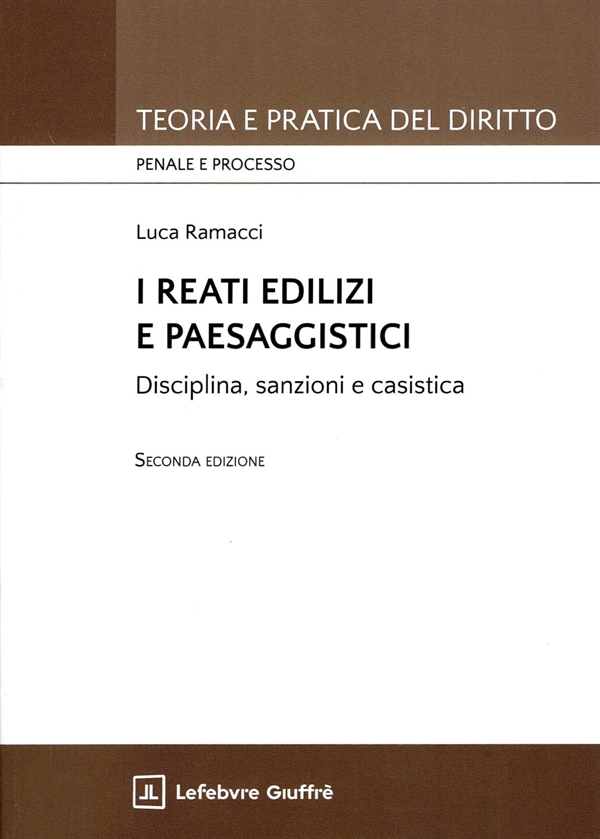Cass. civ. S.U. n. 20381 del 21 luglio 2025
Cass. civ. S.U. n. 20381 del 21 luglio 2025
Pres. Cirillo Est. Mercolino Ric. Greenpeace ed altri c. Eni spa ed altri
Ambiente in genere.Giurisdizione in tema di azioni climatiche strategiche
Regolamento di giurisdizione presentato da Greenpeace O.N.L.U.S. e altre parti relativamente a questione concernente responsabilità legate al cambiamento climatico (segnalazione Avv. M. Ceruti)
FATTI DI CAUSA
1. La GREENPEACE O.N.L.U.S. e la Recommon A.p.s., associazioni ambientaliste di levatura nazionale ed internazionale, nonché Francesca Zazzera, Ninetto Martucci, Rachele Caravaglios, Noa Helffer, Marco Lion, Patrizia Bar-telle, Giorgio Crepaldi, Lucia Pozzato, Vanni Destro, Giovanna Deppi, Lucia Ruffato e Maria Antonietta D'Antonio cittadini residenti in aree del territorio nazionale particolarmente esposte al cambiamento climatico, hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Roma l'ENI Spa, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la CASSA DEPOSITI E PRESTITI Spa, per sentirne accertare l'inottemperanza agli obblighi inerenti al raggiungimento degli obiettivi climatici internazionalmente riconosciuti e la responsabilità per i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati dal cambiamento climatico, con la conseguente condanna dell'ENI alla limitazione del volume annuo aggregato delle emissioni di CO2 in atmosfera derivante dalle attività industriali e commerciali e dai prodotti per il trasporto dell'energia da essa venduti, e del Ministero e della Cassa DDPP all'adozione di una policy operativa che definisca e monitori gli obiettivi climatici di cui l'ENI dovrebbe dotarsi, nonché, in subordine, con la condanna dei convenuti all'adozione delle iniziative necessarie a garantire il rispetto degli scenari elaborati dalla comunità scientifica internazionale per mantenere l'aumento della temperatura entro 1,5 gradi.
Premesso che il cambiamento climatico antropogenico incide negativamente sui diritti umani individuali e collettivi, provocando conseguenze che vanno da un peggioramento della qualità della vita fino all'impossibilità di vivere nei rispettivi luoghi di residenza, gli attori hanno richiamato a) la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti climatici, entrata in vigore il 21 marzo 1994, avente come obiettivo generale di prevenire i cambiamenti climatici pericolosi di origine umana, mediante la stabilizzazione delle concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera, b) l'Accordo di Copenaghen del 2009, che ha fissato al di sotto di 2 C l'aumento globale della temperatura necessario per raggiungere il predetto obiettivo, c) gli Accordi di Cancun del 2016, che hanno riconosciuto la necessità di profondi tagli alle emissioni globali di gas serra, d) la risoluzione 10/4 del 2009 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, che ha riconosciuto che il cambiamento climatico costituisce una minaccia per i diritti umani per coloro che si trovano in posizioni vulnerabili, e) l'Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015, ratificato con legge 4 novembre 2016, n. 204, avente l'obiettivo di mantenere il riscaldamento globale ben al di sotto di 2 C e di limitarlo preferibilmente a 1,5 C, in modo da ridurre significativamente i rischi e gl'impatti dei cambiamenti climatici, f) gl'impegni assunti dagli Stati nelle Conferenze delle Parti di Glasgow e Sharm el Sheik, g) il rapporto di sintesi AR6 dell'Intergovernmental Panel on Climate Change del marzo 2023, che riassume le migliori conoscenze scientifiche attualmente disponibili sui cambiamenti climatici, e dal quale emerge la consapevolezza della comunità internazionale in ordine alla necessità di compiere ogni sforzo per limitare l'aumento della temperatura al di sotto di 1,5 C e per ridurre l'uso complessivo di combustibili fossili.
Secondo gli attori, il riscaldamento globale, derivante dall'incremento della concentrazione di CO2 nell'atmosfera, produce gravi conseguenze sugli ecosistemi e sulle comunità umane dell'intero pianeta, determinando l'interruzione della produzione alimentare e dell'approvvigionamento idrico, danni alle infrastrutture ed agli insediamenti e il deterioramento della vita, della salute e del benessere degli esseri viventi, che, traducendosi a loro volta in un incremento dei flussi migratori e in un'amplificazione delle disuguaglianze tra regioni ed ambienti socioeconomici o tra le generazioni, possono costituire fonti di conflitto o fattori d'inasprimento dei conflitti già in atto. Consapevoli di tali effetti, le compagnie petrolifere hanno dapprima promosso campagne di disinformazione di massa, volte ad ostacolarne il riconoscimento da parte dell'opinione pubblica, ed in seguito adottato comportamenti volti a simulare un impegno nel contrasto del cambiamento climatico, mediante la promozione della ricerca in materia di energia nucleare e di progetti di compensazione delle emissioni inquinanti. Tra le stesse, l'ENI, presente in sessantadue Paesi ed attiva nell'esplorazione, nello sviluppo e nell'estrazione di petrolio e gas naturale in trentasette Paesi, anche attraverso le società da essa controllate, nonché responsabile dello 0,6% delle emissioni cumulate industriali globali e di emissioni di gas serra assolute pari a 419.000.000 di tonnellate di CO2 nell'anno 2022, pur essendosi vincolata nel suo codice etico a rispettare i diritti umani e gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, ha adottato una strategia non in linea con le indicazioni della comunità scientifica e dell'IPCC, dotandosi di un piano di decarbonizzazione al 2050 che, oltre a non prevedere il totale abbandono dei combustibili fossili, contempla una riduzione delle emissioni di appena il 35% entro il 2030, cui corrisponde però, nel breve periodo, un incremento nella produzione di idrocarburi.
Ciò posto, gli attori hanno precisato di essere legittimati ad agire, ai sensi degli artt. 2043,2050 e 2051 cod. civ. e degli artt. 300 e 313, comma settimo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nei confronti dell'ENI, in qualità di responsabile delle emissioni, per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, distinti da quello ambientale, cagionati dalla lesione dei diritti umani tutelati dagli artt. 2,9,32 e 41 Cost., dagli artt. 2 e 8 della CEDU e dagli artt. 2 e 7 della CDFUE. Hanno sostenuto, in proposito, l'immediata applicabilità delle fonti internazionali in materia di cambiamento climatico, in quanto assimilabili al diritto eurounitario, richiamando inoltre i principi dello sviluppo sostenibile e dell'azione ambientale, sanciti dagli artt. 3ter e 3quater del D.Lgs. n. 152 del 2006, che, imponendo espressamente un dovere di tutela ambientale non solo ai soggetti pubblici, ma anche alle persone giuridiche private, comportano la piena giustiziabilità dei diritti dei singoli e delle associazioni nei confronti di azioni imprenditoriali condotte in modo difforme da tali principi e suscettibili di cagionare danni ambientali/climatici, al fine di ottenere l'imposizione di strategie aziendali volte a garantire uno sviluppo sostenibile ed a preservare la salute delle persone e l'ambiente (ivi compresi gli ecosistemi e la biodiversità) dalle conseguenze pregiudizievoli del cambiamento climatico. Hanno affermato infine la corresponsabilità del Ministero e della Cassa DDPP, in qualità di azionisti di controllo dell'ENI, che ne hanno reso possibile l'attività inquinante e che ne traggono un utile, in quanto titolari di quote sufficienti a consentire loro l'esercizio di un'influenza dominante nell'assemblea della società, la nomina di parte dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e dell'amministratore delegato, nonché di parte dei componenti del Comitato sostenibilità e scenari e del Comitato controllo e rischi.
1.1. Si è costituita l'ENI, ed ha eccepito a) la non giustiziabilità della pretesa azionata, in quanto incompatibile con il proprio diritto di determinare liberamente la propria politica aziendale, tutelata dall'art. 41 Cost., b) il difetto assoluto di giurisdizione, avendo la domanda ad oggetto l'adozione di misure che presuppongono valutazioni di natura politicolegislativa, spettanti al Parlamento ed al Governo, c) il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana, avendo gli attori allegato, a sostegno della domanda, anche condotte tenute all'estero ed attribuibili a società straniere distinte ed autonome rispetto ad essa convenuta, d) il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, spettando in via esclusiva al Ministro dell'ambiente la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno ambientale, nonché la competenza ad avviare il procedimento amministrativo volto ad accertarne la sussistenza, e potendo i privati far valere soltanto il danno c.d. residuale, cioè quello direttamente subìto in conseguenza del danno ambientale, e) la carenza di legittimazione ed interesse degli attori, in quanto non portatori di un interesse concreto, diretto e specifico, ma di un generico interesse alla tutela dell'ambiente, del clima e delle risorse naturali, f) la prescrizione del diritto al risarcimento, relativamente ai danni risalenti ad epoca precedente al quinquennio anteriore alla proposizione della domanda, g) l'insussistenza di una condotta illecita, svolgendo essa convenuta una legittima attività d'impresa, avente rilevanza strategica nel settore energetico, e non essendo configurabile una violazione né degli artt. 9 e 41 Cost., non suscettibili di applicazione diretta nei suoi confronti, né degli artt. 2 e 8 della CEDU, applicabili agli Stati aderenti alla Convenzione, né delle regole di soft law, aventi carattere meramente programmatico.
1.2. Si è costituito inoltre il Ministero, ed ha eccepito anch'esso il difetto assoluto di giurisdizione, sostenendo che la pretesa azionata comporterebbe un'invasione della sfera riservata al legislatore, cui l'Accordo di Parigi demanda la definizione delle modalità concrete per la sua esecuzione, anche in riferimento all'autorità giudiziaria competente a valutarne il rispetto da parte dei soggetti pubblici e privati residenti in Italia, vincolando gli Stati soltanto al perseguimento di un risultato comune. Ha aggiunto che un sindacato sulla attività dell’ENI si tradurrebbe in una valutazione dell'opportunità delle sue scelte imprenditoriali, sotto il profilo dell'impatto sul fenomeno del cambiamento climatico, che esula dalle competenze del potere giurisdizionale. Ha eccepito infine il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana, in riferimento alle condotte tenute dal ENI in altri Stati, ai sensi dell'art. 4, par. 1, del Regolamento Ue n. 864/2007 dell'11 luglio 2007 o all'art. 7 del Regolamento UE n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012.
1.3. Si è costituita infine la Cassa DDPP, che ha eccepito a sua volta a) il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo la controversia ad oggetto condotte ascrivibili all'ENI, destinataria esclusiva dei provvedimenti richiesti, b) l'indeterminatezza dell'oggetto e del titolo della domanda proposta nei suoi confronti, non avendo gli attori allegato specifiche condotte ad essa ascrivibili, c) il difetto assoluto di giurisdizione, avendo la controversia ad oggetto questioni di natura politico legislativa estranee all'ambito del potere giurisdizionale e spettanti alla competenza del Parlamento e dell'Esecutivo, ai sensi dello art. 57bis del D.Lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 35 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, d) il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana in ordine alle condotte denunciate, in quanto poste in essere, almeno in parte, da società del Gruppo ENI operanti in altri Stati, e) il difetto di legittimazione degli attori, avendo gli stessi agito a tutela di un interesse collettivo, senza allegare i danni individualmente subìti, f) la carenza di interesse degli attori, avendo gli stessi invocato un provvedimento idoneo a produrre effetti soltanto per il futuro, mediante l'allegazione di un pregiudizio meramente ipotetico e potenziale, f) l'impossibilità giuridica della tutela richiesta, inidonea a garantire il contenimento dell'aumento della temperatura entro il limite di 1,5 C, e comunque implicante una penetrante ingerenza nell'attività d'impresa dell'ENI, in assenza di qualsiasi fondamento normativo, g) la prescrizione della pretesa azionata, avente ad oggetto danni verificatisi in epoca precedente al quinquennio anteriore alla proposizione della domanda, h) l'infondatezza della domanda proposta nei confronti di essa convenuta, non responsabile delle condotte autonomamente tenute dall'ENI, le cui scelte gestionali sono rimesse esclusivamente al consiglio di amministrazione, e non in grado di condizionarle, in virtù della mera partecipazione al capitale della stessa, i) l'insussistenza di una condotta illecita dell'ENI, la cui strategia non contrasta né con gli obiettivi fissati dall'Accordo di Parigi, aventi efficacia vincolante soltanto per gli Stati, né con il diritto alla vita o alla riservatezza degli attori, né con gli artt. 9 e 41 Cost., anch'essi vincolanti soltanto per lo Stato, l) la mancata allegazione di un danno conseguenza concreto ed attuale, m) l'inidoneità del provvedimento invocato a riparare i danni subìti dagli attori ed a ripristinare lo status quo ante, n) l'insussistenza dei presupposti per la concessione di una misura coercitiva indiretta, ai sensi dell'art. 614bis cod. proc. civ.
2. Con atto notificato il 10 giugno 2024, la Greenpeace, la Recommon E.t.s. (già Recommon A.p.s.) la la Zazzera, il Lion, la Bartelle, il Crepaldi, la Pozzato, il Destro e la Ruffato hanno proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, illustrato anche con memoria, chiedendo la dichiarazione della spettanza della giurisdizione al Giudice adito, ed in subordine la proposizione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 204 del 2016, per contrasto con gli artt. 2,9,24,41 e 117 Cost., nella parte in cui non consente di immettere nell'ordinamento statale tutte le norme necessarie a rendere immediatamente applicabili le disposizioni dell'Accordo di Parigi nei confronti sia dei soggetti pubblici che dei cittadini e delle imprese. Hanno resistito con controricorsi, anch'essi illustrati con memorie, l'ENI, il Ministero e la Cassa DDPP. Hanno spiegato intervento nel procedimento la Deppi, il Martucci, la Caravaglios, la Helffer e la D'Antonio, i quali hanno aderito alle richieste degli altri ricorrenti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente procedimento da altri omessi, i quali, pur non avendo proposto il ricorso, non possono considerarsi terzi rispetto al regolamento di giurisdizione, vantando un indubbio interesse alla soluzione della questione sollevata dai ricorrenti, unitamente ai quali hanno agito dinanzi al Tribunale di Roma, ed assumendo quindi la posizione di litisconsorti necessari, nei confronti dei quali, in mancanza dell'intervento, avrebbe dovuto essere disposta l'integrazione del contraddittorio.
Com'è noto, infatti, il regolamento di giurisdizione non costituisce un procedimento autonomo rispetto al giudizio di merito, avendo carattere meramente strumentale ed incidentale rispetto al procedimento principale, con la conseguenza che sono legittimati a parteciparvi tutti e solo i soggetti che abbiano assunto formalmente la qualità di parti nel giudizio a quo (cfr. Cass., Sez. Un., 13/01/2005, n. 463; 9/08/2000, n. 558; 10/12/1993, n. 12167); essendo volto a rimuovere anticipatamente eventuali dubbi in ordine all'individuazione del giudice cui spetta la giurisdizione in ordine alla controversia, esso non consente d'altronde la proposizione di questioni diverse, quali quelle riguardanti la legittimazione di un terzo a partecipare al giudizio a quo e la ricorrenza dei presupposti e delle condizioni per un suo intervento: in linea di principio, deve pertanto negarsi l'ammissibilità dell'intervento di terzi formalmente estranei al giudizio di merito, anche nel caso in cui gli stessi possano vantare un interesse alla soluzione della questione di giurisdizione, per il fatto di essere parti in analoghi giudizi, giacché in questi ultimi la decisione adottata da questa Corte è destinata ad assumere il valore di mero precedente (cfr. Cass., Sez. Un., 31/05/2016, n. 11387; 21/10/2005, n. 20340; 22/11/ 1984, n. 5992). Non può tuttavia escludersi la legittimazione ad intervenire di quei soggetti che, pur essendo parti (anche non costituite) nel giudizio principale, si siano astenuti dal promuovere il regolamento di giurisdizione, essendo configurabile un litisconsorzio necessario processuale tra tutte le parti (cfr. Cass., Sez. Un., 26/03/2014, n. 7179; 9/12/2004, n. 22990), il quale impone, in caso di mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di alcune di esse, l'applicazione dell'art. 331 cod. proc. civ., anche perché la decisione sulla giurisdizione è destinata ad acquistare efficacia di giudicato anche nei loro confronti.
2. Premesso che l'istanza di regolamento trova giustificazione nel proprio interesse ad ottenere una pronuncia immediata e definitiva sulla giurisdizione, alla luce delle eccezioni proposte al riguardo dai convenuti e dell'intervenuta dichiarazione d'inammissibilità di un'analoga domanda proposta da altri soggetti dinanzi al medesimo Tribunale, gli attori insistono sulla proponibilità della domanda, in quanto avente ad oggetto il risarcimento dei danni per lesione di diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, dalla CEDU e dalla CDFUE, sostenendo comunque che il regolamento di giurisdizione è ammissibile anche nel caso in cui la domanda risulti improponibile, per avere ad oggetto un diritto non previsto dall'ordinamento, o strumentale, in quanto diretta a perseguire finalità diverse da quelle tipiche, poiché ciò non elide il profilo sostanziale della domanda proposta, indipendentemente dalla sua fondatezza nel merito.
3. Ciò posto, ribadiscono la giustiziabilità della pretesa azionata, richiamando la sentenza della Corte EDU del 9 aprile 2024, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz c. Suisse, che, nel dichiarare ammissibile la domanda di un'associazione di diritto svizzero e di alcuni cittadini, volta a far valere omissioni delle autorità statali nel settore dei cambiamenti climatici, ha riconosciuto la complementarità dell'intervento giudiziario rispetto ai processi democratici, affermando che, pur non potendo sostituire l'azione del Potere legislativo ed esecutivo, il compito della magistratura consiste nel garantire il rispetto dei requisiti legali.
Precisato che vi è ormai certezza in ordine all'esistenza di un cambiamento climatico di origine antropica, che rappresenta una grave minaccia per il godimento dei diritti umani e richiede l'adozione di misure urgenti che coinvolgono sia il settore pubblico che quello privato, al fine di limitare l'aumento della temperatura a 1,5 C, gli attori evidenziano di aver invocato un intervento tanto inibitorio quanto risarcitorio, mediante l'allegazione di condotte illecite sanzionate dagli artt. 2043,2050 e 2051 cod. civ., degli artt. 2 e 8 della CEDU e degli artt. 2 e 7 della CDFUE. Aggiungono che la domanda trova fondamento nelle norme dell'Accordo di Parigi, il cui recepimento, per effetto dell'ordine di esecuzione, ha determinato l'introduzione nell'ordinamento interno di tutte le norme indispensabili a darvi attuazione, ed in particolare del principio di limitazione dell'aumento della temperatura a non più di 1,5 C, dell'obbligo d'intraprendere rapide riduzioni in linea con le migliori conoscenze scientifiche e della progressività della riduzione della produzione di gas climalteranti, con il conseguente adattamento dell'ordinamento interno a quello pattizio, attraverso la creazione di norme non scritte, necessarie ad adempiere gli obblighi assunti dallo Stato a livello internazionale e vincolanti sia per lo Stato che per i soggetti pubblici e privati, che spetta all'interprete individuare ed applicare.
Negano che la pretesa azionata comporti un'invasione della sfera politica, osservando che la nozione di atto politico è di stretta interpretazione, giacché la giustiziabilità degli atti del pubblico potere costituisce un principio fondante della Costituzione, destinato a trovare applicazione anche nel caso in cui, come nella specie, un'attività pubblica o privata, pur non vincolata da norme specifiche, sia contestata mediante la richiesta di un accertamento della responsabilità civile per fatti illeciti lesivi di diritti fondamentali. Ribadiscono che in ordine a tale pretesa, riguardante diritti soggettivi costituzionalmente protetti, non è configurabile un difetto assoluto di giurisdizione, il quale si riferisce all'invasione della sfera di attribuzioni di altri poteri dello Stato o di altri ordinamenti dotati di autonomia, in controversie coinvolgenti attribuzioni pubbliche neppure astrattamente suscettibili di dar luogo a un intervento del giudice.
4. In ordine alla limitazione della libertà di determinazione della politica aziendale, gli attori osservano che l'art. 9, terzo comma, Cost. prevede una clausola di responsabilità intergenerazionale in funzione della tutela ambientale, che si impone a tutti i poteri pubblici, ivi compreso quello giurisdizionale, consentendo un sindacato sul rispetto dell'obbligazione climatica, che può essere esercitato anche nei confronti delle imprese pubbliche e private, cui si rivolge anche la nuova formulazione dell'art. 41 Cost., secondo cui l'iniziativa economica non può svolgersi in modo da recare danno alla salute ed all'ambiente. Richiamano in proposito anche gli artt. 3-ter e 3-quater del D.Lgs. n. 152 del 2006 e gli artt. 2 e 9 della Convenzione di Aarhus, ratificata con legge 16 marzo 2001, n. 108, che prevedono la piena giustiziabilità dei diritti dei singoli e delle associazioni nei confronti di attività economico imprenditoriali condotte in modo difforme dai principi dell'azione ambientale.
Aggiungono che ENI si è vincolata al rispetto dei diritti fondamentali attraverso il suo codice etico, rilevando comunque che la loro legittimazione ad agire per l'accertamento della sua responsabilità trova fondamento nella violazione dell'art. 8 della CEDU, qualificabile come fatto illecito generatore di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. Precisano che l'art. 8 cit. opera sia nei rapporti tra privati che nei confronti delle autorità statali, a carico delle quali sono configurabili non solo obblighi negativi, ma anche obblighi positivi, comprendenti anche quello di applicare e mantenere un quadro giuridico adeguato che offra protezione contro gli atti di violenza commessi da privati, sicché in materia ambientale la norma è applicabile sia nel caso in cui l'inquinamento sia causato direttamente dallo Stato, sia nel caso in cui lo stesso si sia dimostrato incapace di regolamentare correttamente l'industria privata. Il rispetto dei predetti obblighi impone alle autorità nazionali, ivi compresi i tribunali, di garantire ai cittadini e alle associazioni il diritto di accesso alla giustizia, previsto dall'art. 6 della CEDU, il quale dev'essere pratico ed effettivo, e comprende non solo il diritto di proporre un ricorso, ma anche quello di ottenere una decisione della controversia da parte di un giudice.
5. Quanto infine al difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana, gli attori richiamano gli artt. 4, par. 1, e 7, n. 2 del Regolamento UE n. 1215/ 2012, secondo cui le persone possono essere convenute dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui domiciliano, ed in materia di illecito civile dinanzi all'autorità giurisdizionale del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso, precisando che tale luogo può essere identificato sia in quello in cui si è concretizzato il danno sia in quello in cui si è verificato l'evento generatore. Affermano che nella specie il danno si è certamente concretizzato in Italia, indipendentemente dalla circostanza che l'evento generatore si sia verificato all'estero, richiamando anche la giurisprudenza eurounitaria, secondo cui la giurisdizione si radica nel luogo in cui il fatto illecito ha prodotto i suoi effetti dannosi nei confronti della vittima, ed aggiungendo che a conclusioni diverse non potrebbe pervenirsi neppure in base all'art. 4, par. 1, del Regolamento UE n. 864/2007 dell'11 luglio 2007, che in materia di obbligazioni extracontrattuali dichiara applicabile la legge del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese in cui è avvenuto il fatto generatore e da quello in cui si verificano le conseguenze indirette del fatto.
In proposito, sostengono anche l'irrilevanza della riconducibilità delle emissioni a società le cui azioni non sono detenute dall'ENI, osservando che le emissioni delle società di combustibili fossili devono essere valutate sulla base della teoria della cd. corporate personhood, secondo cui il ruolo strategico della capogruppo nella definizione delle politiche per l'intero gruppo comporta la sua responsabilità per le emissioni ad effetto serra complessive delle sue attività e dei suoi prodotti, e precisando comunque che le decisioni strategiche che contribuiscono all'emergenza climatica, con conseguente violazione dei diritti umani, non sono imputabili alle società del Gruppo ENI, ma alla capogruppo, la quale adotta dichiaratamente politiche aziendali contrarie alla migliore scienza disponibile e agli obiettivi climatici fissati dalla comunità internazionale.
6. Tanto premesso, si osserva innanzitutto che, come ripetutamente affermato da queste Sezioni Unite, l'ammissibilità del regolamento di giurisdizione non può essere esclusa in virtù della mera circostanza che l'iniziativa sia stata assunta dalla medesima parte che ha promosso il giudizio di merito, dovendosi ritenere configurabile anche in tal caso, ove siano insorti ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito, un interesse concreto ed attuale alla risoluzione della questione, in via definitiva ed immodificabile, da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, in modo tale da evitare che una decisione adottata al riguardo dal giudice di merito possa subire successive modifiche nel corso del giudizio, ritardando la definizione della controversia (cfr. Cass., Sez. Un., 12/05/2022, n. 15122; 26/02/2021, n. 5513; 18/12/2018, n. 32727).
A maggior ragione, poi, l'utilizzazione del predetto strumento deve ritenersi giustificata nel caso in esame, in considerazione della novità delle questioni (inerenti non solo alla giurisdizione, ma anche al merito) suscitate dalla domanda proposta dagli attori, relativamente alle quali non si riscontrano precedenti nella giurisprudenza di legittimità, laddove in quella di merito l'unica pronuncia in qualche modo pertinente è costituita da una sentenza del medesimo Tribunale adìto dagli attori, intervenuta nel corso del presente procedimento principale, che, in riferimento ad una controversia analoga (ma non identica), ha dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione, escludendo che la domanda fosse conoscibile da alcun giudice ordinario o speciale, in ragione della mancanza dell'ordinamento di una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio (cfr. Trib. Roma, 26/02/2024, n. 3552). A ciò si aggiungano le plurime eccezioni d'inammissibilità sollevate dalle difese dei convenuti, le quali hanno alimentato le incertezze in ordine alla spettanza al Giudice ordinario del potere di statuire sulla pretesa avanzata dagli attori, contestandone la giustiziabilità e prospettando la possibile invasione da parte del Giudice della sfera riservata al Parlamento ed all'Esecutivo, nonché la riconducibilità, almeno parziale, della controversia alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana.
7. La natura processuale della questione, nella cui soluzione questa Corte è chiamata ad operare come giudice anche del fatto, consente di procedere all'esame diretto degli atti di causa, e segnatamente dell'atto di citazione, dal quale si evince che la domanda proposta dinanzi al Tribunale di Roma ha ad oggetto a) l'accertamento dell'inottemperanza dell'ENI, del Ministero e della Cassa DDPP al raggiungimento degli obiettivi climatici internazionalmente riconosciuti, volti a garantire il contenimento dell'incremento della temperatura entro 1,5 C, b) la conseguente dichiarazione della responsabilità solidale dei convenuti per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti e subendi dagli attori in conseguenza del cambiamento climatico, per violazione del combinato disposto degli artt. 2 e 8 della CEDU e degli artt. 2043, 2050 e 2051 cod. civ., c) la condanna dell'ENI a limitare il volume annuo aggregato di tutte le emissioni di CO2 in atmosfera, in misura tale che a fine 2030 lo stesso venga ridotto di almeno il 45% rispetto ai livelli del 2020, ovvero in altra misura che garantisca il rispetto degli scenari elaborati dalla comunità scientifica internazionale, con la fissazione di una somma di denaro da pagarsi in caso d'inottemperanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento, d) la condanna del Ministero e della Cassa DDPP, ai sensi dell'art. 2058 cod. civ. e dell'art. 614bis cod. proc. civ., ad adottare una policy operativa che definisca e monitori gli obiettivi climatici di cui l'ENI dovrebbe dotarsi, con la fissazione di una somma di denaro da pagarsi in caso d'inottemperanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento, e) in subordine, la condanna dei convenuti alla adozione di ogni iniziativa necessaria a garantire il rispetto degli scenari elaborati dalla comunità scientifica internazionale per contenere l'aumento della temperatura entro 1,5 C.
Lo specifico riferimento agli artt. 2043,2050,2051 e 2058 cod. civ. rende evidente che attraverso la domanda in esame gli attori hanno inteso far valere una responsabilità extracontrattuale dei convenuti per i danni cagionati dall'inottemperanza dell'ENI al dovere di adottare, nell'esercizio dell'attività industriale e commerciale svolta sia direttamente che attraverso le società da essa partecipate, le misure necessarie per ridurre il volume di emissioni di CO2 in atmosfera, in misura tale da consentire di raggiungere l'obiettivo fissato dagli accordi internazionali in tema di contrasto del cambiamento climatico, consistente nella limitazione dell'incremento della temperatura globale entro il limite dell'1,5 C rispetto ai livelli preindustriali. Il fondamento di tale responsabilità viene individuato nella violazione degli obblighi derivanti dai predetti accordi, e segnatamente dall'Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015, ritenuto vincolante anche nei confronti dei privati, per effetto dell'ordine di esecuzione impartito con legge n. 104 del 2016, e nella conseguente lesione del diritto alla vita ed al rispetto della vita privata e familiare, previsto dagli artt. 2 e 8 della CEDU, ritenuti a loro volta produttivi di obblighi positivi e negativi a carico non solo degli Stati aderenti alla Convenzione, ma anche dei privati, nonché nella violazione degli art. 9, terzo comma, e 41, secondo e terzo comma, Cost., come modificati dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, che, nel sancire il principio della tutela dell'ambiente, precisano che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno allo stesso o alla salute, prevedendo inoltre che la stessa debba essere indirizzata e coordinata a fini ambientali.
7.1. La domanda degli attori s'inserisce nel noto filone, da tempo diffuso a livello internazionale e da poco approdato anche in Italia, della c.d. climate change litigation, nell'ambito del quale si caratterizza, rispetto ad altre analoghe iniziative, per il fatto di avere come destinatari una società privata (quale viene ormai considerata a tutti gli effetti l'ENI, a seguito della trasformazione avviata con l'art. 15 del D.L. 11 luglio 1992, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359), ed altri due soggetti, uno dei quali è un'Amministrazione dello Stato, mentre l'altro, pur a seguito della trasformazione in società per azioni (prevista dall'art. 5 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), continua ad avere una natura piuttosto discussa, ritenendosi ancora da parte di alcuni che esso costituisca, sotto il profilo sostanziale, un'amministrazione pubblica ad ordinamento autonomo (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 12/02/2007, n. 550; Cons. Stato, Sez., Comm. Spec., 7/11/2012, n. 8178). Al di là di tali incertezze, peraltro, ciò che appare dirimente, ai fini della soluzione della questione in esame, è la circostanza che nel giudizio di merito tanto il Ministero quanto la Cassa sono stati convenuti non già nella veste di amministrazioni pubbliche, responsabili della mancata adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza necessari per il conseguimento degli obiettivi climatici fissati dalle fonti indicate, ma in quella di azionisti di riferimento dell'ENI, cui gli attori hanno addebitato l'omesso o inadeguato esercizio delle facoltà loro spettanti in qualità di soci, al fine d'indirizzare l'attività della società partecipata verso il rispetto dei predetti obiettivi.
Nell'altro giudizio introdotto dinanzi al Tribunale di Roma, e conclusosi con la dichiarazione del difetto assoluto di giurisdizione, la domanda era stata invece proposta nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed aveva ad oggetto l'accertamento della responsabilità extracontrattuale o da contatto sociale qualificato dello Stato per inadempimento dei doveri (aventi le medesime fonti indicate dagli attori) d'intervento e di protezione contro gli effetti degenerativi dell'emergenza climatica, a tutela dei diritti fondamentali della persona, con la richiesta di condanna della convenuta all'adozione di ogni necessaria iniziativa per l'abbattimento delle emissioni nazionali artificiali di CO2 nella misura ed entro i termini indicati, ed in particolare a conformare il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) alle disposizioni idonee a realizzare il predetto obiettivo. Tale iniziativa rispecchiava, sotto il profilo soggettivo, un modello adottato in altri Paesi, nei quali l'azione era rivolta contro lo Stato legislatore o lo Stato amministrazione, al medesimo fine di ottenerne direttamente la condanna all'adozione di misure limitative delle emissioni climalteranti (cfr. nei Paesi Bassi, Gerechtshof Den Haag, 9/ 10/2018, Stichting Urgenda v. Netherlanden) oppure al diverso fine di ottenere la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di atti normativi in materia ambientale recanti misure inadeguate al raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dalle fonti internazionali (cfr. in Germania, Bundesverfassungsgericht, 24/03/2021, Neubauer et al. v. Deutschland) o la fissazione di termini per l'adozione di misure volte a ridurre le emissioni di gas serra nell'atmosfera (cfr. in Francia, Tribunal administratif de Paris, 3/02/2021, Notre Affaire à Tous et al. c. France).
A differenza delle predette ipotesi, la fattispecie in esame si configura come una comune azione risarcitoria, fondata sull'allegazione di un danno, consistente nella lesione del diritto alla vita ed al rispetto della vita privata e famigliare, la cui ingiustizia viene predicata in virtù del richiamo da un lato agli obblighi positivi e negativi derivanti dagli artt. 2 e 8 della CEDU, e dall'altro ai doveri d'intervento previsti dalle fonti internazionali in tema di contrasto del cambiamento climatico, obblighi e doveri dei quali viene affermata l'efficacia vincolante non solo a carico degli Stati che hanno aderito alla CEDU ed agli Accordi richiamati, ma anche a carico dei singoli soggetti pubblici e privati, segnatamente di quelli operanti direttamente o a mezzo di altri soggetti da loro partecipati nel settore della produzione, del trasporto e della commercializzazione di combustibili fossili, al quale la c.d. attribution science, cui si deve l'approfondimento di tali fenomeni, imputa il maggior contributo alle emissioni di CO2 nell'atmosfera, responsabili dell'incremento della temperatura globale. In tal senso dev'essere intesa anche l'invocazione degli artt. 2050 e 2051 cod. civ., ritenuti idonei a fondare una responsabilità oggettiva o presunta dei predetti soggetti, in ragione dell'intrinseca pericolosità dell'attività svolta, che impone a chi la esercita di adottare tutte le misure idonee evitare che la stessa arrechi danno a terzi, o comunque del dinamismo dannoso connesso alla natura dei materiali trattati, che implica un dovere di custodia e controllo a carico di chi ne abbia la disponibilità. Sulla base di tali allegazioni in fatto ed in diritto, viene poi chiesto l'accertamento della responsabilità solidale dell'ENI, in quanto esercente direttamente la predetta attività industriale e commerciale, e degli altri due convenuti, in quanto titolari di una posizione di controllo (inteso in senso privatistico) che consente loro d'intervenire indirettamente su tale attività, con la condanna degli stessi ad adottare le misure idonee a ridurre le emissioni entro i limiti previsti dalle fonti internazionali indicate.
Non può quindi essere esteso alla fattispecie in esame il ragionamento seguito dal Tribunale di Roma in riferimento all'azione proposta nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo cui "la domanda risarcitoria ricollegata alla titolarità di un diritto soggettivo (e come tale considerata scrutinabile dal giudice ordinario), per come formulata, è diretta in concreto a chiedere, quale petitum sostanziale, al giudice un sindacato sulle modalità di esercizio delle potestà statali previste dalla Costituzione", giacché l'accertamento dei presupposti dell'illecito "non può prescindere da un sindacato sul quando e sul quomodo dell'esercizio di potestà pubbliche (che pure tiene conto delle indicazioni provenienti dalla scienza) e la pretesa risarcitoria è solo la conseguenza eventuale di tale accertamento"; né appare pertinente l'affermazione contenuta nella medesima sentenza, secondo cui "l'interesse di cui si invoca la tutela risarcitoria ex artt. 2043 e 2051 cod. civ. non rientra nel novero degli interessi soggettivi giuridicamente tutelati, in quanto le decisioni relative alle modalità e ai tempi di gestione del fenomeno del cambiamento climatico antropogenico - che comportano valutazioni discrezionali di ordine socioeconomico e in termini di costi-benefici nei più vari settori della vita della collettività umana - rientrano nella sfera di attribuzione degli organi politici e non sono sanzionabili nell'odierno giudizio". Nel caso di specie, gli attori non fanno valere una responsabilità dello Stato legislatore per "atti, provvedimenti e comportamenti manifestamente espressivi della funzione di indirizzo politico, consistente nella determinazione delle linee fondamentali di sviluppo dell'ordinamento e della politica dello Stato nella delicata e complessa questione, indubbiamente emergenziale, del cambiamento climatico antropogenico", ma una responsabilità dei convenuti, quali soggetti operanti direttamente o indirettamente nel settore della produzione e distribuzione dei combustibili fossili, per la mancata adozione delle misure necessarie a ridurre le emissioni climalteranti prodotte dall'attività aziendale: il compito affidato al Giudice consiste pertanto soltanto nel verificare se le fonti internazionali e costituzionali invocate (o altre norme, eventualmente individuate dal Giudice di merito, in ossequio al principio jura novit curia) risultino idonee ad imporre un dovere d'intervento direttamente a carico dei convenuti, tale da fondare una responsabilità extracontrattuale degli stessi, e quindi da giustificarne la condanna al risarcimento in forma specifica, ai sensi dell'art. 2058 cod. civ.
7.2. In quest'ottica, deve innanzitutto escludersi che il sindacato sollecitato al Giudice di merito comporti un'invasione della sfera riservata al potere legislativo, configurabile peraltro, come ripetutamente affermato da queste Sezioni Unite, soltanto quando il giudice ordinario o speciale non abbia applicato una norma esistente, ma una norma da lui stesso creata, in tal modo esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete (cfr. Cass., Sez. Un., 26/12/2024, n. 34499; 9/07/2024, n. 18722; 26/11/2021, n. 36899), e non anche quando sia stato chiamato a pronunciarsi su una comune azione risarcitoria, ancorché fondata sull'allegazione dell'omesso o illegittimo esercizio della potestà legislativa, la quale non dà luogo ad un difetto assoluto di giurisdizione, neppure in relazione alla natura politica dello atto legislativo, ove sia stata dedotta la sola lesività della disciplina che ne è derivata (cfr. Cass., Sez. Un., 24/11/2021, n. 36373).
Non può essere poi fatto valere in questa sede il difetto di giustiziabilità della pretesa azionata, che, in quanto configurabile soltanto nell'ipotesi in cui si sostenga l'impossibilità d'individuare nell'ordinamento una norma astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio, non dà luogo ad una questione di giurisdizione, proponibile con lo strumento di cui all'art. 41 cod. proc. civ., ma ad una questione di merito, la cui soluzione è demandata al giudice adìto (cfr. Cass., Sez. Un., 27/03/2023, n. 8675; 16/01/2015, n. 647; 4/08/2010, n. 18052).
Nella specie, l'esame di detta questione presuppone, tra l'altro, la verifica della vincolatività, nei confronti dei singoli soggetti pubblici o privati, degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali invocati e dalla CEDU, anche alla luce dell'avvenuto recepimento degli artt. 2 e 8 di tale Convenzione ad opera degli artt. 2 e 7 della CDFUE, nonché della recente pronuncia della Corte EDU, che, in considerazione della relazione causale esistente tra le azioni e/o le omissioni dello Stato in ordine all'adozione di misure idonee a impedire il surriscaldamento globale e i danni o il rischio di danni per i singoli individui, ha ravvisato nella mancata adozione delle predette misure da parte delle autorità statali una violazione dell'art. 8 cit., ritenendo che il diritto alla vita ed al rispetto della vita privata e familiare includa il diritto degli individui a una protezione efficace contro i gravi effetti del cambiamento climatico sulla loro vita, salute, benessere e qualità della vita (cfr. Corte EDU, sent. 9/04/2024, Verein Klimaseniorinnen Schweitz et al. c. Suisse). Trattasi peraltro, anche in questo caso, di una questione che esula dall'ambito oggettivo del regolamento di giurisdizione, il quale verte esclusivamente sull'individuazione del giudice cui spetta la competenza giurisdizionale a decidere la controversia, con la conseguente improponibilità, in questa sede, di questioni di compatibilità con il diritto dell'Unione Europea o di questioni di legittimità costituzionale, anche per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., riguardanti il merito della controversia (cfr. Cass., Sez. Un., 14/01/2022, n. 1083).
Per le medesime ragioni, deve escludersi la possibilità di sollevare nel presente procedimento questioni relative alla configurabilità di un danno individuale, attuale e concreto, sulla base delle allegazioni in fatto degli attori, oppure alla legittimazione ad agire delle associazioni attrici, riconosciuta ai fini della proposizione della domanda dinanzi alla Corte EDU sulla base del criterio dello status di vittima, interpretato in modo non rigido e meccanico, ma evolutivo e flessibile, alla luce degl'interessi in gioco e delle condizioni della società contemporanea, e contestata invece nell'ordinamento interno dalla difesa dei controricorrenti, sulla base di un'interpretazione restrittiva dell'art. 310 del D.Lgs. n. 152 del 2006, che, in caso di ritardo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nell'attivazione delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale, riconosce la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno, tra gli altri, alle persone fisiche o giuridiche che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantino un interesse tale da legittimarne la partecipazione al procedimento relativo all'adozione delle predette misure.
8. Per quanto riguarda infine il difetto di giurisdizione del Giudice italiano, eccepito dai convenuti in riferimento alla domanda di risarcimento dei danni cagionati all'estero, si osserva che, come si evince da una lettura complessiva dell'atto di citazione, in verità non del tutto chiaro in proposito, a sostegno di tale pretesa gli attori non hanno inteso far valere la responsabilità delle società controllate dall'ENI aventi la loro sede in altri Paesi ed operanti al di fuori del territorio italiano, ma una responsabilità della società controllante per l'attività svolta dall'intero gruppo ad essa facente capo, ricollegabile alla mancata adozione di una strategia industriale e commerciale idonea a garantire la riduzione delle emissioni di CO2 nell'atmosfera entro i limiti quantitativi e temporali indicati, al fine di contribuire al contenimento dell'incremento della temperatura globale nella misura prevista dalle fonti richiamate. Il danno evento derivante dalla predetta omissione è stato poi individuato nella lesione del diritto alla vita, alla salute e al benessere degli stessi attori, nonché, nella prospettiva intergenerazionale che caratterizza l'iniziativa in esame, al pari delle altre in tema di climate change litigation, nella compromissione dello ambiente in pregiudizio delle generazioni future.
Trattandosi di un fatto dannoso verificatosi, almeno in parte, al di fuori del territorio nazionale, ma imputato ad un soggetto avente la propria sede nel nostro Paese, trova applicazione la disciplina dettata dagli artt. 4, par. 1, e 7 n. 2 del Regolamento UE n. 1215/2012, i quali, nel disporre in linea generale che "le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro", prevedono una competenza speciale ed esclusiva in materia di illeciti civili dolosi o colposi, stabilendo che in tal caso una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta "davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire": quest'ultimo criterio è stato costantemente interpretato da questa Corte, in conformità del consolidato orientamento della giurisprudenza eurounitaria (cfr. Corte di Giustizia UE, 11/01/1990, in causa C220/88, Dumez France e Tracoba; 16/07/2009, in causa C189/08, ZuidChemie BV), nel senso dell'attribuzione all'attore danneggiato di una facoltà di scelta tra due fori speciali, concorrenti ed alternativi, costituiti rispettivamente dal luogo in cui si è concretizzato il danno e da quello in cui si è verificato l'evento generatore di tale danno (cfr. Corte di Giustizia UE, 9/07/2020, in causa C343/19, Verein für Konsumenteninformation; Cass., Sez. Un., 17/ 12/2021, n. 40548; 9/02/2021, n. 3125; 15/12/2020, n. 28675). La giurisprudenza eurounitaria ha peraltro affermato che la regola sulla competenza speciale prevista dall'art. 7 n. 2 del Regolamento n. 1215/2012 dev'essere interpretata in maniera autonoma e restrittiva, costituendo una deroga alla regola generale di cui all'art. 4, par. 1, secondo cui la competenza spetta ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha il suo domicilio (cfr. Corte di Giustizia UE, 12/09/2018, in causa C304/17, Löber): è stato quindi chiarito che l'espressione "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto" non può essere interpretata estensivamente fino al punto da comprendere qualsiasi luogo in cui possano essere avvertite le conseguenze lesive di un fatto che ha causato un danno effettivamente avvenuto in un altro luogo, precisandosi che, mentre il luogo in cui si è verificato l'evento generatore del danno si identifica con quello in cui è stata tenuta la condotta lesiva, per individuare il luogo in cui si è concretizzato il danno occorre avere riguardo al "danno iniziale", e non alle conseguenze negative derivanti da un pregiudizio verificatosi altrove (cfr. Corte di giustizia UE, 4/07/2024, in causa C42522, La MOL Magyar Olajés Gázipari Nyrt.; 12/05/2021, in causa C709/19, Vereniging van Effectenbezitters; 29/07/2019, in causa C451/18, TiborTrans; nel medesimo senso, Cass., Sez. Un., 17/05/2023, n. 13504).
8.1. Ai fini dell'applicazione dei predetti criteri di collegamento, occorre poi considerare che le emissioni climalteranti, pur avendo la loro origine nel luogo in cui si svolgono la produzione, il trasporto e la commercializzazione dei combustibili fossili, hanno una portata naturalmente diffusiva, estendendo i loro effetti all'intera atmosfera terreste, nell'ambito della quale si determina l'incremento della temperatura globale che produce il cambiamento climatico; la lesione del diritto alla vita ed alla vita privata e familiare allegata a sostegno della domanda si verifica invece nel luogo in cui gli attori risiedono, dove è destinata a determinarsi quella compromissione dell'aspettativa di vita, delle condizioni di salute e della qualità complessiva dell'esistenza, che costituisce l'effetto ultimo della sequenza causale innescata dal cambiamento climatico, ed in cui gli attori hanno individuato il danno individuale, concreto ed attuale da loro subìto. Sulla base di tali considerazioni, nel caso di specie, il luogo in cui si verifica l'evento generatore del danno dev'essere individuato in quello (o in tutti quelli, avuto riguardo alla pluralità di luoghi e di Stati in cui si svolge direttamente o indirettamente l'attività dell'ENI) in cui si producono le emissioni climalteranti, mentre il luogo in cui si concretizza il danno fatto valere dagli attori va identificato in quello in cui gli stessi risiedono: l'applicazione di quest'ultimo criterio consente quindi di affermare che la giurisdizione in ordine alla pretesa risarcitoria avanzata dagli attori spetta all'Autorità giudiziaria italiana, mentre l'utilizzazione del primo porterebbe ad individuare una pluralità di giudici competenti, identificabili in quelli di ciascuno dei Paesi (ivi compresa l'Italia) in cui si producono le emissioni di CO2. In proposito, va peraltro evidenziato che, nel ricostruire la sequenza causale generatrice del danno allegato, gli attori ne hanno individuato l'origine nella strategia industriale e commerciale dell'ENI, la cui elaborazione, spettante in definitiva agli organi di governo della società, che operano nel luogo in cui la stessa ha la sua sede legale ed operativa, consentono di collocare la condotta dannosa nel territorio nazionale, con la conseguenza che, anche sotto tale profilo, la competenza giurisdizionale dev'essere assegnata all'Autorità giudiziaria italiana.
Nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza, fatta valere dai convenuti, che una parte (verosimilmente, la maggior parte) delle emissioni lamentate dagli attori siano prodotte da soggetti che, pur appartenendo al gruppo d'imprese facente capo all'ENI, non s'identificano giuridicamente con quest'ultima, essendo dotati di una personalità giuridica distinta ed autonoma ed avendo la loro sede in Paesi diversi dall'Italia, nell'ambito dei quali svolgono più o meno esclusivamente la loro attività: tali soggetti non rivestono infatti la qualità di parti del giudizio principale, nel quale è stata convenuta esclusivamente l'ENI, in qualità di società capogruppo, cui è affidata l'elaborazione e l'approvazione della strategia industriale e commerciale dell'intero gruppo, ritenuta dagli attori all'origine della mancata adozione, da parte delle società controllate, delle misure necessarie per ridurre le emissioni climalteranti che costituisce l'evento generatore del danno da loro lamentato. L'accertamento dell'imputabilità all'ENI delle emissioni prodotte dalle predette società, in relazione alla distinta soggettività giuridica di cui queste ultime sono dotate e dell'autonomia di cui godono nell'effettuazione delle rispettive scelte imprenditoriali costituisce una questione estranea all'oggetto del presente procedimento, riguardando l'individuazione non già del giudice cui spetta la giurisdizione in ordine alla pretesa risarcitoria, ma del soggetto cui è addebitabile la produzione del danno allegato a sostegno della domanda, la quale attiene al merito della controversia.
9. In conclusione, va dichiarato che la giurisdizione in ordine alla domanda proposta dagli attori spetta all'Autorità giudiziaria italiana, con la conseguente rimessione delle parti al Tribunale di Roma, dinanzi al quale il giudizio dovrà proseguire, anche per il regolamento delle spese relative alla presente fase.
P.Q.M.
dichiara la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana, e rimette le parti al Tribunale di Roma, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge.
Così deciso in Roma il 18 febbraio 2025
Depositato in cancelleria il 21 luglio 2025.