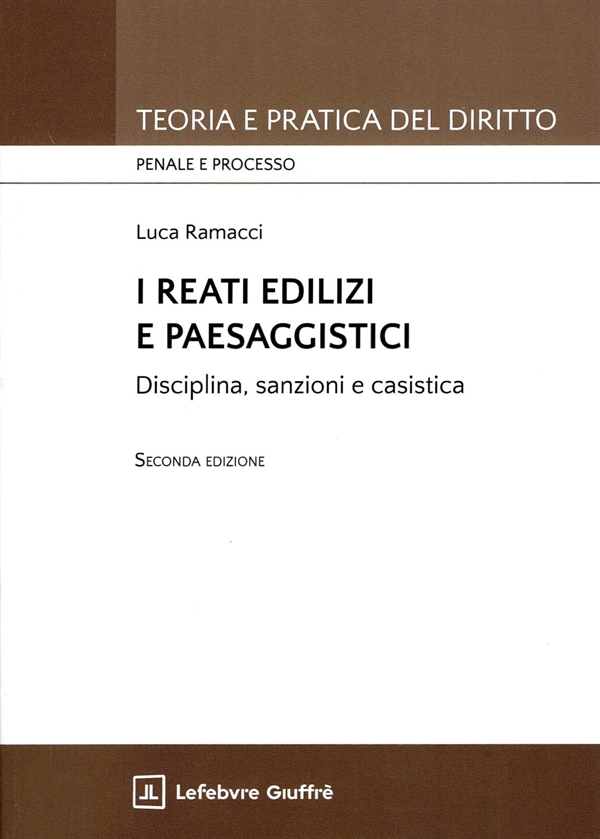Partecipazione civica e legittimazione alla luce della sentenza TAR Campania n. 7451 del 2025
Partecipazione civica e legittimazione alla luce della sentenza TAR Campania n. 7451 del 2025
di Oreste PATRONE
NOTA: La sentenza in commento è leggibile qui
La partecipazione ai procedimenti amministrativi si afferma in Italia come principio generale a partire dalla legge n. 241/1990. Essa rappresentò una conquista democratica, che consegnò alle comunità un prezioso strumento di intervento nelle decisioni pubbliche.
Da allora il contesto è profondamente mutato.
Le istanze sociali si sono ridefinite, gli approcci al confronto pubblico si sono evoluti e si sono affermate nuove forme di partecipazione e di coinvolgimento collettivo, anche attraverso canali informali e digitali, che hanno ampliato l’accesso al dibattito ma ne hanno al tempo stesso reso più complessa la gestione istituzionale, esponendo il procedimento amministrativo a dinamiche inedite.
Inoltre, l’utilizzo distorto di tale istituto, favorito da una lettura talvolta eccessivamente prudenziale e difensiva delle norme sulla partecipazione da parte delle amministrazioni, ha contribuito a delineare un nuovo e problematico confine tra l’esercizio effettivo del diritto partecipativo e una sua declinazione meramente formale, funzionale più alla neutralizzazione del conflitto che alla qualità della decisione pubblica.
La recente sentenza del TAR Campania n. 7451 del 17 novembre 2025, sul cosiddetto “comitato di comodo” si colloca esattamente su quel confine e merita di essere letta non solo per ciò che afferma, ma per ciò che implicitamente esclude. Pur nella consapevolezza che la pronuncia si fonda su una pluralità di autonome motivazioni e si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, l’attenzione qui si concentra su uno specifico profilo, quello della legittimazione e dei suoi riflessi sistemici sulla partecipazione.
È bene chiarire, prima di addentrarci nella disamina dell’accaduto, che la partecipazione ai processi decisionali pubblici, soprattutto in materia ambientale, non rappresenta una generosa concessione dell’amministrazione procedente, ma un elemento strutturale di legittimazione delle proprie scelte. È dunque da questa prospettiva — non ideologica, ma istituzionale — che questa sentenza va interrogata.
Entrando nel merito.
Il TAR dichiara inammissibile il ricorso ritenendo il comitato privo di legittimazione attiva, qualificandolo come organismo costituito ad hoc per opporsi a uno specifico progetto. Nulla di sorprendente, sul piano strettamente giuridico: il giudizio sulla legittimazione serve proprio a evitare che il giudizio si trasformi in una forma di azione popolare surrettizia.
Il problema non sta nel principio in sé, ma nel modo in cui viene applicato. La categoria del cosiddetto “comitato di comodo” funziona come una sorta di sbarramento. È una categoria rapida ed efficace che, letta in chiave meramente formale e senza un’analisi approfondita del ruolo effettivamente svolto dal comitato sul territorio, può portare a confondere la strumentalità con la reattività, ossia a leggere come artificiosa una mobilitazione che, ancorché priva di una storia associativa preesistente, nasce come risposta diretta a un procedimento che incide sul territorio.
È un dato di fatto, del resto, che molti comitati nascano in risposta a un progetto specifico. È un tratto fisiologico delle dinamiche collettive, non un’anomalia patologica. La tendenza a mobilitarsi quando all’orizzonte emerge una minaccia, reale o anche solo percepita, costituisce una reazione sociale frequente, soprattutto in quei contesti in cui la capacità dell’autorità di farsi garante degli interessi locali è messa in dubbio. Lo sanno bene funzionari, amministratori e tecnici che, nei procedimenti più complessi, si trovano spesso a intercettare reazioni che precedono l’atto amministrativo e ne accompagnano l’intero percorso di formazione.
La partecipazione civica, soprattutto in ambito ambientale, non segue i tempi lunghi dell’associazionismo strutturato: segue piuttosto l’irruzione di un impianto, di una variante urbanistica, di un’autorizzazione che modifica l’equilibrio percepito di un territorio.
Pretendere che un comitato esista da anni, che abbia uno statuto e una missione astratta di tutela dell’ambiente significa ignorare l’evidenza per cui la partecipazione nasce spesso dal conflitto, dalla coagulazione di interessi locali e timori, più o meno comprovati, non dalla quotidianità ordinaria.
In questo quadro si innesta un ulteriore profilo, spesso trascurato ma decisivo, che riguarda la valutazione delle istanze di partecipazione al procedimento, delle audizioni, delle osservazioni presentate nelle fasi di evidenza pubblica. Qui il rapporto si pone in un’ottica speculare.
È vero che ai cittadini e ai comitati è richiesto uno sforzo di concretezza, coerenza e pertinenza, ma è altrettanto vero che sull’amministrazione grava il dovere di valutazione effettiva di tali apporti.
La partecipazione, se ridotta a rituale obbligato privo di incidenza reale, rischia di trasformarsi in una soglia simbolica formalmente aperta ma nella pratica sostanzialmente ininfluente. Ed è proprio in questo scarto che si consuma la frattura tra cittadinanza attiva e decisione amministrativa.
Chi si occupa di procedimenti amministrativi ambientali sa che, accanto alle competenze tecniche specialistiche, spesso è richiesto un esercizio non meno impegnativo di ascolto, di intelligenza interpretativa e sensibilità comunicativa.
La valutazione delle osservazioni su un progetto, soprattutto quando provenienti da contesti non specializzati, non può infatti esaurirsi nella loro mera verifica in base ai parametri di una griglia tecnico, per quanto necessaria e rigorosa, ma implica la capacità di cogliere ciò che attraverso di esse si esprime sul piano sociale e umano. Rispondervi in modo adeguato non significa travolgere quei timori con il peso schiacciante del dato scientifico, né liquidarli come errori da correggere con la penna rossa, con un approccio paternalistico e semplificatorio, ma rendere quei dati comprensibili, leggibili e, soprattutto, capaci di svolgere una funzione rassicurante. Anche perché l’autorità competente non è chiamata soltanto ad autorizzare ciò che è tecnicamente possibile e giuridicamente ammissibile, ma a esercitare un ruolo più ampio di tutela, che riguarda la salute pubblica e, insieme, le preoccupazioni delle comunità coinvolte.
Ciò doverosamente chiarito, la sentenza sottolinea anche la mancanza di prova concreta del pregiudizio ambientale lamentato dai ricorrenti. Anche qui, il rilievo è formalmente corretto ma pone una questione che chiunque si occupi di processi decisionali pubblici conosce bene: la pretesa di una dimostrazione puntuale dell’impatto da parte di soggetti con competenze tecniche limitate.
Il giudice amministrativo non può trasformare il processo in una sede di mera prosecuzione di un confronto che, non avendo trovato composizione o considerazione in sede procedimentale, si ripropone in giudizio con gli stessi tratti di indeterminatezza che lo avevano caratterizzato all’origine. Ed è proprio per questo che il filtro della legittimazione e l’onere di una minima dimostrazione del pregiudizio svolgono una funzione essenziale.
Tuttavia, la ricorrenza di contestazioni fragili o congetturali impone una riflessione che supera il singolo caso. In molti procedimenti ambientali, la genericità delle doglianze è spesso il riflesso di una difficoltà strutturale data dalla distanza tra complessità tecnica dei progetti e capacità effettiva dei cittadini di comprenderla e tradurla in argomenti pertinenti, cui si affianca una diffidenza, ormai radicata, nei confronti delle decisioni pubbliche. Chi è chiamato a decidere non può non tenere conto di tutto questo, non tanto in termini di un’incidenza diretta sulla formazione della decisione — che resta, allo stato, espressione della convergenza di valutazioni prevalentemente tecniche — quanto nella consapevolezza dell’impatto culturale e simbolico che quella decisione è destinata a produrre.
Qui si annida un paradosso.
Da un lato, il rigore del filtro è doveroso per preservare la serietà della giurisdizione. Dall’altro, esso finisce per intercettare conflitti che si presentano in forme improprie proprio perché privi degli strumenti culturali e informativi necessari a strutturarsi diversamente. È una frattura che il giudice non è chiamato a colmare, ma che il sistema, nel suo complesso, non può continuare a ignorare, perché investe ambiti culturali, educativi e sociali che condizionano profondamente la qualità stessa della partecipazione.
Il compito della dottrina, in questo contesto, non è quello di anticipare soluzioni normative o procedurali, ma fare emergere le tensioni che attraversano il sistema e ne condizionano l’andamento.
Questa pronuncia del TAR campano è giuridicamente solida e difficilmente censurabile sul piano tecnico. Non è, tuttavia, una pronuncia neutra. Essa produce effetti culturali, prima ancora che giuridici, poiché rafforza l’idea che la partecipazione sia legittima solo se ordinata, preventiva, strutturata e guarda con sospetto quella che nasce dal basso, in modo imperfetto, magari scomposto.
Se la partecipazione civica è parte integrante dei processi decisionali pubblici, allora anche la sua proiezione in sede giurisdizionale va letta all’interno di un equilibrio complesso, che richiede di distinguere con attenzione tra iniziative effettivamente strumentali e forme di reazione collettiva che traggono origine dal procedimento stesso. Si tratta di un’operazione interpretativa possibile, ma esigente, che non sempre può essere risolta attraverso il solo richiamo al difetto di legittimazione.
Lungi dal volere mettere in discussione la correttezza del diritto applicato, limitandoci all’osservazione dei suoi effetti sistemici, quello che emerge da questa sentenza è la conferma della solidità degli strumenti a disposizione del giudice amministrativo. Essa impone, al tempo stesso, una riflessione sulla partecipazione, sulle modalità del suo esercizio e sui filtri preventivi posti a presidio del suo uso distorto. Una riflessione che si colloca sul piano sociale e istituzionale, prima ancora che giuridico, se si vuole evitare che il rigore delle categorie processuali finisca, nel tempo, per coincidere con una riduzione degli spazi di ascolto.