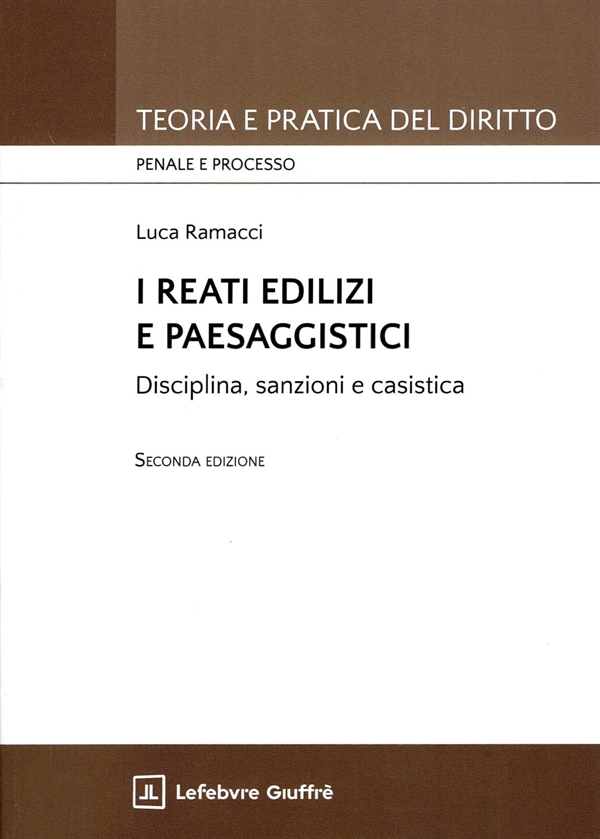Cass. Sez. III n. 13701 del 19 aprile 2006 (Ud. 15 febbraio 2006)
Pres. Grassi Est. Mancini Ric. Salvo
Beni Culturali - Furto archeologico (elemento oggettivo)
Il reato di "furto d'arte" in tanto si perfeziona in quanto il soggetto abbia posto in essere un'azione a mezzo della quale abbia appreso la cosa spostandola dal luogo in cui originariamente si trovava per collocarla altrove, nel proprio dominio. Non è dunque sufficiente un atteggiamento meramente passivo come si verifica ad esempio allorché la cosa sia pervenuta al soggetto che la detiene per successione ereditaria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 15/02/2006
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 00267
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 009949/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) /SALVO GIUSEPPE/ N. IL 13/01/1945;
avverso SENTENZA del 26/01/2004 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MANCINI
FRANCO;
Udito il P.M. in persona del Dott. Izzo Gioacchino che ha concluso:
annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Udito il difensore avv. Buscemi Gaetano di Roma.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26 gennaio 2004 la Corte d'appello di Palermo in riforma della
sentenza in data 3 aprile 2000 del tribunale di Marsala sezione distaccata di
Mazara del Vallo, impugnata dal Procuratore generale, affermava la
responsabilità di Salvo Giuseppe in ordine al reato a lui ascritto, previsto e
punito dalla L. n. 1089 del 1939, artt. 1 e 67 avente ad oggetto la tutela delle
cose di interesse artistico o storico, per avere omesso di denunciare reperti di
interesse storico ed artistico fortuitamente rinvenuti dei quali si era pertanto
impossessato. Lo condannava conseguentemente alla pena di legge disponendo la
confisca, in parte, di quanto in sequestro. La Corte è pervenuta a questa
conclusione considerando che tutti i reperti hanno sicuro interesse archeologico
ed in qualche caso anche storico ed artistico. Le ceramiche e le monete
rientrano con certezza nell'elenco di cui all'art. 1 della legge in questione ed
in quanto tali sono sottoposti allo speciale regime previsto da quest'ultima.
rileva la Corte stessa che impropriamente all'imputato è stato contestato di non
avere denunciato i reperti atteso che risulta esserne soltanto il possessore e
versare dunque nella personale condizione prevista e sanzionata ai sensi della
L. del 1939, art. 67, attualmente D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 125.
L'imputato solo genericamente e tardivamente ha dichiarato che i "cocci"
provenivano dai genitori. In realtà però non ha fornito alcuna prova circa la
loro legittima provenienza, tanto più necessaria in quanto molti di essi
risalgono ad epoca precristiana. a mezzo del difensore propone ricorso per
cassazione l'imputato rilevando in primis che la sentenza impugnata nonostante
il riferimento all'art. 125 della nuova normativa - D.L. n. 490 del 1999 - in
realtà finisce con l'applicare la vecchia, più severa dal punto di vista
sanzionatorio.
Nega poi di avere fortuitamente ritrovato i beni o di essersi procurato gli
stessi mediante escavazione.
Peraltro, come emerso nel primo grado di giudizio, gli stessi non sono di
particolare pregio artistico.
La Corte si sarebbe basata al riguardo su indimostrate affermazioni del perito.
Anche l'eredità rileva - costituisce un modo di acquisto legittimo della
proprietà dei beni.
Nelle more del presente giudizio di legittimità la difesa ha presentato una
memoria nella quale osserva che nella specie, per i beni di che trattasi, non è
mai iniziato e non si è mai svolto quel procedimento amministrativo di cui al
D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 13 previsto per l'accertamento del valore culturale
del reperto che è condizione imprescindibile perché possa parlarsi di furto
d'arte secondo la previsione dell'illecito impossessamento dei beni culturali
dello Stato di cui al D.Lgs. art. 176.
Nella memoria si ricorda inoltre che spetta comunque all'accusa di dare la prova
della illegittima provenienza dei beni. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini che vengono di seguito precisati. Occorre
ricordare che all'imputato è contestato di "essersi impossessato di beni di
interesse artistico e storico fortuitamente rinvenuti ed in particolare di
monete metalliche e reperti ceramici vari".
La contestazione riecheggia la formula della L. n. 1089 del 1939, art. 67 che
era del seguente letterale tenore "Chiunque si impossessa di cose di antichità e
d'arte rinvenute fortuitamente ovvero in seguito a ricerche ed opere in genere è
punito ai sensi dell'art. 624 c.p.". La norma corrispondente (art. 125)
contenuta nel D.Lgs. 490 del 1999 che ha abrogato (art. 166) la L. del 1939,
rubricata come "impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo
Stato" è espressa con parole pressoché identiche "chiunque si impossessa di beni
culturali indicati nell'art. 2 appartenenti allo Stato a norma dell'art. 88 è
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da Euro 30,00 a 516,00".
Lo stesso dicasi della norma corrispondente attualmente in vigore (art. 176)
contenuta nel D.Lgs. n. 42 del 2004 - che con l'art. 184 ha abrogato il predetto
decreto legislativo - nella quale testualmente si legge " Chiunque si impossessa
di beni culturali indicati nell'articolo 10 appartenenti allo Stato ai sensi
dell'art. 91 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da Euro
31 ad Euro 516,50".
Inoltre l'art. 90 di quest'ultimo decreto legislativo, contenente il codice dei
beni culturali e del paesaggio ai sensi della L. 6 luglio 2002, n. 137, art. 10,
disciplina le "scoperte fortuite" dei beni di cui si tratta e gli obblighi che
incombono sullo scopritore mentre il successivo art. 91 proclama che i beni
stessi "da chiunque ed in qualunque modo ritrovati nel sottosuolo o nei fondali
marini appartengono allo Stato...".
Ebbene sia la formula usata dall'art. 176 del vigente decreto legislativo (come
peraltro quelle uguali o analoghe dei corrispondenti, precedenti testi
legislativi), che fa riferimento ad una azione di impossessamento, sia la
struttura della norma che riecheggia quella usata dal codice penale all'art. 624
per il furto (richiamata, quest'ultima, nei vari provvedimenti legislativi che
nel tempo hanno disciplinato la materia anche per la determinazione della misura
della pena) sono elementi i quali inducono a ritenere che in tanto il reato -
c.d. furto d'arte - si perfeziona in quanto il soggetto abbia posto in essere
un'azione a mezzo della quale abbia appreso la cosa spostandola dal luogo in cui
in origine si trovava per collocarla altrove, nel proprio dominio.
Non basta dunque, in altre parole, che nei confronti della acquisita
disponibilità della cosa il soggetto abbia tenuto un atteggiamento meramente
passivo come si verifica ad esempio allorché essa gli sia pervenuta per
successione ereditaria.
Conferma questa interpretazione della norma il rilievo che l'art. 92 del vigente
decreto legislativo - a somiglianza di quanto statuito nei precedenti testi
normativi - prevede un premio per i ritrovamenti (concetto che esprime un
comportamento attivo e non un atteggiamento di mera ricezione e passività) ma
soprattutto l'esplicito richiamo contenuto nell'art. 176 al precedente art. 91
in forza del quale sono oggetto di protezione le cose "ritrovate nel sottosuolo
o sui fondali marini".
Ebbene, nella specie l'affermazione nel secondo grado di giudizio della
responsabilità dell'imputato (dopo l'assoluzione da parte del tribunale) è
avvenuta in quanto, come si legge nell'impugnata sentenza, egli non ha saputo
dare alcuna giustificazione della provenienza delle cose sequestrate. Ciò da un
lato significa che la Corte di merito non ha ravvisato nella sua condotta gli
estremi di cui al combinato disposto del vigente D.Lgs. n. 42 del 2004, artt.
176 e 91; dall'altro che la mancata acquisizione della prova di colpevolezza
dell'imputato non può ricadere su quest'ultimo in quanto anche in questo caso,
come di norma e come in materia ha puntualmente statuito questa Corte Suprema
con la sentenza di questa 3^ sezione n. 28929 del 27 maggio 2004 Rv. 229492, la
prova della illegittima provenienza dei beni di interesse archeologico non è a
carico dell'imputato ma della pubblica accusa.
Alla stregua delle considerazioni che precedono deve concludersi che
contrariamente all'avviso dell'impugnata sentenza il fatto contestato
all'imputato - illecito impossessamento di reperti archeologici fortuitamente
rinvenuti - non sussiste.
Questa conclusione è assorbente ed esonera il Collegio dall'obbligo di esaminare
gli altri motivi del ricorso, in particolare quello incentrato sul fatto che
nella specie, per i beni di cui si tratta, è mancata la dichiarazione di
interesse culturale di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 13.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché
il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 febbraio 2006. Depositato
in Cancelleria il 19 aprile 2006