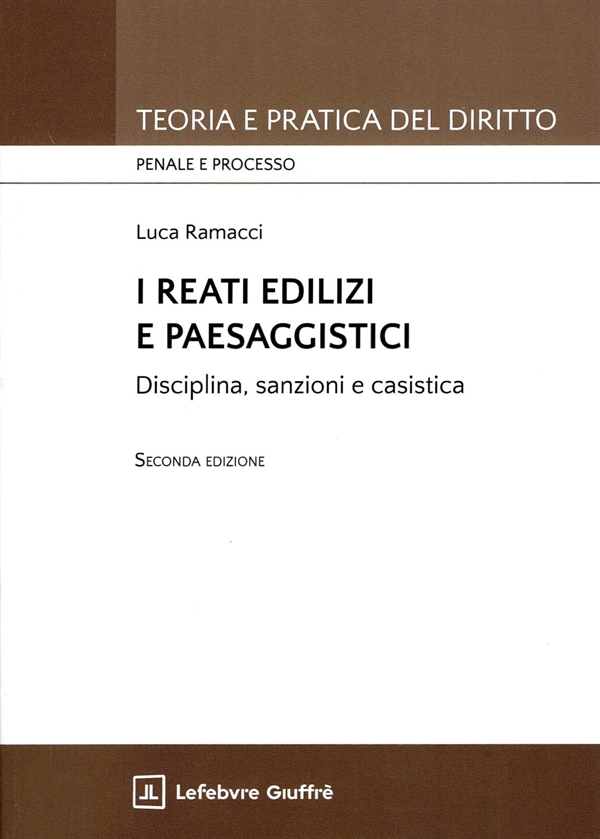INQUINAMENTO IDRICO E ATMOSFERICO: LA DISCIPLINA PENALE DOPO IL C.D. TESTO UNICO AMBIENTALE
Prof. Paolo Patrono
ordinario di diritto penale nell’Università di Verona
relazione tenuta all\'Incontro di Studio del CSM "I Crimini Ambientali"
INQUINAMENTO IDRICO E ATMOSFERICO: LA DISCIPLINA PENALE DOPO IL C.D. TESTO UNICO AMBIENTALE
Anche dopo l’approvazione del d.lgs. 152/2006 (c.d. testo unico ambientale) e dell’ultimo suo “correttivo” (d.lgs. 4/2008) - che, peraltro, ha tentato, in pochi articoli, di meglio adeguare la normativa ambientale al diritto comunitario, introducendo anche una sorta di parte generale della materia con il richiamo espresso di principi costituzionali e con l’inserimento, tra l’altro, nel testo legislativo, di alcuni importanti principi di origine comunitaria (principio della precauzione; dell’azione preventiva; della correzione, in via prioritaria, alla fonte dei danni all’ambiente; del “chi inquina paga”) a garanzia della tutela dell’ambiente - il sentimento che rimane, almeno nello studioso di diritto penale, è quello di profonda frustrazione.
Anche dopo l’approvazione del c.d. T.U. ambientale, così come modificato ed integrato, si può dire che il quadro legislativo è ancora caotico. Fermando la mia attenzione all’inquinamento idrico ed atmosferico, non posso non notare, infatti, che accanto ai numerosi articoli di legge (circa 150) ed allegati (21) del decreto legislativo in oggetto, rimangono in vigore - a prescindere dalle interferenze necessarie con la disciplina di settori strettamente collegati quali quello dei rifiuti, della disciplina in materia di urbanistica, paesaggio e bellezze naturali, almeno altre 7-8 importanti leggi esclusivamente dedicate alla tutela dell’acqua e dell’aria.
Senza parlare, poi, del continuo, inarrestabile, sovraffollamento di direttive da recepire, l’ultima, in materia di aria, è del 21.5.2008 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea l’11.6.2008: direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa. (direttiva composta da 35 articoli, numerosi allegati e ricca di definizioni, come quelle di: aria ambiente; inquinante; valore limite; livello critico; valore obiettivo; soglia di allarme). Anche dopo il d.lgs. 2006 e successive modificazioni si può dire che i modelli di incriminazione e le tecniche di tutela sono le stesse del passato. Nei primi commenti (Vergine) si è parlato (almeno con riferimento alla tutela dell’inquinamento idrico) di mera “fotocopiatura” delle fattispecie del testo previgente (d.lgs. 152/1999) ma lo stesso può dirsi per la tutela dall’inquinamento atmosferico rispetto alle fattispecie che erano
1
previste dagli artt. 24 e 25 del d.P.R. 203/88 con alcune precisazioni, tuttavia, che nel prosieguo dell’analisi saranno doverose.
Nessuna integrazione significativa, con l’unica differenza, rispetto al passato, che immediatamente è balzata agli occhi anche dei primissimi commentatori, dell’incremento dei limiti dell’ammenda per i reati in materia di inquinamento idrico nonostante l’espressa indicazione in senso contrario della legge delega, che all’art. 1, dopo aver affermato che i decreti legislativi avrebbero dovuto conformarsi, tra gli altri principi, a quello (8° comma lett. i) della garanzia di una più efficace tutela in materia ambientale anche mediante il coordinamento e l’integrazione del sistema sanzionatorio”, stabilisce che tutto ciò deve avvenire “fermi restando i limiti di pena e l’entità delle sanzioni amministrative già stabilite dalla legge”.
Ancora contravvenzioni, ancora illeciti formali, ancora reati di disobbedienza, ancora pericolo presunto. Ancora una volta dipendenza del nostro diritto penale ambientale dal diritto amministrativo secondo i collaudati schemi della punizione delle attività di scarico, di emissione in assenza dell’autorizzazione o nell’inosservanza di un provvedimento amministrativo. Accanto a queste fattispecie - in alcuni casi ulteriormente specificate (non ottemperanza alle prescrizioni, non ottemperanza al provvedimento adottato dall’autorità competente, effettuazione degli scarichi dopo la sospensione o revoca dell’autorizzazione, ecc.) – i classici reati di pericolo presunto di superamento degli standard legislativi (art. 137 per la tutela delle acque, art. 279 per la disciplina delle emissioni) e, con riferimento alla tutela dell’aria, la fattispecie, che di sicuro non rappresenta un modello nuovo d’incriminazione nell’ambito della tutela penale dell’ambiente, che sanziona l’omessa adozione delle misure necessaria ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni nei casi previsti dall’art. 281, 1° comma, cioè per “i gestori degli impianti autorizzati anche in via provvisoria o in forma tacita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203 (con alcune eccezioni indicate nello stesso art. 281).
Con una rilevante novità, tuttavia, in materia di acque, per quella importante fattispecie che, all’art. 58 d.lgs. 152/99 sanzionava l’inosservanza di obblighi ripristinatori (omessa bonifica e ripristino dei siti inquinati) e di cui non troviamo alcuna traccia nell’art. 137 d.lgs. 152/2006. Questa fattispecie era solo in parte simile a quella contenuta nell’art. 51-bis d.lgs. 22/97 in materia di rifiuti e, secondo alcuni,
2
rappresentava una sorta di “terzo livello” di tutela penale dell’ambiente (ma avevo già notato che anche queste fattispecie – ove l’obbligo trovi concretezza nell’ingiunzione dell’autorità amministrativa – riproducono lo stesso schema di dipendenza del diritto penale dal diritto amministrativo).
La particolarità di queste fattispecie criminose derivava dal fatto che presupponevano, secondo la formula legislativa , un inquinamento o un pericolo di inquinamento già realizzato. Con un’ importante differenza, tuttavia, che nell’ipotesi di cui all’art. 51-bis d.lgs. n. 22/1997 l’inquinamento era normativamente considerato quale superamento dei limiti di cui al comma 1 lett. a) e il pericolo era definito dal legislatore come un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, mentre nella fattispecie di cui all’art. 58 d.lgs. n. 152/1999 si faceva riferimento ad un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo o alle altre risorse ambientali, o genericamente ad un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale.
L’ipotesi di cui all’art. 58 del d.lgs. 152/1999 in materia di tutela delle acque dall’inquinamento presupponeva, quindi, almeno stando alla lettera della legge, per la propria effettiva operatività, un preventivo accertamento dell’esistenza del nesso causale tra il comportamento inosservante le norme del decreto e il danno o il pericolo per le risorse ambientali. E, tutto ciò, paradossalmente, in una legislazione speciale che prescindeva e che prescinde sempre dall’offesa ad un concreto bene giuridico proprio perché l’evento offensivo non viene mai selezionato dal legislatore in un determinato nucleo significativo riducendo in tal modo la criminalità ambientale a criminalità bagatellare.
Nella parte quarta del decreto, dedicata ai rifiuti e alla bonifica dei siti inquinati, troviamo, però, all’art. 257 una fattispecie di omessa bonifica che non solo sostituisce, con formula diversa, e per certi versi più limitativa, la fattispecie dell’art. 51-bis d.lgs. 22/97, ma che ricomprende di sicuro, al suo interno, parte della previgente fattispecie di cui all’art. 58 d.lgs. 152/99. Viene punito, infatti, “chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia rischio (…) se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di cui agli art. 242 e seguenti”.
3
Il secondo comma prevede, poi, che si applica una pena più grave “se l’inquinamento è provocato da sostanze pericolose”.
Ora, l’unificazione delle fattispecie, limitata all’omessa bonifica in caso di inquinamento e non anche, come in passato, di pericolo di inquinamento, configura tuttavia l’inquinamento – similmente a quanto avveniva nell’art. 51-bis d.lgs. 22/97 come superamento di limiti (in questo caso superamento delle concentrazioni soglia rischio) e non come effettivo danno alle risorse ambientali, diversamente da quanto disponeva l’art. 58 d.lgs. 152/99 (forse) con rinvio implicito alla vaghissima definizione di inquinamento che veniva fornita dall’art. 2 dello stesso decreto. Bisogna rilevare, a tale proposito, che, come in passato, anche in questa fattispecie criminosa l’evento non è l’inquinamento la cui punizione viene subordinata all’omessa bonifica, come, invece, sostenuto da una recente sentenza della Corte di Cassazione (sez. III, 14.3.2007, dep. 9.7.2007, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2007, 869 ss.). Ci troviamo sempre di fronte ad un reato omissivo di pericolo presunto: non si punisce l’inquinamento bensì l’omessa bonifica come viene chiaramente evidenziato anche dalla sanzione prevista dall’art. 257 d.lgs. 2006/152 (pena dell’arresto da tre mesi a un anno o dell’ammenda da mille euro a ventiseimila euro – stessa pena prevista per il trasporto di rifiuti in assenza di autorizzazione!).
Ma, comunque si voglia qualificare la fattispecie, è chiaro che si avrebbe oggi, comunque, un restringimento dell’area di rilevanza penale dell’omessa bonifica dei siti inquinati per acqua e rifiuti: un’area di continuità normativa e, quindi di successione soltanto modificativa, rilevante ai sensi dell’art. 2, 4° comma, c.p. e un’area di sicura abolitio criminis, rilevante ai sensi dell’art. 2, 2° comma, c.p.. Anche se bisogna considerare l’osservazione già formulata in dottrina, secondo la quale, con riferimento al superamento delle concentrazioni soglie rischio (CSR) l’allegato 1 alla parte 4a del decreto 2006 “nulla prevede in ordine ai criteri di valutazione della contaminazione che permettano di eliminare gli effetti dell’inquinamento del sito sulle acque superficiali e di prescrivere obiettivi di bonifica” (FIMIANI). Si sostiene, quindi, che, al di là della volontà del legislatore di punire con questa norma anche la bonifica di acque superficiali inquinate “la norma mai potrà efficacemente sanzionare la mancata bonifica delle stesse, proprio perché, stando agli attuali contenuti dell’allegato 1 alla parte quarta, non si potrà individuare il loro livello di contaminazione (VERGINE)
4
Abbiamo, per ora, accertato che, per quanto attiene all’inquinamento idrico e all’inquinamento atmosferico, i modelli di incriminazione, le fattispecie incriminatrici, la disciplina sanzionatoria, pur con alcune particolarità già individuate (aumento dei limiti delle sanzioni pecuniarie per i reati in materia di inquinamento delle acque, diversa riproposizione, con ambito ridotto di rilevanza penale, dell’omessa bonifica dei siti inquinati, sempre in materia di acque, con dubbi sull’effettiva operatività della restante area di incriminazione) sono gli stessi del passato e che pressoché identico è lo smarrimento dell’interprete di fronte alla caotica disciplina extrapenale integrativa dei precetti penali. Ovviamente, ampio è ancora oggi lo spazio dell’errore scusabile sul precetto, lo spazio per eccezioni di costituzionalità per violazione del principio di legalità, e, purtroppo, è ancora troppo ampia l’area delle violazioni sostanziali punite come se fossero formali, e quella degli illeciti non puniti perché il controllo amministrativo è mancato o è stato insufficiente. Ancora una volta, quindi, può dirsi che la forma di tutela penale dell’ambiente, attuata nel nostro Paese, è meramente simbolica: con la tutela anticipata non si è realizzata una maggiore tutela del bene o dei beni che si volevano proteggere. Si è realizzata una sottotutela o addirittura una non tutela dei beni ambiente e salute e forse si può dire che non si è attuata neanche una tutela di funzioni visto il fallimento del momento politico amministrativo. Ma ora vediamo più da vicino, anche se solo per brevi cenni, visto il tempo a disposizione della mia relazione, alcuni dei problemi che la nuova e vecchia formulazione degli illeciti, così come integrati dalla normativa extrapenale, possono creare e che sono stati oggetto di particolare attenzione a livello interpretativo, e come la magistratura abbia tentato – spesso purtroppo creando nuove fattispecie criminose in palese violazione del principio di legalità – di rimediare alle carenze del legislatore attraverso una ardita rilettura di vecchie, inadeguate fattispecie del codice Rocco solo in minima parte adattabili ai nuovi fenomeni criminosi.
A) Problemi relativi alla modifica di disciplina in materia di acque
Un primo problema di delimitazione dell’ambito di operatività della disciplina anche penale di tutela dell’acqua dall’inquinamento rispetto a quello della disciplina in materia di rifiuti, posto dalla definizione di “scarico” contenuta nel testo originario dell’art. 74 d.lgs. 152/2006, apparentemente meno chiara di quella contenuta nella normativa previgente e che aveva fatto temere, a qualche interprete, la riproposizione di vecchie
5
incertezze nella delimitazione dei rapporti tra “scarichi” e “rifiuti liquidi” con il ripristino del concetto di scarico indiretto, è stato ormai risolto attraverso la modifica dell’art. 74 apportata dal c.d. decreto “correttivo” n. 4 del 2008, in base al quale lo scarico è “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore”. Bisogna, peraltro, mettere in luce come la giurisprudenza, sin da subito, abbia dato una lettura dell’art. 74 che lasciava inalterati i vecchi confini.
Un secondo problema, che riguarda questa volta la qualificazione dell’illecito come penale, attiene all’oggetto dello scarico che deve essere rappresentato da acque reflue industriali.
Dopo il “correttivo” del 2008 la definizione di acque reflue industriali è quella di “qualsiasi acque reflue scaricate” (e non “provenienti” come nel testo originario dell’art. 74) “da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzioni di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento”. La definizione, pressoché identica a quella contenuta nella previgente disciplina (è stato sostituito solo il termine “installazione” con quello di “impianti” come luogo di provenienza degli scarichi), mette in luce come, anche oggi, a differenza di quanto avveniva nella vigenza della legge Merli, non è il criterio formale della provenienza – pur indicato nella definizione del d.p.r. 99 e del d.p.r. 2006 – a prevalere ma quello della qualità del refluo che deve essere diverso da quello delle acque domestiche e meteoriche di dilavamento, come peraltro riconosciuto dalla quasi unanime giurisprudenza. Bisogna, tuttavia, rilevare a tale proposito, che, come già messo in evidenza in dottrina (GIAMPIETRO) non è sempre agevole accertare quando in uno scarico siano prevalenti sostanze di natura domestica o diverse.
B) Problemi relativi alla modifica di disciplina in materia di aria
Con riferimento all’ambito applicativo della nuova disciplina penale dell’inquinamento atmosferico, la Cassazione (Cass. sez. III n. 40964 del 11.10.2006 e Cass. sez. III n. 456 del 13.1.2007) ha, da un lato, affermato che la mancata riproposizione nella definizione (di cui all’art. 267 1° comma T.U. ambientale) di “impianto” delle parole “che serve per usi industriali o di pubblica utilità” riconduce l’ambito di applicazione della normativa alla precedente elaborazione giurisprudenziale (secondo cui si escludeva che il legislatore avesse voluto limitare la tutela ai soli
6
impianti definibili come industriali ai sensi dell’art. 2195 c.c. escludendo quelli non individuabili come tali “ma che pure potevano avere uguale o maggiore potere inquinante”) e, dall’altro, che l’art. 267, 1° comma, restringe l’ambito applicativo della disciplina a quella degli impianti e delle attività che producono immissioni in atmosfera non essendo più sufficiente, come in passato, la generica possibilità di produzione di emissioni.
La questione dell’ambito applicativo della nuova disciplina penalistica prevista nella parte V del d.lgs. 152/2006, nonostante queste prime prese di posizione della giurisprudenza di legittimità, condivise dai primi commentatori (FIMIANI, RAMACCI), non credo sarà di così semplice risoluzione ai fini della determinazione della disciplina da applicare in tema di successione di leggi penali.
Proprio con riferimento alla disciplina del 1° comma dell’art. 279, da cui parte l’analisi della Corte, primo comma che punisce chi “inizia ad installare o esercisce un impianto e chi esercita un’attività in assenza della prescritta autorizzazione”, sorgono i primi dubbi sulla esclusione dall’ambito di rilevanza penale della generica possibilità di produzione delle emissioni da parte dell’impianto.
Nonostante l’espressa previsione dell’art. 267, 1° comma, come distinguere, se si richiede in ogni caso l’effettiva produzione delle emissioni, l’inizio di installazione dall’esercizio dell’impianto in assenza di autorizzazione ? Pur avendo il legislatore mutato formula, non più chi “inizia la costruzione di un nuovo impianto” come nel previgente art. 24 d.p.r. 203/88, bensì chi “inizia ad installare ….. un impianto”, è chiaro che il fatto punito è identico e di sicuro nell’inizio di costruzione (o di installazione) di un impianto non è presa in considerazione l’effettiva produzione di emissioni ma solo la possibilità di produrre emissioni.
Ove si dovesse giungere a diverse conclusioni, si dovrebbe ritenere depenalizzata la precedente ipotesi criminosa di inizio di costruzione di un impianto in assenza di autorizzazione ma la stessa Cassazione, di recente (sez. III 17.1.2008 ud. 9.10.2007, n. 2488), riconosce che il reato di realizzazione di un impianto in difetto di autorizzazione, di cui all’art. 24, comma 1, d.p.r. n. 203 del 1988 è ora “sostituito con continuità normativa dall’art. 279, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006”. Ora, a prescindere dalla qualificazione, operata dalla Corte, del reato come permanente, che non trova alcuna conferma nel testo della fattispecie incriminatrice, è comunque chiaro che il momento
7
perfezionativo del reato si realizza – secondo la stessa impostazione seguita dalla Cassazione – nel momento di “inizio di costruzione” fatto coincidere con quello di “inizio di installazione”.
Ma, proprio con la qualifica di permanenti attribuita dalla giurisprudenza a quasi tutte le contravvenzioni in materia ambientale incentrate sull’assenza di autorizzazione o di comunicazione, si entra in un tema particolarmente controverso che tuttavia, spesso, come quello della qualifica di reato comune invece che di reato proprio data a fattispecie a prevalente componente omissiva, tende a facilitare l’accertamento delle responsabilità penali.
Questi reati vanno qualificati, secondo parte della dottrina, come misti di azione ed omissione, di carattere prevalentemente omissivo (per questa categoria di reati, per tutti, v. CADOPPI), reati omissivi di pura condotta rispetto ai quali qualificata dottrina ritiene incompatibile il reato permanente.
Anche se, poi, in realtà, bisognerebbe ulteriormente distinguere: innanzitutto per stabilire se sia proprio vero che tutte queste fattispecie hanno una componente omissiva e se questa è prevalente, ed in secondo luogo se sia proprio vero che, rispetto ai reati omissivi di pura condotta, è sempre incompatibile il reato permanente.
Fermandoci per il momento ai reati incentrati sull’assenza di un’autorizzazione, questa è un elemento costitutivo della fattispecie costruito negativamente: la sua assenza rende quindi il fatto tipico. La fattispecie è costituita da un elemento positivo: il tenere la condotta attiva di un certo tipo (iniziare l’installazione di un impianto di un certo tipo, esercitare un’attività di emissione di un certo tipo, mettere in esercizio un impianto di un certo tipo) e il fatto diventa tipico, in quanto considerato presuntivamente pericoloso, solo quando è realizzato in assenza dell’atto amministrativo di controllo (art. 279, 1° comma). Non si punisce, tuttavia, in questi casi, per non aver presentato la domanda di autorizzazione ma si punisce per aver intrapreso una certa attività prima che l’autorità amministrativa abbia esercitato il necessario controllo. L’omissione consiste nel non fare qualcosa che si aveva l’obbligo giuridico di fare: si sanziona, quindi, una condotta negativa. In questo caso invece si punisce una condotta positiva svolta in assenza di un presupposto richiesto dal legislatore. Ed è nel momento in cui si realizza la condotta attiva, in assenza del presupposto richiesto dal legislatore, che si consuma il reato che sarà normalmente istantaneo. Anche se vi sono casi in cui la mancata domanda di
8
autorizzazione entro un certo termine si considera esercizio senza autorizzazione. Non vi è un termine per la presentazione della domanda di autorizzazione che non entra in gioco in quanto non si punisce per l’omessa richiesta di autorizzazione. Occorre, tuttavia, analizzare se le diverse condotte indicate, inizio di installazione, esercizio di impianto, attività di emissione, siano diverse modalità della condotta di un solo reato che in questo caso sarebbe eventualmente permanente o, come sembra doversi sostenere, quantomeno per le prime due, autonome fattispecie di reato: in questo caso solo l’esercizio di un impianto senza autorizzazione si configurerebbe come reato permanente.
Diversa è l’ipotesi di chi tiene una condotta attiva (mette in esercizio un impianto di un certo tipo, esercita un’attività di emissione di sostanze di un certo tipo) senza aver dato la prescritta comunicazione all’autorità competente (art. 279, 3° comma). In questo caso l’assenza di comunicazione è la componente omissiva del fatto: l’omissione consiste nel non aver effettuato la comunicazione che si aveva l’obbligo di effettuare e solo in questo caso si può dire che il reato è in parte di azione e in parte di omissione e che la componente omissiva è prevalente. In questo caso, tuttavia, l’azione doverosa (cioè la comunicazione all’autorità) avrà un termine entro il quale va fatta e solo alla scadenza del termine, senza che sia stata effettuata, il reato si consumerà: in questo caso, però, il reato dovrà considerarsi istantaneo.
Solo nel caso in cui, guardando alla struttura della norma, si dovesse accertare che anche “dopo la scadenza del termine persistano l’obbligo e la possibilità di tenere la condotta comandata” si potrà, per una parte della dottrina, ritenere il reato come permanente. Ed è questa la tesi che sembra accogliere la giurisprudenza senza, tuttavia, che vi sia sempre il necessario approfondimento d’indagine sul tipo e sulla struttura dell’illecito preso in considerazione.
E non appare condivisibile quella giurisprudenza, anche recente (sez. III 28.11.2007 ud. 13.11.2007, n. 44298), che ritiene che “in tema di inquinamento atmosferico, la presentazione di una domanda di autorizzazione incompleta, perché priva delle indicazioni relative alle caratteristiche tecniche dell’impianto nonché ai valori di emissione, integra il reato di esercizio di impianto in assenza della prescritta autorizzazione (art. 25 d.p.r. 203/1988 oggi sostituito dall’art. 279 comma 1 d.lgs. 152/2006) in quanto l’incompletezza della domanda è equiparabile all’omessa 9
presentazione della medesima. Ciò che il legislatore punisce, infatti, non è l’incompletezza della domanda, ma lo svolgimento di una certa attività in assenza di autorizzazione. Se, nonostante l’incompletezza della domanda, l’autorizzazione è stata rilasciata il giudice, se accerta che la legittimità dell’atto amministrativo è requisito implicito della fattispecie, potrà si considerare l’autorizzazione come inesistente ma solo in quanto illegittima.
Passando brevemente alla questione della qualifica dei reati ambientali come comuni o propri, e premesso che nella quasi totalità delle ipotesi saranno considerati come reati propri in quanto sarà, a seconda dei casi, il titolare dell’insediamento, dello scarico, dell’autorizzazione o comunque chi ha il potere decisionale in materia ad essere il soggetto attivo cui fa riferimento la fattispecie, che apparentemente si rivolge a chiunque, bisogna notare che, con particolare riferimento alla nuova disciplina dei reati in materia di inquinamento atmosferico, la qualifica di reati propri risulta in maniera estremamente chiara dallo stesso testo legislativo. Fermandoci alle ipotesi, appena prese in considerazione, per esempio, installazione, esercizio di un impianto, attività di emissione, il “chiunque” del 279, 1° comma, d.lgs. 152/2006 si personalizza attraverso il rinvio implicito (e necessario) all’art. 268 che alla lett. n) definisce come gestore la persona fisica o giuridica che ha un potere decisionale circa l’installazione o l’esercizio dell’impianto o, (nei casi previsti dall’art. 269, commi 10, 11 e 12 e dall’art. 275), la persona fisica o giuridica che ha un potere decisionale circa l’esercizio dell’attività. E’, quindi, in questi casi, il legislatore che individua espressamente l’obbligato primario, colui che può realizzare il reato eventualmente in concorso con soggetti che non rivestono il ruolo (qualifica) indicato dal legislatore.
A differenza, quindi, di quanto una parte della dottrina continua a sostenere, questi reati non possono considerarsi comuni ma propri, a soggettività ristretta.
A prescindere da questi casi, appena analizzati, in cui è il legislatore che individua il soggetto attivo come colui che di fatto ha i poteri decisionali e, che quindi, risolvono in radice anche il problema di validità e di efficacia penalistica della delega essendo soltanto necessario accertare se il soggetto, cui va attribuito il reato, avesse nel periodo della commissione del fatto, il potere decisionale voluto dal legislatore, anche nei casi, in cui il “chiunque” si riferisce a chi aveva una qualifica formale implicitamente richiesta dal legislatore (proprietario, amministratore delegato, direttore di stabilimento,
10
ecc.), è chiaro che la delega di funzioni, che abbia determinate caratteristiche, non può non avere efficacia penalistica, ed in questo senso è attualmente orientata la costante giurisprudenza, anche se tuttora si continua a discutere se la delega abbia un’incidenza solo soggettiva o anche oggettiva escludendo la stessa materialità del fatto: se residui nel delegante un obbligo di garanzia e di vigilanza o se, in caso di delega effettiva, la responsabilità penale passi dal delegante al delegato, liberando il primo da obblighi di garanzia e di vigilanza.
Lasciando l’approfondimento del tema alla relazione della prof.ssa Severino, ritengo che la tesi maggiormente accoglibile oggi sia quella funzionalistica sulla quale ormai anche parte della giurisprudenza sembra concordare. Risponde penalmente solo chi effettivamente svolge le funzioni corrispondenti alla qualifica formale. Solo chi ha effettivamente i poteri e le funzioni ha anche gli obblighi e le responsabilità penali relativi: la delega di funzioni effettiva, che consente piena autonomia decisionale e patrimoniale al delegato, nel caso di obblighi di per sé trasferibili, incide, quindi, sulla stessa materialità del fatto escludendola.
Concordo, quindi, con chi sostiene (FIORELLA) che è la stessa norma penale, nella sostanza, che quando indica esplicitamente o implicitamente determinate qualifiche formali fa implicito riferimento a chi effettivamente svolge le funzioni e, quindi, ha i poteri e doveri corrispondenti alla qualifica extrapenalistica di rilievo.
Ho solo accennato in precedenza all’attività di supplenza della magistratura, spesso in violazione del principio di legalità, nel tentativo di sostituire un legislatore assente o, in alcuni casi, troppo inutilmente presente.
Mi fermerò, per ragioni di tempo, nell’esame dei rapporti tra legislazione speciale e reati previsti nel codice penale, all’utilizzo, non sempre corretto, da parte della magistratura, dell’art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose) cui si ricorre sempre più spesso, soprattutto, in tema di inquinamento atmosferico, e con riferimento al più recente fenomeno dell’elettrosmog.
Analizzeremo, per il momento, il rapporto tra legislazione speciale a tutela dall’inquinamento atmosferico e l’art. 674 c.p., 2° parte, secondo cui chiunque “nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo atti a cagionare” gli effetti di cui al 1° comma, cioè “offendere o imbrattare o molestare le persone” è punito con l’arresto fino a un mese e con l’ammenda fino a € 206.
11
Il rispetto delle prescrizioni dell’autorizzazione o dei limiti tabellari, per una parte della giurisprudenza ormai minoritaria, non esonererebbero il titolare dell’impianto, il gestore dell’impianto dalla eventuale responsabilità per il reato di cui all’art. 674: non sarebbe, infatti, consentita dalla legge quell’emissione che supera la soglia della normale tollerabilità ai sensi dell’art. 844 c.c. (tra le altre, Cass. 21 aprile 2005, in Cass. pen. 2006, 2116 ss.; Cass. sez. III 28 settembre 2005, in Dir. giust. 2005/42, 59). A questo risultato si giunge partendo dal presupposto che le norme previste nella disciplina di settore e il 674 c.p. tutelino beni giuridici diversi, presupposto che consentirebbe anche il concorso tra gli illeciti delineati nella legislazione speciale e la fattispecie codicistica.
Altra giurisprudenza, più recente, che oggi può ritenersi prevalente, invece, afferma l’irrilevanza penale delle emissioni inferiori ai limiti previsti da standard legislativi o dalle autorizzazioni rilasciate (Cass. se. III, 31 marzo 2006, in Ambiente, 2006, 921; Cass., sez. III, 9 ottobre 2007 n. 2475). L’espressione “casi non consentiti dalla legge” significa, quindi, in questa prospettiva, necessità che l’emissione avvenga in violazione delle disposizioni previste dalla legislazione speciale. Al di sotto dei limiti previsti dalle norme sull’inquinamento atmosferico, le emissioni che arrechino concretamente fastidio alle persone, non integrano forme di responsabilità penale e possono comportare la sola applicazione della disciplina contenuta nell’art. 844 c.c.
Seguendo, quindi, le indicazioni fornite dalla più recente giurisprudenza, affinché possa configurarsi il reato di cui all’art. 674 c.p. occorre che le immissioni in atmosfera superino i limiti eventualmente fissati dalla normativa speciale e che esse abbiano carattere effettivamente molesto, molestia che ricorrerebbe in tutte quelle situazioni di fastidio, disturbo e comunque “turbamento della tranquillità e della quiete” che producono “un impatto negativo, anche psichico sull’esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione”. Nei casi in cui non esiste una disciplina normativa, la valutazione affidata al giudice penale dovrebbe, in questa prospettiva, aver riguardo al criterio della “stretta tollerabilità” e non della “normale tollerabilità” di cui all’art. 844 c.c. inidoneo ad assicurare protezione adeguata all’ambiente e alla salute e, quindi, per le “molestie olfattive”, in assenza di una normativa di settore e di standard fissati dalla legge, potrebbe trovare applicazione l’art. 674 c.p. “con individuazione del
12
parametro di legalità nel criterio della ‘stretta tollerabilità’ ” (Cass., sez. III, 9 ottobre 2007 n. 2475; Cass. 9 ottobre 2007 n. 41582, in Riv.giur.amb. n. 2 2008, 402 ss.)
Il primo indirizzo seguito dalla giurisprudenza di legittimità, oramai per fortuna da considerarsi minoritario, era in contrasto palese con il principio costituzionale di legalità: attraverso una pura “invenzione” poneva, infatti, il divieto civilistico di cui all’art. 844 c.c. come presupposto della tutela penalistica. L’indirizzo oggi prevalente nella Cassazione penale è, invece, largamente condivisibile ma lascia residuare più di una perplessità quando arriva a sostenere che, in assenza di predeterminazioni legislative di limiti di tollerabilità, le “molestie olfattive” potrebbero rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 674 c.p., individuandosi il parametro di legalità nella “stretta tollerabilità”. Anche in questo caso, infatti, i principi costituzionali di garanzia fissati in materia penale sembrano non rispettati.
Con riferimento, infine, al fenomeno dell’inquinamento elettromagnetico, è noto come questo sia stato solo di recente disciplinato dal legislatore con la l. 36/2001 che all’art. 15, 1° comma prevede che “Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici od elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio di ministri ……. è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1032 a euro 309.874.
Il legislatore, quindi, prevede, con una clausola di riserva, solo un illecito amministrativo per il superamento dei limiti di esposizione. Anche questa volta, la giurisprudenza ha affrontato il problema dell’applicabilità dell’art. 674 c.p. (in questo caso applicabilità della prima parte ) al fenomeno in questione, con esiti contrastanti.
Sul punto, in estrema sintesi - considerata l’attuale incertezza, a livello scientifico, degli effetti sulla salute dell’uomo di questo fenomeno, e considerata anche l’inidoneità del testo legislativo dell’art. 674 (prima parte) a ricomprendere nel proprio ambito l’emissione “molesta” di onde elettromagnetiche - non posso che concordare con quell’orientamento giurisprudenziale (Cass. 27.3.2002 n. 8102) che afferma che “l’emissione di onde elettromagnetiche d’intensità superiore ai limiti fissati dalla vigente normativa non è riconducibile all’ipotesi di reato di cui all’art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose), giacché, a parte la non assimilabilità delle suddette onde alle “cose” cui si riferisce la norma incriminatrice, il superamento dei limiti in questione, essendo
13
questi fissati solo in via meramente cautelare, non può essere riguardato come idoneo, di per sé, a produrre fastidi a persone o pericoli per la loro salute, tanto che lo stesso legislatore ha ritenuto, con l’art. 15 della legge 22 febbraio 2001 n. 36, di sanzionarlo solo in via amministrativa”.
Certamente, specialmente in passato, l’intervento “sostitutivo” della magistratura, che ha utilizzato, a volte in violazione del principio di tassatività, ipotesi criminose del codice penale (assolutamente non concepite in funzione di una difesa dell’ambiente) è servita ad offrire una prima, seppur inadeguata, tutela, soprattutto attraverso gli artt. 635 (danneggiamento) e lo stesso art. 647, ad alcune componenti dell’ambiente (in particolare acqua e aria) ed è servita da stimolo al potere politico. Bisogna, tuttavia, dire che il cammino della legislazione ambientale dagli anni 60 ad oggi è stato sì lungo ed in parte significativo, anche perché in larga parte attuativo di direttive comunitarie, ma, per quanto riguarda la tutela penale, quasi del tutto inutile.
Ormai tutti i codici penali più moderni hanno previsto l’inserimento al loro interno dei reati ambientali utilizzando il modello delittuoso (Germania, Austria, Spagna, Portogallo, Russia). Anche il legislatore comunitario, attraverso la proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sulla tutela penale dell’ambiente, approvata, con alcune modificazioni, dal Parlamento europeo in data 21 maggio 2008 e trasmessa nella stessa data al Consiglio e alla Commissione, obbliga gli Stati membri a prevedere come reati una serie di illeciti contro l’ambiente di particolare gravità. Per questi reati l’originaria proposta di direttiva del 9.2.2007 indicava la necessità di applicare pene anche fino a 10 anni. Oggi, nel testo approvato dal Parlamento europeo (dopo l’intervento della importante sentenza della Corte di Giustizia del 23.10.2007, che ha disposto che “la determinazione del tipo e del livello delle sanzioni penali applicabili (…) non rientra nella competenza della Comunità”), le pene vengono individuate solo come necessariamente effettive, proporzionate e dissuasive.
A questo punto è chiaro che il nostro Paese non può più restare fermo alla tutela formale, alla tutela di funzioni, alla tutela simbolica e che, quindi, deve riprendere, anche se con necessarie modifiche, la via prescelta dal disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei Ministri del precedente governo nella seduta del 22 maggio 2007 di inserimento nel codice penale dei delitti contro l’ambiente (la previsione era quella di inserire tali delitti nel titolo VI-bis del codice). A mio parere, tuttavia, non si
14
deve seguire l’esempio tracciato dalle codificazioni penali più moderne e anche dal nostro progetto di legge delega di normale dipendenza della punibilità dei fatti offensivi dell’ambiente, della salute e della vita dalla violazione di norme o di atti amministrativi. Come ho già messo in rilievo altre volte, in questo modo non si consente una valutazione della responsabilità di chi ha conoscenze ulteriori rispetto ai parametri normativi o di chi comunque deve rispettare la migliore tecnologia disponibile. L’osservanza delle norme di diritto amministrativo non deve poter escludere automaticamente l’antigiuridicità o la tipicità oggettiva o la giuridica rilevanza del nesso causale. Non si deve neanche seguire l’esempio della generica definizione dell’evento lesivo e, in questo senso il nostro disegno di legge delega è sicuramente più preciso rispetto alle formule vaghe di molti codici europei, pensiamo alla formula inquinamento inammissibile del codice portoghese o a quella del pregiudizio grave per l’equilibrio dei sistemi naturali del codice spagnolo o quello del danno significativo all’ambiente del codice penale russo.
Ancora una volta, ripropongo mie antiche, ma penso ancora attuali, considerazioni: tutela penale dell’ambiente come tutela degli equilibri ecologici vitali; precisa descrizione dell’evento; fissazione di standard legislativi estremamente rigorosi, misurati sull’astratta idoneità della condotta o del cumularsi delle condotte, la cui inosservanza determini solo l’applicazione di una sanzione extrapenale. L’osservanza – inosservanza di eventuali standards legislativi potrebbe, da un lato, agevolare il giudice nell’accertamento del nesso causale, dall’altro (tenendo conto anche della misura generica della colpa e della diligenza esigibile da parte dell’individuato autore del fatto) fondare o escludere l’imputazione soggettiva a titolo di colpa.
Resta, infine, (anche secondo l’indicato schema di relazione), da affrontare, sia pur brevemente, il problema della responsabilità degli enti che, anche recentemente, il legislatore comunitario non qualifica necessariamente come penale anche perché una scelta di questo genere contrasterebbe con la Costituzione di diversi paesi membri come il nostro.
E’ noto sul punto che il nostro legislatore ha previsto, con il d.lgs. 231 del 2001, una nuova forma di responsabilità da reato degli enti, definita formalmente come amministrativa ma che, giustamente per la maggioranza della dottrina penalistica, è una responsabilità sostanzialmente penale. Responsabilità molto limitata, all’inizio, con
15
16
riferimento al numero dei reati rispetto ai quali era prevista, e notevolmente ampliata, nel corso di questi ultimi anni, sino a comprendere i reati in materia di sicurezza del lavoro, ma ancora non estesa ai reati ambientali, che, invece, la legge delega del 29 settembre 2000 n. 300 già indicava tra quelli cui riferire questa nuova forma di responsabilità.
E’ anche noto che nel citato disegno di legge delega dell’aprile 2007 si prevede una responsabilità sostanzialmente penale degli enti per i delitti ambientali, attraverso un’estensione dei reati presupposto previsti dal d.lgs. 231/2001, con la strana esclusione, però, dei delitti colposi che, peraltro, sarebbero quelli di più frequente realizzazione.
La scelta di responsabilizzare la persona giuridica anche con riferimento ai reati in materia di ambiente è senz’altro da condividere – e senza l’esclusione dei reati colposi – ma forse, come dico da tempo, la soluzione della responsabilità non solo formalmente amministrativa resta ancora quella preferibile, la sola veramente compatibile con il principio di personalità della responsabilità penale senza possibilità di comode fuoriuscite dal circuito penale della persone fisiche realmente responsabili della politica d’impresa. Il risultato perverso dell’effettività della punizione (anticipata) dell’ente attraverso l’applicazione delle misure cautelari interdittive (che sembra profilarsi nelle prime prese di posizione della giurisprudenza sul d.lgs. 231/2001) o addirittura il rischio della paralisi del processo penale, con conseguente prescrizione degli illeciti delle persone fisiche e degli enti, consigliano di seguire strade diverse da quella della responsabilità penale o, comunque, maggiormente rispettose dei principi costituzionali di garanzia e, nello stesso tempo, adeguate ad una tutela rapida ed efficace degli interessi in gioco.
Prof. Paolo Patrono
ordinario di diritto penale
nell’Università di verona