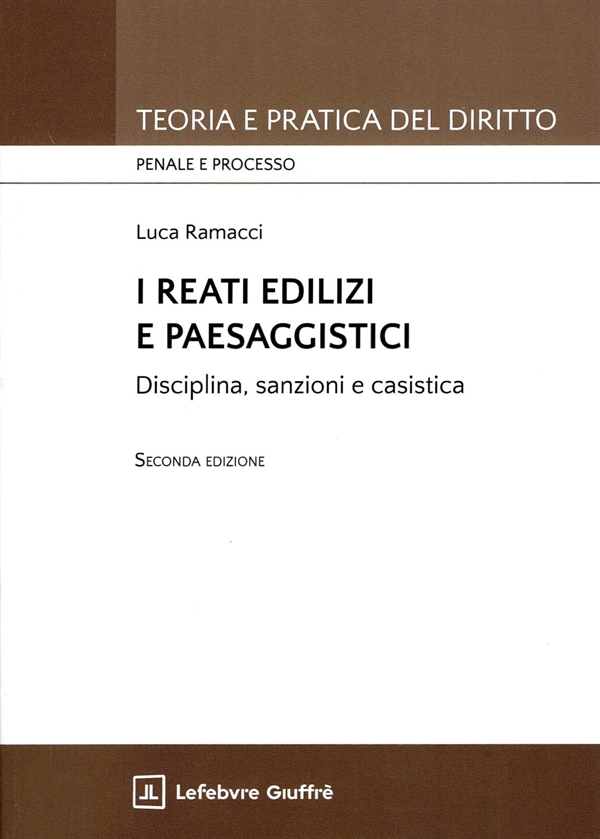La circostanza attenuante del ravvedimento operoso di cui all’art. 452 decies, c.p.: la prima pronuncia della Cassazione
La circostanza attenuante del ravvedimento operoso di cui all’art. 452 decies, c.p.: la prima pronuncia della Cassazione
di Vincenzo PAONE
pubblicato su osservatorioagromafie.it. Si ringraziano Autore ed Editore
Cass. Sez. III Pen. 1° aprile 2025, n. 12514 - Ramacci, pres.; Noviello, est.; Fimiani, P.M. (parz. diff.) - Du.Br. ed a., ric. (Cassa in parte con rinvio App. Roma 27 marzo 2024)
Ambiente - Inquinamento ambientale - Attenuante del ravvedimento operoso.
In tema di inquinamento ambientale, l’attenuante del ravvedimento operoso di cui all’art. 452 decies, comma 1, prima parte, c.p. consiste nella condotta di colui che si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori e perciò fa riferimento a tutti quegli interventi, non preventivamente tipizzati, ma evincibili alla luce dei casi concreti, che si connotino per dar luogo ad una effettiva, quanto concreta interruzione delle conseguenze del reato.
1. Quasi a festeggiare il decennale dell’entrata in vigore della legge n. 68/15, la Cassazione ha sfornato una sentenza in tema di inquinamento ambientale in cui, per la prima volta, prende posizione anche sulla circostanza attenuante del ravvedimento operoso di cui all’art. 452 decies, c. p. con riferimento all’ipotesi di cui alla prima parte del suo comma 1 secondo cui «Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all’articolo 416 aggravato ai sensi dell’articolo 452 octies, nonché per il delitto di cui all’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni1, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi (…)».
La circostanza attenuante in questione non costituisce affatto una novità nel nostro ordinamento: basti pensare alla normativa dettata per contrastare fenomeni associativi terroristici ed eversivi (artt. 1, 4 e 5, legge n. 15/80, oggi trasfusi nell’art. 270 bis.1, c.p.;) nonché mafiosi (art. 8, legge n. 203/91, oggi trasfuso nell’art. 416 bis.1, c.p.), il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, comma 7, d.p.r. n. 309/90) e il contrabbando (art. 291 quater, comma 5, d.p.r. n. 43/73), l’immigrazione clandestina (art. 12, comma 3 quinquies, d.lgs. n. 286/98).
Senza dimenticare altre analoghe norme già presenti nel diritto penale ambientale: l’art. 257, d.lgs. n. 152/06 che, a dire il vero, prevede l’impunità per chi abbia bonificato oppure l’art. 140 stesso decreto che prevede un’attenuante a favore di chi abbia riparato il danno “idrico”; in generale, la possibilità di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino.
La dottrina2 ha giustamente osservato che «La norma si inserisce in un ormai risalente filone premiale tipico dei reati più gravi (terrorismo, mafia, contrabbando di tabacchi, stupefacenti ecc.), ove al bastone di pene severe si contrappone la carota di forti attenuanti: la forbice tra la minaccia di pene aspre e la promessa di trattamenti miti dovrebbe appunto spingere l’agente a tenere condotte riparatorie».
È evidente la ratio di questa normazione e cioè l’esigenza di incentivare il responsabile a provvedere alla riparazione del danno provocato con il reato commesso o all’attenuazione delle sue conseguenze. Come è stato opportunamente sostenuto3, «Dove non è stato possibile prevenire, è necessario (...) incentivare, mediante premi, tutte le attività post delictum che in qualche modo consentano di bloccare il danno e, in alcuni casi, di ripararlo (...)».
2. La decisione n. 12514/2025 si presenta di notevole interesse per aver messo a fuoco i tratti salienti dell’attenuante in parola.
Nella specie, era stato contestato il delitto di cui all’art. 452 bis, c.p. e nel ricorso per cassazione gli imputati lamentavano la mancata applicazione della attenuante ex art. 452 decies, c.p. sostenendo, in particolare, che avevano collaborato alla messa in sicurezza nelle aree oggetto di imputazione per evitare il protrarsi di ulteriori conseguenze del reato.
La Suprema Corte si è misurata con le problematiche legate alla specifica ipotesi di cui alla prima parte del comma 1 dell’art. 452 decies, c.p. senza tuttavia trascurare di esprimere il proprio pensiero sulla confinante ipotesi di risanamento materiale del pregiudizio arrecato.
Orbene, la sentenza ha ritenuto corretto il ragionamento della Corte d’appello che, oltre a sottolineare l’assenza di spontanee iniziative per elidere le conseguenze del reato, aveva spiegato come la sola attività rivendicata dai ricorrenti, diretta a rimuovere i residui ferrosi presenti in loco (diversi dai liquidi inquinanti oggetto di contestazione), fosse stata comunque necessitata, trattandosi di materiale che ostacolava le operazioni di bonifica in corso.
La Cassazione ha evidenziato che la prima condotta contemplata dall’art. 452 decies, c.p. consiste nella condotta di colui che si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori e perciò fa riferimento a tutti quegli interventi, non preventivamente tipizzati, ma evincibili alla luce dei casi concreti, che si connotino per dar luogo ad una effettiva, quanto concreta interruzione delle conseguenze del reato.
In tal senso, si legge in sentenza che «l’uso del verbo adoperarsi, obiettivamente suscettibile di interpretazioni riduttive valorizzanti la mera buona volontà disgiunta dal risultato, deve essere considerato nel quadro dell’ispirazione di fondo della norma – connotata da una prospettiva di risultato – e quindi deve essere valorizzato in una stretta correlazione con l’elisione delle conseguenze ulteriori, posto anche che l’espressione “adoperarsi per” ben può essere intesa anche nel senso, conforme alla interpretazione che qui si prospetta, di “salvaguardare”, come tale implicante un risultato».
La Cassazione ha perciò escluso che potesse rientrare nella previsione dell’articolo in commento l’attività posta in essere dagli imputati per rimuovere i residui ferrosi alla luce del criterio dell’efficacia e concretezza dell’intervento attuato.
Da questo punto di vista, la conclusione è del tutto condivisibile perché il contributo rivendicato dai ricorrenti per “lucrare” l’attenuante era palesemente privo di qualsiasi rilevanza in chiave preventiva.
3. Meno convincente invece è l’ulteriore passaggio della sentenza in cui si sottolinea, per un verso, l’assenza di ogni spontanea iniziativa per elidere le conseguenze del reato e, per altro verso, la necessarietà dell’operazione realizzata dagli imputati in quanto era emerso che il materiale di cui trattasi era stato rimosso solo perché ostacolava le operazioni di bonifica in corso.
Invero, va rilevato che la sentenza in commento, nel rifarsi anche a quanto asserito dal giudice di appello, ha ritenuto che l’attenuante in parola premi chi si è adoperato per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, locuzione utilizzata nell’art. 62, n. 6, c.p.4, mentre, secondo il dato testuale dell’art. 452 decies, c.p., la circostanza attenuante scatta a favore di chi si è adoperato per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori.
La differenza non è marginale perchè la condotta dell’elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato interviene quando il reato si è ormai consumato ed ha esaurito i suoi effetti lesivi che, pertanto, possono soltanto essere rimossi o attenuati. Di contro, l’art. 452 decies, c.p. spinge il responsabile ad assumere iniziative dirette ad evitare le conseguenze ulteriori del reato, purché riguardino il bene tutelato dalla norma incriminatrice.
La norma perciò comprende sia interrompere l’attività criminosa in corso (sul punto, si veda in appresso più diffusamente) sia impedire il verificarsi di risultati lesivi ulteriori rispetto al minimum necessario per perfezionare il reato.
Concentrando ora la nostra attenzione in ordine alla possibile applicazione dell’attenuante di cui trattasi in caso di commissione del delitto di inquinamento ambientale, va ricordato, prima di tutto, che esso costituisce un reato di danno integrato da un evento di danneggiamento indicato con i termini “compromissione” e “deterioramento”.
Come insegna la giurisprudenza5, l’evento consiste in un’alterazione, significativa e misurabile, della originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema, caratterizzata, nel caso della “compromissione”, da una condizione di squilibrio funzionale, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell’ecosistema medesimi e, nel caso del “deterioramento”, da una condizione di squilibrio “strutturale”, connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi.
Il delitto in oggetto è un reato istantaneo che si consuma perciò nel momento in cui si concretizzano gli elementi essenziali dell’ipotesi criminosa. Tuttavia, la giurisprudenza6, riprendendo analoga riflessione maturata in merito al delitto di danneggiamento7, si è interrogata su come inquadrare quelle situazioni in cui al primo evento di danno segue, per effetto della realizzazione della stessa o di analoga condotta abusiva, un ulteriore danno all’ambiente.
Orbene, tenendo conto che, ai fini dell’integrazione del reato di inquinamento ambientale, non è richiesta la tendenziale irreversibilità del danno, fino al momento in cui tale irreversibilità non si verifica8, le condotte poste in essere successivamente all’iniziale “deterioramento” o “compromissione” del bene non costituiscono un “post factum” non punibile, bensì singoli atti di un’unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione del reato con i conseguenti risvolti in tema di decorrenza del termine di prescrizione.
Al definitivo, il delitto di cui all’art. 452 bis, c.p. è un reato istantaneo che può tuttavia configurarsi come reato a consumazione prolungata se le condotte che lo integrano siano ripetute e produttive di successivi effetti lesivi.
In questa ottica, la condotta dell’adoperarsi per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori può svolgere una classica funzione preventiva essendo diretta ad evitare l’ulteriore aggressione al bene giuridico.
In proposito, è stato ipotizzato9 il caso del pubblico ufficiale che fa parte dell’associazione a delinquere che, dopo avere illegittimamente rilasciato un’autorizzazione ambientale, la revochi; o dell’imprenditore che interrompa il traffico organizzato di rifiuti, rinunciando a smaltire rifiuti per i quali non abbia l’autorizzazione, o faccia domanda (e attenda il relativo rilascio) per gestire tipologie di rifiuti fin lì gestite clandestinamente.
Ma si potrebbe anche pensare a comportamenti d’emergenza atti a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente.
Fermo restando che anche queste contro-condotte sono suscettibili di essere valorizzate al fine di attenuare la pena, ci pare giusto prospettare una criticità della norma qui in esame che assegna, anche per gli interventi di entità (necessariamente) inferiore a quelli oggetto della seconda parte dell’art. 452 decies, c.p., riguardanti la riparazione integrale del danno mediante la bonifica e il ripristino dello stato dei luoghi, la stessa notevole attenuazione della pena.
Questa situazione è probabilmente il frutto della tecnica adottata dal legislatore del 201510 che si è evidentemente ispirato alle normative ricordate in esordio, senza però tener conto che in esse il ravvedimento operoso sostanziale è inserito nella stessa disposizione che considera anche la collaborazione processuale il ché logicamente non pone questioni connesse all’uguale trattamento di situazioni oggettivamente diverse.
4. Un altro profilo della sentenza sul quale occorre soffermarsi riguarda la questione se l’art. 452 decies, c.p. richieda un comportamento spontaneo oltre che efficace.
Per la gran parte della dottrina11, la condotta dell’evitare le conseguenze ulteriori non può essere legata ad un atteggiamento di resipiscenza o a motivi interni all’agente perché ciò che rileva è il risultato dell’azione; in senso contrario, ma isolatamente12, è stato detto che la natura speciale della circostanza attenuante in questione rispetto a quella prevista dall’art. 62, n. 6, c.p., comporta la necessità del requisito della spontaneità.
A nostro avviso, il silenzio del legislatore sul profilo qui in esame è significativo e manifesta una precisa – e consapevole – opzione politico-criminale soprattutto perché nello stesso art. 62, n. 6, c.p. la norma prevede una prima ipotesi (l’avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni) che richiede solo la volontarietà dell’azione13; e un’altra ipotesi (l’essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell’ultimo capoverso dell’art. 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato) in cui è testualmente menzionato il requisito della spontaneità, sicché la condotta deve essere determinata da ragioni interne e non opportunistiche.
Per questi motivi, la circostanza attenuante di cui trattasi non richiede la sussistenza di autentici motivi interiori o di ravvedimento morale.
L’altro connotato della condotta “virtuosa” su cui la Cassazione ha preso posizione, e cioè che l’azione non deve essere “coartata” (il che avviene quando la stessa sia imposta dalla legge come, ad esempio, nel caso dell’ordine di ripristino dello stato dei luoghi colpiti da un reato ambientale), ci lascia perplessi proprio in base a quanto argomentato poc’anzi.
Non si ignora la giurisprudenza che si è pronunciata nel senso che la circostanza di cui all’art. 62, n. 6, c.p. non è applicabile al reato edilizio quando la demolizione del manufatto abusivo sia compiuta a seguito dell’accertamento della violazione sia perché manca il requisito soggettivo della spontaneità del ravvedimento, sia perché, nel periodo di mantenimento ed utilizzazione dell’opera, la condotta illecita ha realizzato appieno la propria offensività14.
Di converso, è stato però detto che la circostanza è applicabile se l’imputato provvede alla rimozione spontanea dell’opera abusiva, in assenza cioè di ordinanza di demolizione15; analogamente, è stato ritenuto che l’attenuante si possa applicare, in un caso di realizzazione di discarica abusiva, quando la bonifica volontaria dell’area abusivamente utilizzata sia avvenuta in epoca anteriore al giudizio ed in assenza dell’ordinanza sindacale di bonifica16.
Si tratta di conclusioni ineccepibili tenuto conto che l’art. 62, n. 6, c.p., prescrive che l’adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze del reato debba essere spontaneo. Tuttavia, posto che l’art. 452 decies, c.p. non richiede tale requisito, la condotta riparatoria va apprezzata a favore del soggetto anche se posta in essere a causa di un fattore esterno, tra cui spicca l’eventuale applicazione della sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi secondo il disposto dell’art. 452 duodecies, c.p.17.
Tra parentesi, il questo ragionamento tocca da vicino l’attenuante di cui alla seconda parte del comma 1 dell’art. 452 decies, c.p., ma non si può escludere, per quanto abbiamo prima esposto, che anche l’adoperarsi per evitare l’aggravamento del danno possa avere ad oggetto condotte materiali inquadrabili, ad es., nella messa in sicurezza dei luoghi.
Orbene, l’art. 452 decies c.p. intende favorire l’anticipazione degli interventi che sarebbero comunque oggetto dell’ordine impartito dal giudice18 e perciò, se anche fosse questo il motivo determinante che ha spinto l’agente ad effettuare le opere di risanamento prima del passaggio in giudicato della sentenza, sarebbe irragionevole escludere che tale condotta riparatoria non sia comunque suscettibile di valutazione positiva ai fini della riduzione della pena.
Peraltro, non deve passare sotto silenzio che questa scelta “anticipatoria” espone il soggetto, che potrebbe aver sostenuto anche spese non indifferenti, al rischio segnalato in dottrina19 e cioè «l’eventualità che il reo – dopo aver portato a termine le attività riparatorie descritte dalla norma premiale – possa essere assolto, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, dal reato contestatogli (…) In sostanza, in caso di assoluzione, l’imputato si troverebbe ad avere compiuto, nelle more della sospensione del procedimento penale, quelle attività riparatorie che l’art. 452 duodecies c.p. pone a carico del soggetto condannato per uno dei reati ambientali contestati»20.
In questa prospettiva, appare chiaro come gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza attuati prima della conclusione del processo meritino un “occhio di riguardo” in più.
Va aggiunto che la legge del 2015 contiene un’altra disposizione che risponde ad una logica premiale: l’art. 452 undecies, c.p. prevede infatti che l’istituto della confisca non trovi applicazione nel caso in cui l’imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.
Ne consegue che, anche per questa ragione, sarebbe illogico attribuire al comportamento virtuoso in questione efficacia per evitare la draconiana misura della confisca obbligatoria e negarla per l’applicazione di una semplice attenuante.
5. Anche se la tematica esula leggermente dall’argomento trattato nel presente contributo, è utile segnalare che l’art. 452 decies, c.p. sembra dare rilievo, a differenza dell’art. 452 duodecies, c.p., anche alla sostenibilità economica dell’operazione di ripristino dello stato dei luoghi. Perciò, in astratto, potrebbe fruire dell’attenuante del ravvedimento operoso anche chi, per motivi economici, non sia in grado di procedere al ripristino pur tecnicamente possibile.
La conclusione, certo giustificata dal mero dato letterale – che però non appare decisivo perché l’avverbio tecnicamente manca anche nell’art. 452 undecies, comma 4, sicché potrebbe trattarsi di una mera svista del legislatore – non è invece pienamente giustificata sul piano sistematico e logico.
In primo luogo, perché all’art. 452 duodecies, c.p. va assegnato valore prioritario rispetto alle altre citate disposizioni che, perciò, vanno interpretate avendo come faro illuminante la prima norma; in secondo luogo, perché è immanente nel diritto penale dell’impresa il principio che il garante del bene protetto dalla norma penale debba attuare, a sua protezione, tutte le misure tecnicamente possibili senza subire alcun condizionamento economico.
Peraltro, in dottrina21 è stato osservato che «Il reo che versa in una situazione di particolare difficoltà economica sarà privato della possibilità di beneficiare del considerevole sconto di pena che l’art. 452 decies c.p. subordina al concreto espletamento delle procedure riparatorie. Tale previsione rischia di comportare una evidente disparità di trattamento tra chi ha le possibilità economiche di sostenere le spese della bonifica e chi, invece, non versa in tale condizione. Dietro tale disposizione si cela, dunque, una possibile violazione del canone costituzionale di uguaglianza-ragionevolezza, di cui all’art. 3 Cost.».
Orbene, proprio riconoscendo la non infondatezza di tale considerazione, è rafforzata la tesi, orientata costituzionalmente, che secondo l’art. 452 decies, c.p le attività di ripristino dei siti inquinati debbano essere eseguite con il solo limite della possibilità tecnica di farvi fronte.
6. La sentenza n. 12514/2025 ha riflettuto, infine, sul termine utile perché l’attivazione prestata dal responsabile sia rilevante ai fini della diminuzione della pena.
La Suprema Corte ha preso atto che la disposizione nulla specifica circa il tempo in cui il soggetto debba adoperarsi ai fini ivi descritti, anche se per la distinta, ma analoga, fattispecie della messa in sicurezza, bonifica o ripristino dello stato dei luoghi espressamente l’articolo dispone, come termine ultimo, quello della dichiarazione di apertura del dibattimento, cui si collega, ove le predette attività siano ancora «in corso di esecuzione», anche una sospensione (ex art. 452 decies, comma 2) «del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività (...)».
La Corte ha pertanto concluso che, anche per l’attività di ravvedimento operoso di cui alla prima parte del comma 1 dell’art. 452 decies, c.p. sia logico che la stessa venga quantomeno attivata anteriormente all’inizio del dibattimento.
Un’ultima riflessione riguarda il problema se, avendo la norma indicato nella dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado il termine per il compimento delle condotte riparatorie, sia escluso che l’attenuante possa riconoscersi anche in caso di scelta del giudizio abbreviato o del procedimento di applicazione pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. nei quali la dichiarazione di apertura del dibattimento non è prevista.
La lettera della legge dovrebbe far propendere per la soluzione negativa, però la Cassazione, tenuto anche conto dell’irragionevolezza di tale limitazione a fronte di situazioni eguali, ha preferito abbracciare la tesi opposta per cui «il momento della dichiarazione di apertura del dibattimento segna uno spazio cronologico che ben può comprendere il precedente eventuale verificarsi dei citati procedimenti speciali».
In effetti, se la dichiarazione di apertura del dibattimento ha la funzione di segnare il passaggio allo svolgimento della fase dibattimentale del giudizio ordinario, la stessa funzione di cesura tra una fase e l’altra potrebbe svolgerla, nel giudizio abbreviato, l’ordinanza con cui il giudice ammette il rito speciale (art. 440, comma 1 c.p.p.) oppure il deposito della richiesta (congiunta o di una parte con il consenso dell’altra) di applicazione della pena (art. 444, comma 1 e 2 c.p.p.). La condotta riparatoria va perciò completata non oltre le indicate scadenze processuali.
Ci sembra, infatti, condivisibile l’osservazione della Suprema Corte secondo cui, stante la stretta correlazione tra la dichiarazione di apertura del dibattimento e la sospensione del processo per consentire le attività «di cui al comma precedente» che devono essere in corso di “esecuzione”, si può ragionevolmente escludere che tale sospensione operi nell’ambito dei giudizi speciali, anche in ragione della natura acceleratoria del giudizio.
Vincenzo Paone
1 A questo riguardo, la Corte fa notare che la norma comprende nel novero dei reati per i quali si applica l’attenuante anche il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all’art. 260, d.lgs. n. 152/06: nonostante l’intervenuta abrogazione dell’articolo appena citato, la fattispecie del traffico illecito di rifiuti è attualmente sanzionata dall’art. 452 quaterdecies, c.p. ed è quindi compreso nell’ambito di applicazione dell’art. 452 decies in ragione del richiamo ivi effettuato ai «delitti di cui al presente titolo», tra cui è compreso anche l’art. 452 quaterdecies.
2 Ruga Riva, Diritto penale dell’ambiente, V ed., Torino, 324.
3 Patrono, I nuovi delitti contro l’ambiente: il tradimento di un’attesa riforma, in Legislazione penale, 11 gennaio 2016, 18.
4 In questa prospettiva, se l’art. 452 decies, c.p. avesse descritto la prima tipologia di ravvedimento in termini equivalenti a quanto previsto dall’art. 62, n. 6, c.p., poteva anche determinarsi una sovrapposizione tra questa condotta e quella descritta dallo stesso art. 452 decies come bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
5 Da ultimo, v. Cass. 24 gennaio 2023, n. 17400, Cuffaro, rv. 284.557-01.
6 V. Cass. 27 ottobre 2016, n. 10515, Sorvillo, rv. 269.274-01.
7 V. infatti Cass. 21 ottobre 2010, n. 9343, Valentini, rv. 249.809, secondo cui il termine di prescrizione del reato di danneggiamento, che pure ha natura di reato istantaneo, ha inizio, nel caso in cui le condotte che lo integrano siano frutto non di un unico atto bensì della ripetizione di condotte lesive, dalla commissione dell’ultima condotta, configurandosi nella specie come reato a consumazione prolungata o a condotta frazionata. (Fattispecie in cui la Corte ha precisato che le plurime immissioni di sostanze inquinanti nei corsi d’acqua, successive alla prima, non costituiscono un “post factum” penalmente irrilevante, né singole ed autonome azioni costituenti altrettanti reati di danneggiamento, bensì singoli atti di un’unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione, e quindi l’inizio della decorrenza della prescrizione, fino all’ultima immissione).
8 Il ripristino dello stato dei luoghi è perciò concettualmente incompatibile con l’irreversibilità del danno alla matrice ambientale, qualunque essa sia, per cui la circostanza attenuante è esclusa nei casi di irreversibile distruzione del bene giuridico, come nel caso di disastro ambientale che abbia determinato l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema (art. 452 quater, comma 2, n. 1, c.p.), ovvero di inquinamento ambientale aggravato dalla morte come conseguenza del reato (artt. 452 bis, 452 ter c.p.).
9 Ruga Riva, Diritto penale, cit., 324-325.
10 Come è stato segnalato da Molino, I delitti in materia ambientale, in C. Parodi (a cura di), Diritto penale dell’impresa, vol. II, Milano, 2017, 775, l’art. 452 decies c.p. mescola ipotesi costituenti ravvedimento operoso in senso stretto [«(...) si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori (...)] ad altre inquadrabili come forme di collaborazione premiale processuale [«(...) aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nella individuazione degli autori (...)], ad altre ancora operanti come condotte riparatorie del danno cagionato [«(...) provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi (...)»].
11 Spadano, Il ravvedimento operoso, in Cornacchia - Pisani (diretto da), Il nuovo diritto penale dell’ambiente, Torino, 2018, 241; Molino, I delitti in materia ambientale, cit., 775; Amarelli, La nuova disciplina dei reati ambientali, in Palazzo - Paliero (diretto da), Trattato teorico pratico di diritto penale, vol. XI, Reati contro l’ambiente e il territorio, Torino, 2019, 147.
12 Fimiani, La tutela penale dell’ambiente, Milano, IV ed., 2022, 124.
13 Perciò l’attenuante è applicabile anche quando il soggetto abbia deciso di porre in essere la condotta riparatrice al solo fine di usufruire dell’attenuante stessa.
14 V., da ultimo, Cass. 13 luglio 2011, n. 29991, Crisà, rv. 251.025.
15 V. Cass. 10 marzo 2016, n. 15731, Ledda, rv. 266.585.
16 Cass. 18 aprile 2019, n. 40378, P.F. ed a., in Ambiente e sviluppo, 2019, 934.
17 «Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l’esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all’articolo 197 del presente codice».
18 Così Ruga Riva, Diritto penale, cit., 279.
19 Spadano, Il ravvedimento operoso, cit., 249.
20 La stessa dottrina citata nella nota che precede evidenzia che «nulla esclude che in caso di condanna il reo possa vedersi privato della riduzione di pena prevista dalla norma in commento e, questo, anche nell’ipotesi in cui le procedure riparatorie, dallo stesso eseguite, abbiano sortito esiti positivi. Infatti, il legislatore del 2015 non ha introdotto alcuna disposizione volta ad escludere l’attenuante de qua dal giudizio di bilanciamento delle circostanze. Il giudice, quindi, sarà libero di ritenere la predetta attenuante soccombente od equivalente rispetto ad altre concorrenti aggravanti».
21 Spadano, Il ravvedimento operoso, cit., 249.