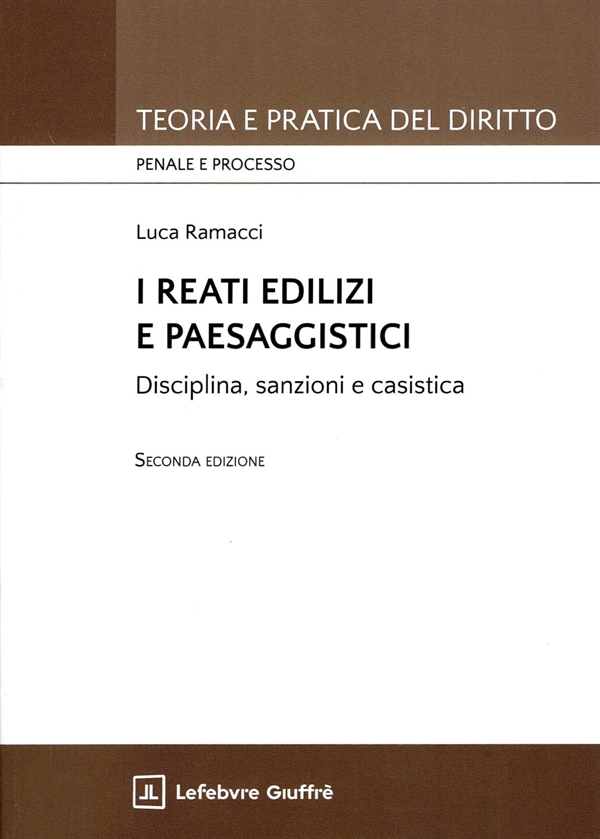Ristrutturazione edilizia e sostituzione edilizia: dal vincolo di continuità alla neutralità morfologica
Ristrutturazione edilizia e sostituzione edilizia: dal vincolo di continuità alla neutralità morfologica
(Commento alle sentenze Cass. Pen., Sez. III, 29 ottobre 2025, n. 35217, e Cons. St., Sez. IV, 4 novembre 2025, n. 8542)
di Antonio VERDEROSA
1. Premessa
Il concetto di ristrutturazione edilizia rappresenta oggi uno degli istituti più dinamici e discussi del diritto urbanistico ed edilizio, al crocevia tra esigenze di rigenerazione urbana, tutela del territorio e disciplina della legalità edilizia. Da attività un tempo “conservativa” e marginale, la ristrutturazione è divenuta progressivamente la forma più diffusa e complessa di trasformazione del costruito, capace di ricomprendere anche la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti. Questa evoluzione è il risultato di un percorso normativo articolato che prende avvio con la Legge 5 agosto 1978, n. 457 , passa attraverso il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell’Edilizia) e giunge alla svolta introdotta dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 , convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Decreto Semplificazioni). Con quest’ultimo intervento, il legislatore ha profondamente innovato l’art. 3, comma 1, lett. d), del Testo Unico, ampliando la nozione di ristrutturazione edilizia e introducendo il principio della neutralità morfologica.
2. Il quadro normativo
Nella formulazione oggi vigente, l’art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. 380/2001 definisce la ristrutturazione edilizia come: “l’insieme di interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”.
Sono ricompresi nella categoria anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti “con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche”, purché sia rispettata la volumetria complessiva preesistente e la morfologia del territorio .
Nei casi di immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), restano invece fermi i vincoli più restrittivi di cui agli articoli 136, comma 1, lett. c) e d) e 142, che impongono la conservazione della sagoma , del sedime e dei prospetti originari.
La distinzione fra ristrutturazione edilizia “leggera” (soggetta a SCIA) e ristrutturazione edilizia “pesante” (soggetta a permesso di costruire) è poi disciplinata dall’art. 10, comma 1, lett. c), dello stesso D.P.R. 380/2001. Quest’ultimo prevede che richiedono il permesso di costruire “gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino anche modifiche della volumetria complessiva o dei prospetti”.
La ristrutturazione edilizia, nel diritto positivo e giurisprudenziale, rappresenta una categoria di trasformazione intermedia tra manutenzione straordinaria e nuova costruzione. Secondo la Corte Costituzionale (sent. n. 303/2003), essa implica la “ricostruzione, anche mediante demolizione e fedele ricostruzione, dell’edificio preesistente, purché ne restino invariati volumetria e sagoma, salvo le modifiche consentite dalla normativa vigente”. Il Consiglio di Stato ha chiarito che: “ La ristrutturazione edilizia comporta un intervento sostitutivo dell’esistente, che tuttavia mantiene un rapporto di continuità con il precedente organismo, distinguendosi dalla nuova costruzione per la persistenza di una quota di preesistenza materiale o funzionale” (Cons. Stato, Sez. IV, 3 aprile 2019, n. 2200). La giurisprudenza penale, in particolare, individua due elementi costitutivi:
-
L’esistenza di un organismo edilizio originario , riconoscibile o ricostruibile;
-
L’intento trasformativo, volto a modificarne struttura, volume o destinazione d’uso.
La dottrina (v. Clarich, Diritto Urbanistico, Il Mulino, 2022) ha ulteriormente evidenziato che la ristrutturazione rappresenta un “momento di equilibrio tra conservazione e innovazione edilizia” , soggetto a titolo differenziato in base all’intensità della trasformazione.
3. La sentenza della Cassazione penale n. 35217/2025: l’aumento volumetrico come criterio qualificante
La Corte di Cassazione, Sezione III penale, con la sentenza 29 ottobre 2025, n. 35217 (udienza 24 settembre 2025, Pres. Ramacci, Rel. Noviello, ric. D’Ippolito), ha ribadito un principio rigoroso in materia di ristrutturazione edilizia, riaffermando la centralità dell’ aumento di volumetria come elemento qualificante dell’intervento “pesante”.
Nel caso concreto, la ricorrente era stata condannata per avere realizzato, in assenza di titolo e in difformità da un permesso in sanatoria, un soppalco abitabile nel sottotetto, con cambio di destinazione d’uso e apertura di nuove finestre. Secondo la Corte, l’intervento – pur non alterando la sagoma esterna – determinava la creazione di nuovi volumi interni abitabili e, quindi, un organismo edilizio “in parte diverso” dal precedente.
Da ciò la qualificazione dell’opera come ristrutturazione edilizia “pesante” , soggetta a permesso di costruire e non a semplice SCIA. Il principio espresso si fonda sull’art. 10, lett. c), del D.P.R. 380/2001 e richiama precedenti consolidati, come Cass. Pen., Sez. III, 7 novembre 2013, n. 48478 (Rv. 258352), che riconosce la creazione di un solaio interpiano come “nuovo volume abitativo”, e Cass. Pen., Sez. III, 23 giugno 2021, n. 24084 , che considera la formazione di nuovi ambienti abitabili quale trasformazione edilizia rilevante.
La Corte ha inoltre sottolineato che tali opere incidono sulle strutture portanti , determinando un aumento del carico statico e richiedendo pertanto la preventiva autorizzazione sismica ex artt. 93, 94 e 95 del D.P.R. 380/2001. L’assenza di tale autorizzazione integra un reato edilizio ai sensi dell’art. 44, lett. b), dello stesso testo normativo.
Infine, la Cassazione ha escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto), in quanto la pluralità di violazioni – edilizie e antisismiche – e la concreta offensività della condotta impediscono di ritenere il fatto di scarsa rilevanza penale.
4. Obblighi antisismici
Sotto il profilo strutturale, l’art. 93 T.U. dispone che “chiunque intenda procedere a costruzioni, sopraelevazioni o riparazioni che possano interessare la staticità dell’edificio deve darne preavviso scritto al competente Ufficio tecnico regionale”. L’art. 94, poi, subordina l’esecuzione dei lavori all’autorizzazione preventiva, mentre l’art. 95 prevede sanzioni penali per chi inizi i lavori senza l’autorizzazione sismica. La giurisprudenza è costante nell’affermare che tali obblighi sussistono anche per le opere interne , ove incidenti sul comportamento statico dell’edificio (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 15 febbraio 2017, n. 7020 ; Cass. Pen., Sez. III, 17 giugno 2020, n. 18628).Nel caso in esame, la Cassazione ha rilevato che la realizzazione del soppalco, aumentando il carico statico e modificando la rigidezza del solaio, rientra pienamente nell’ambito delle opere strutturali, per le quali è necessaria la preventiva autorizzazione ex art. 94. L’omessa richiesta configura, pertanto, violazione dell’art. 95, con conseguente responsabilità penale.
5. La sentenza del Consiglio di Stato n. 8542/2025: la neutralità morfologica e la nuova frontiera della ristrutturazione
Di segno diverso, ma complementare, è la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 novembre 2025, n. 8542 , che affronta il tema della demolizione e ricostruzione e afferma in modo netto il principio della neutralità morfologica .
Il caso riguardava un intervento di demolizione e ricostruzione con modifica di sagoma e sedime, che il Comune aveva qualificato come nuova costruzione , negando il titolo edilizio richiesto come ristrutturazione. Il Consiglio di Stato ha annullato tale diniego, rilevando che – dopo la riforma introdotta dal D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 – la ristrutturazione edilizia non richiede più una continuità fisica o geometrica con l’edificio preesistente, purché si rispetti la volumetria complessiva e si mantenga la coerenza morfologica con il contesto territoriale.
La pronuncia si inserisce nel solco già tracciato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana , con la sentenza n. 422 del 2025, secondo cui la ristrutturazione può ritenersi tale anche in assenza di elementi di “continuità fisica”, quando l’intervento non comporti incremento volumetrico e rispetti l’impianto planimetrico dell’area.
Il Consiglio di Stato individua così un nuovo paradigma interpretativo: la ristrutturazione edilizia non è più una mera ricostruzione fedele, ma una trasformazione neutrale, capace di adattarsi alle esigenze di adeguamento antisismico, efficientamento energetico e accessibilità.
L’unico limite invalicabile resta il divieto di aumento di volumetria , salvo gli incrementi ammessi dagli strumenti urbanistici o da leggi speciali in materia di rigenerazione urbana.
6. Il contributo dottrinale: la ristrutturazione come sostituzione edilizia
Il progressivo ampliamento del concetto di ristrutturazione edilizia trova un riscontro significativo nella riflessione dottrinale, che ne aveva da tempo anticipato gli sviluppi interpretativi e applicativi oggi consolidati nella giurisprudenza amministrativa e penale. Tra i contributi che hanno delineato tale evoluzione si annoverano gli scritti dell’autore pubblicati su LexAmbiente, nei quali è stato analizzato in modo sistematico il rapporto tra ristrutturazione, demolizione-ricostruzione e sostituzione edilizia, proponendo una lettura organica e coerente con la più recente normativa in materia di rigenerazione urbana.
Già nel contributo del 12 febbraio 2013, dal titolo «Urbanistica. La sostituzione edilizia costituisce una modalità spinta della ristrutturazione edilizia» (LexAmbiente, sezione Urbanistica), l’autore sosteneva che la sostituzione edilizia – intesa come demolizione e ricostruzione del manufatto preesistente, anche con modifiche planivolumetriche o tipologiche – rappresenta una forma avanzata della ristrutturazione edilizia. In tale prospettiva, la sostituzione edilizia non costituisce una categoria autonoma, bensì un’estensione fisiologica della ristrutturazione stessa, in coerenza con la ratio dell’art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 380/2001.
La finalità sottesa a tale interpretazione è quella di favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente, senza alterare la volumetria complessiva e senza determinare ulteriore consumo di suolo, in piena aderenza ai principi di sostenibilità ambientale e di rigenerazione urbana.
Il tema viene ulteriormente sviluppato nell’articolo del 22 maggio 2015 , «L’evoluzione del concetto di ristrutturazione edilizia dalla L. 457/1978 sino ai Decreti del Fare e Sblocca Italia» (LexAmbiente – Dottrina Urbanistica), in cui l’autore ricostruisce in modo puntuale l’evoluzione normativa dell’istituto: dalla definizione originaria contenuta nella L. 457/1978 fino alle riforme introdotte dal D.L. 69/2013 (Decreto del Fare) e dal D.L. 133/2014 (Sblocca Italia). Già in quella sede si osservava come il legislatore avesse progressivamente ampliato l’ambito della ristrutturazione, includendovi le operazioni di demolizione e ricostruzione con sagoma diversa, purché venissero rispettati i parametri volumetrici e il contesto paesaggistico, anticipando di fatto le innovazioni poi formalizzate con il D.L. 76/2020, convertito nella L. 120/2020.
Un ulteriore approfondimento si rinviene nell’articolo del 29 novembre 2022 , «Semplificazione edilizia e rigenerazione urbana per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente in Campania» (LexAmbiente – Dottrina Urbanistica), dove l’autore inquadra la sostituzione edilizia all’interno delle politiche di rigenerazione urbana e di semplificazione amministrativa introdotte a livello regionale e statale. In tale prospettiva, la sostituzione edilizia è letta come strumento operativo della rigenerazione urbana: un intervento di demolizione e ricostruzione che, pur alterando sagoma o sedime, conserva la volumetria complessiva e ripristina l’equilibrio morfologico del tessuto urbano, migliorando nel contempo la qualità architettonica e la sicurezza sismica degli edifici.
L’articolo «Urbanistica. Demo-ricostruzione con modifica di sagoma e prospetti» (LexAmbiente, 24 febbraio 2023) ha chiarito esplicitamente che, nell’ambito dell’art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (nella versione vigente post D.L. 76/2020 e D.L. 17/2022 ), sono ricomprese le demolizioni e ricostruzioni con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, in quanto rientranti nella ristrutturazione edilizia, a condizione che si rispetti la volumetria complessiva preesistente.
Il contributo più recente, «Edilizia libera, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e art. 119, comma 13-ter, del D.L. 34/2020» (LexAmbiente – Dottrina Urbanistica, 26 gennaio 2024), offre un aggiornamento sistematico alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni del 2020.
Qui l’autore evidenzia che la nuova formulazione dell’art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 380/2001 segna una svolta concettuale: la ristrutturazione edilizia diventa un intervento di trasformazione morfologica neutrale, capace di comprendere anche le ricostruzioni con diversa sagoma, sedime, prospetti o caratteristiche tipologiche, purché nel rispetto del volume preesistente.
Si tratta, dunque, di una definizione funzionale e non più fisica , in cui l’elemento determinante è la neutralità volumetrica e la coerenza urbanistica, non la riproduzione fedele dell’edificio originario.
In questa cornice, la sostituzione edilizia viene riletta come la manifestazione più evoluta della ristrutturazione, idonea a coniugare tre dimensioni fondamentali:
-
Tutela del territorio: la ristrutturazione/sostituzione edilizia conserva la volumetria complessiva, evita nuovo consumo di suolo ed è coerente con i principi di sostenibilità urbana.
-
Riqualificazione funzionale e tecnologica: demolizione e ricostruzione consentono di superare l’obsolescenza strutturale, energetica e distributiva, realizzando edifici più sicuri, efficienti e fruibili.
-
Semplificazione procedurale: in un quadro regolamentare che privilegia la modernizzazione del patrimonio edilizio esistente (cfr. D.L. 76/2020 , convertito in L. 120/2020), la ristrutturazione diventa uno strumento operativo chiave per la rigenerazione, riducendo le rigidità burocratiche e ampliando le possibilità progettuali.
Questa impostazione si rivela oggi perfettamente coerente con l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 novembre 2025, n. 8542 , che recepisce e consolida sul piano giurisprudenziale la logica della neutralità morfologica. Il Consiglio, infatti, supera il tradizionale dogma della continuità fisica tra vecchio e nuovo fabbricato e riconosce la legittimità della demolizione e ricostruzione con modifiche planivolumetriche, purché l’intervento non generi aumento di volumetria e rispetti il contesto territoriale.
Tale visione, peraltro, non contrasta con la lettura fornita dalla Cassazione penale, n. 35217/2025 , che mantiene un approccio rigoroso sul piano tecnico-strutturale e sanzionatorio, sottolineando la necessità di un controllo effettivo sugli interventi che comportano un incremento volumetrico – anche interno – o un’incidenza sulle strutture portanti.
La dottrina, dunque, conferma quanto oggi emerge anche dalla giurisprudenza: la ristrutturazione edilizia si configura sempre più come sostituzione edilizia regolata, ovvero come una ricostruzione morfologicamente neutra e funzionalmente migliorativa, che rappresenta la sintesi tra tutela, innovazione e sostenibilità. Essa non è più mera “conservazione dell’esistente”, ma uno strumento attivo di rigenerazione urbana e di riqualificazione del patrimonio costruito, perfettamente in linea con gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo, efficienza energetica e sicurezza antisismica previsti dalle più recenti politiche nazionali ed europee.
7. Confronto interpretativo tra Cassazione e Consiglio di Stato
L’analisi comparata delle due pronunce del 2025 consente di individuare una diversa prospettiva interpretativa, pur all’interno di un quadro normativo comune.
La Cassazione penale n. 35217/2025 affronta la questione in chiave strutturale e sanzionatoria, ponendo l’accento sull’aumento volumetrico – anche interno – come elemento decisivo per distinguere la ristrutturazione leggera da quella pesante. La Corte mira a garantire la sicurezza statica e antisismica dell’edificio e la legalità formale dell’intervento, sottolineando la necessità del titolo edilizio e delle autorizzazioni strutturali previste dagli artt. 93-95 del D.P.R. 380/2001.
Il Consiglio di Stato n. 8542/2025, invece, adotta una prospettiva urbanistica e funzionale, orientata alla rigenerazione urbana e alla semplificazione amministrativa . L’attenzione è rivolta non alla forma del manufatto, ma alla sua coerenza volumetrica e territoriale: ciò che rileva non è la “continuità fisica” del fabbricato, ma la “neutralità morfologica” dell’intervento rispetto al contesto. Laddove la Cassazione guarda al contenitore edilizio e ai suoi effetti strutturali, il Consiglio di Stato considera la funzione urbanistica dell’opera e il rispetto delle invarianti ambientali.
Le due pronunce, dunque, non si contrappongono ma si integrano: la prima presidia la legalità edilizia e la sicurezza costruttiva; la seconda amplia l’orizzonte della ristrutturazione come strumento di rigenerazione urbana. In entrambe, la volumetria complessiva resta il limite invalicabile che separa la ristrutturazione dalla nuova costruzione.
8. Conclusioni
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale maturato negli ultimi anni, la ristrutturazione edilizia si impone come l’istituto cardine della trasformazione urbana contemporanea , non più confinato all’ambito della conservazione edilizia ma proiettato verso una dimensione di rigenerazione sostenibile del territorio .
Le due pronunce analizzate rappresentano, da prospettive complementari, i pilastri interpretativi di questo processo evolutivo. Da un lato, la Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 35217 del 29 ottobre 2025 , riafferma il principio di rigore tecnico e conformità strutturale , ribadendo che ogni trasformazione edilizia che comporti un incremento volumetrico o incida sulle strutture portanti deve essere eseguita nel rispetto dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni antisismiche di cui agli artt. 93, 94 e 95 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. La Corte tutela la dimensione di legalità sostanziale dell’attività edilizia, ricordando che la sicurezza statica e il rispetto delle norme tecniche costituiscono presidi essenziali dell’interesse pubblico.
Dall’altro lato, la Sezione IV del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8542 del 4 novembre 2025, consolida il principio della neutralità morfologica, che segna il definitivo superamento del tradizionale “dogma della continuità fisica” tra fabbricato originario e ricostruito.
L’intervento di demolizione e ricostruzione, anche con diversa sagoma, sedime, prospetti e caratteristiche planivolumetriche, è ora pienamente inquadrato nella ristrutturazione edilizia, a condizione che sia rispettata la volumetria complessiva preesistente e la coerenza morfologica con il contesto territoriale (art. 3, comma 1, lett. d, D.P.R. 380/2001, come modificato dal D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020).
Sul piano dottrinale, le analisi già pubblicate su LexAmbiente hanno tracciato con coerenza questa stessa traiettoria evolutiva, leggendo la ristrutturazione edilizia come sostituzione edilizia sostenibile : una forma di trasformazione regolata che unisce innovazione tecnologica, sicurezza strutturale, efficienza energetica e tutela ambientale . Gli interventi di demolizione e ricostruzione, dunque, non rappresentano più una “rottura” rispetto all’edificio preesistente, ma la sua naturale rigenerazione funzionale, in linea con le politiche europee di decarbonizzazione e con i principi di contenimento del consumo di suolo espressi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e nella Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.
Ne emerge una concezione unitaria e dinamica della ristrutturazione edilizia:
-
sul piano tecnico-giuridico, come insieme coordinato di opere soggette a regole di sicurezza, competenza e controllo;
-
sul piano urbanistico-funzionale, come strumento di rigenerazione e riequilibrio del tessuto urbano;
-
sul piano valoriale, come espressione di sostenibilità ambientale, innovazione e responsabilità pubblica.
La ristrutturazione edilizia, così interpretata, non è più un atto di mera conservazione o di manutenzione straordinaria dell’esistente, ma diventa il principale vettore della rigenerazione urbana e della riqualificazione del patrimonio edilizio , in grado di conciliare legalità, efficienza e qualità architettonica. È questa la prospettiva, ormai condivisa da dottrina e giurisprudenza, di un’edilizia che evolve da attività “autorizzata” a funzione pubblica di interesse generale , orientata alla sicurezza, alla sostenibilità e alla valorizzazione del territorio.