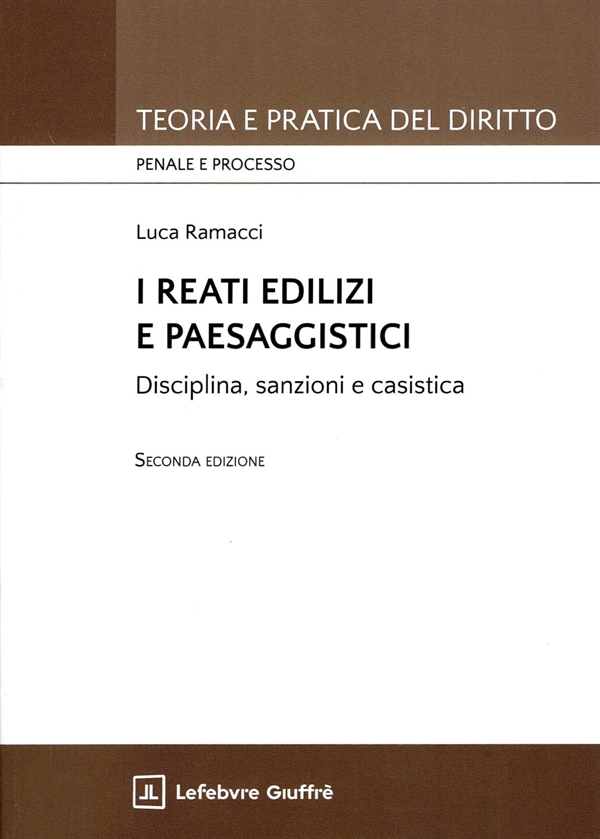Il presupposto della disponibilità giuridica nei procedimenti ambientali
Il presupposto della disponibilità giuridica nei procedimenti ambientali
di Oreste PATRONE
Nel contesto dei procedimenti autorizzativi in materia ambientale, uno dei temi frequentemente sollevati riguarda la titolarità delle aree su cui insistono gli impianti progettati. Può un soggetto non ancora proprietario di un terreno ottenere l’autorizzazione a realizzarvi un impianto? La risposta, alla luce della normativa vigente e della consolidata giurisprudenza amministrativa, è affermativa e merita un approfondimento.
Diversamente da quanto avviene in ambito edilizio, dove il rapporto tra la disponibilità del bene oggetto di trasformazione e il titolo abilitativo è esplicitamente disciplinato dalla normativa, nel settore ambientale il legislatore non ha definito in modo chiaro tale connessione. Il DPR 380/2001 – Testo Unico dell’Edilizia – all’articolo 11, comma 1, stabilisce infatti che il permesso di costruire può essere rilasciato non solo al proprietario dell’immobile, ma anche a “chi abbia titolo per richiederlo”.
Occorre rilevare, nondimeno, che il titolo sostitutivo rappresentato dall’Autorizzazione Integrata Ambientale non si limita a cumulare gli effetti giuridici dei titoli assorbiti, ma ne recepisce anche i presupposti sostanziali di rilascio. In tale prospettiva, l’AIA, in quanto sostitutiva del permesso di costruire e degli ulteriori titoli abilitativi, incorpora il requisito della disponibilità giuridica delle aree interessate, che deve ritenersi presupposto della sua legittima adozione. Ne deriva, dunque, che l’accertamento della titolarità o della legittima disponibilità dei terreni non costituisce un profilo estraneo al procedimento ambientale, bensì un elemento ad esso immanente, che l’autorità competente è tenuta a verificare al pari degli altri presupposti autorizzativi.
Secondo l’interpretazione giurisprudenziale prevalente, quella formula ampia va intesa come riferita non solo a titolari di diritti reali, ma anche a soggetti che vantano una relazione giuridica qualificata con l’immobile. Tra questi, rientrano ad esempio il promissario acquirente, il titolare di un diritto personale di godimento o l’intestatario di un contratto di comodato, purché il titolo consenta l’esecuzione dell’opera.
Il Consiglio di Stato ha chiarito in più occasioni [sentenze n. 1947/2005, n. 144/2010, n. 4818/2014] che il promissario acquirente può legittimamente richiedere il permesso di costruire, a condizione che il preliminare contenga il consenso del proprietario alla realizzazione delle opere.
Il contratto preliminare di compravendita, quando corredato da esplicito assenso alla realizzazione delle opere, costituisce un titolo giuridicamente rilevante. L’art. 2932 del Codice civile attribuisce efficacia specifica a tale atto, che può essere reso esecutivo con sentenza, configurando così una disponibilità giuridica sufficiente ai fini del rilascio del titolo edilizio e, per estensione, dell’autorizzazione ambientale.
Un ulteriore argomento a favore della legittimazione si rinviene nella disciplina speciale dei rifiuti.
L’art. 177, comma 2, del D.lgs. 152/2006 qualifica l’attività di gestione dei rifiuti come attività di pubblico interesse. Non solo: l’art. 208, comma 6, dello stesso decreto stabilisce che l’approvazione del progetto comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. Ciò apre alla possibilità, in caso di necessità, di attivare le procedure espropriative previste dal DPR 327/2001, anche a favore di soggetti privati, proprio in virtù della natura pubblicistica dell’attività di gestione dei rifiuti. In questo quadro, la proprietà non solo non è requisito essenziale, ma può essere surrogata da strumenti giuridici messi a disposizione dal legislatore per tutelare l’interesse collettivo.
La disponibilità dell’area, intesa in senso ampio, rappresenta dunque un presupposto sufficiente per l’ottenimento dell’autorizzazione ambientale. La proprietà, dunque, non è condizione necessaria per l’avvio del procedimento autorizzativo, soprattutto quando l’intervento risponde a un interesse pubblico e si fonda su atti contrattuali validi e trasparenti.