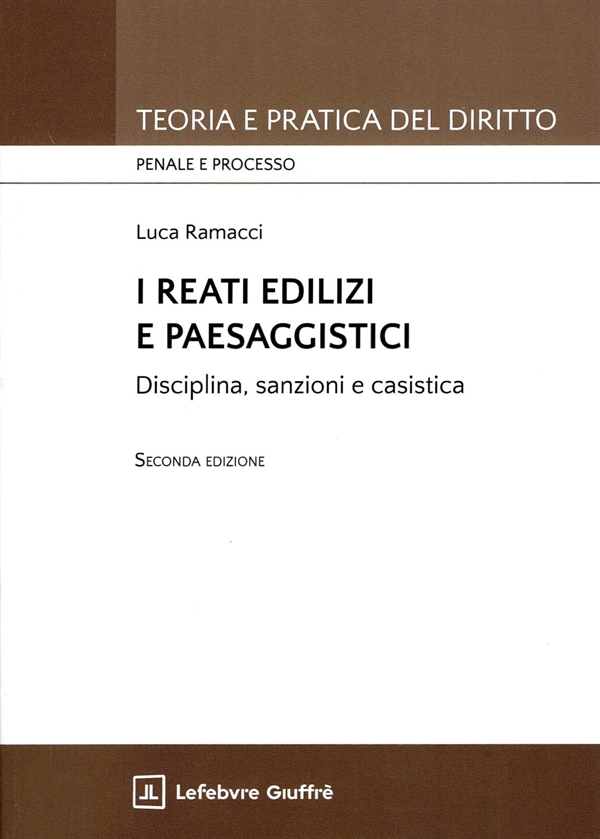Consiglio di Stato Sez. VII n. 5753 del 3 luglio 2025
Consiglio di Stato Sez. VII n. 5753 del 3 luglio 2025
Rifiuti.Rapporti tra procedimento penale e amministrativo
Deve ritenersi irrilevante l’assoluzione in sede penale riportata da una società per imputazioni varie, relative alle operazioni di trattamento dei rifiuti autorizzate nell’impianto di smaltimento da essa gestito, tra cui la miscelazione non autorizzata per partite non omogenee. Nella sede amministrativa, concernente il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell’art. 29-octies, comma 3, lett. a), del testo unico ambientale, si controverte in ordine al distinto profilo concernente la conformità a legge delle misure imposte dall’autorità competente per il legittimo scopo di migliorare il rendimento ambientale dell’impianto di smaltimento dei rifiuti, nell’ambito dell’ampia discrezionalità a quest’ultimo attribuita dalla legge, e sulla base degli elementi di carattere tecnico a disposizione, perché forniti dal soggetto autorizzato o acquisiti attraverso gli appositi controlli di legge. In questo ambito, la mancata dimostrazione in sede penale del superamento dei limiti autorizzati allo scarico non vale evidentemente ad elidere il potere amministrativo di disciplina delle attività di trattamento dei rifiuti nell’ambito dell’impianto autorizzato, il quale anzi si pone nella medesima direzione di raggiungere gli obiettivi di carattere ambientale penalmente tutelati.
Pubblicato il 03/07/2025
N. 05753/2025REG.PROV.COLL.
N. 04677/2023 REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Corbyons e Maria Cristina Mattiacci, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Cicerone 44
contro
Provincia autonoma di Trento, in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Marialuisa Cattoni e Sabrina Azzolini, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, non costituita in giudizio
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO n.-OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento;
Vista l’ordinanza istruttoria del 31 ottobre 2024, n. 8700;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. del giorno 4 giugno 2025 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Corbyons, Mattiacci e Azzolini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società appellante indicata in intestazione, titolare in -OMISSIS-di uno stabilimento in cui sono smaltiti rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi per conto terzi, a suo tempo autorizzato dalla Provincia autonoma di Trento -OMISSIS-, impugna nel presente giudizio l’autorizzazione integrata ambientale rilasciatale dall’amministrazione provinciale all’esito del procedimento di riesame ex art. 29-octies, comma 3, lett. a), del c.d. testo unico ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Il provvedimento impugnato, di cui alla determinazione -OMISSIS- era adottato all’esito del procedimento a sua volta avviato in seguito dell’emanazione delle nuove BAT (best available techniques) di riferimento per l’attività, con decisione di esecuzione della Commissione europea 2018/1147/UE del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
3. Con il proprio ricorso, proposto in primo grado davanti al Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Provincia di Trento, la società censurava le prescrizioni contenute nell’allegato 2 alla determinazione provinciale da ultimo citata (intitolato «Valori limite, frequenza, metodiche di controllo e prescrizioni gestionali»), nel presupposto del loro carattere innovativo rispetto all’autorizzazione previgente e della loro illegittimità sotto plurimi profili: innanzitutto perché introdotte sulla base di un acritico recepimento della consulenza tecnica d’ufficio disposta nell’ambito delle indagini penali per varie ipotesi di reato riferite alla gestione dell’impianto, le quali avevano portato a disporre il sequestro preventivo della linea di trattamento chimico-fisico di rifiuti dell’impianto; ed inoltre in violazione della normativa di legge relativa allo smaltimento dei rifiuti ed eccedenti le richiamate BAT di riferimento; ed ancora sproporzionate e tali da comportare ingiustificati aggravi gestionali e di costi in conto capitale e di esercizio dell’attività. Erano ulteriormente contestati i termini assegnati dal provvedimento autorizzativo impugnato per recepire le prescrizioni.
4. Con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione le censure erano giudicate infondate e dunque respinte, ad eccezione di quelle concernenti i termini di adempimento di alcune prescrizioni considerate innovative.
5. Contro la pronuncia di primo grado la società ricorrente ha proposto appello, al quale resiste la Provincia autonoma di Trento.
DIRITTO
1. Con un primo ordine di censure si contestano le considerazioni svolte dalla sentenza in premessa rispetto all’esame dei motivi di impugnazione. Un primo errore consisterebbe nel non avere ricavato dall’incontroverso fatto che le BAT relative alla previgente autorizzazione integrata ambientale erano pressoché integralmente applicate, come attestato nell’allegato 1 al provvedimento impugnato (intitolato «rapporto istruttorio»), la logica conseguenza per cui le prescrizioni imposte ex novo all’esito del riesame dell’autorizzazione sarebbero esorbitanti da esse e avrebbero dovuto essere sorrette da una motivazione chiara ed adeguata. Un secondo errore consisterebbe nell’avere supposto che con l’istanza di consulenza tecnica d’ufficio o di verificazione formulata dalla difesa della ricorrente in primo grado si sarebbe sollecitato un sindacato di tipo sostitutivo di merito sulle valutazioni tecnico-scientifiche dell’amministrazione, quando invece la richiesta istruttoria era stata formulata solo in via subordinata, rispetto a deduzioni, corroborate dall’offerta di prove di carattere tecnico, già in tesi idonee ad evidenziare i plurimi profili di eccesso di potere da cui sarebbero affette le prescrizioni censurate. Al medesimo riguardo si aggiunge che la consulenza tecnica d’ufficio e la verificazione sono mezzo istruttori pienamente utilizzabili in sede giurisdizionale amministrativa in caso di dubbio sull’attendibilità delle valutazioni tecniche dell’amministrazione e dunque si sostanziano in strumenti di sindacato della discrezionalità tecnica sul piano della sua legittimità.
2. Con un secondo motivo d’appello sono riproposte le censure nei confronti della consulenza tecnica d’ufficio svolta nel parallelo procedimento penale ed acriticamente recepita dall’amministrazione nella formulazione delle contestate prescrizioni. Si assume che sull’atto istruttorio penale si fonderebbero gran parte delle contestate prescrizioni, e che si sarebbe così violato l’obbligo di sottoporre lo stesso ad un vaglio critico. Viene al riguardo sottolineato che l’obbligo è stato imposto dallo stesso Tribunale di primo grado nel precedente tra le parti di cui alla sentenza -OMISSIS-resa su ricorso della società contro la nota provinciale -OMISSIS-, di richiesta di integrazione istruttoria); e che un vaglio analogo è stato svolto nella sede penale medesima, nel dibattimento seguito alle indagini nell’ambito del quale la consulenza tecnica è stata disposta. Sul punto viene prospettata la contraddittorietà della sentenza, per un verso, per avere riconosciuto che almeno due prescrizioni, tra cui quella concernente il divieto di miscelare i rifiuti, fanno espresso riferimento alla consulenza tecnica, e nondimeno avere respinto le censure svolte sul punto; e per altro verso l’illogica e insufficiente motivazione della pronuncia di primo grado, per non avere considerato che nella presente sede processuale è stata la stessa amministrazione provinciale a riconoscere di avere utilizzato la consulenza in sede di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale. Sul punto, la sentenza avrebbe inoltre erroneamente supposto che il riesame ex art. 29-octies del testo unico ambientale si sarebbe svolto «in piena autonomia dal procedimento penale»; e in particolare che la consulenza tecnica sarebbe stata utilizzata nella diversa sede amministrativa solo in relazione a fatti che «rilevano nella loro oggettività», senza tuttavia spiegare quali sarebbero questi fatti oggettivi. Ne deriverebbe che, al di là dell’intrinseca inattendibilità della consulenza, il suo utilizzo violerebbe l’art. 29-octies, comma 5, del testo unico ambientale, il quale demanda all’autorità competente di utilizzare «le informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni», nel caso di specie non svolti. A conferma dell’acritico recepimento della consulenza tecnica ai fini del riesame dell’autorizzazione integrata ambientale si sottolinea che numerose e puntuali sono state le prove addotte in giudizio sugli errori di carattere tecnico-scientifico da cui sarebbe affetto l’atto istruttorio e dunque le prescrizioni che su di essa si basano. Nondimeno - si lamenta - le stesse sono state immotivatamente considerate come «apodittiche» dalla sentenza di primo grado. Del pari quest’ultima avrebbe erroneamente supposto che dalla motivazione del provvedimento impugnato si evince che nel procedimento di riesame sono state valutate le proposte di carattere tecnico formulate dalla società ricorrente alla luce delle nuove BAT, senza ricavare da ciò la logica conseguenza per cui le contestate prescrizioni sarebbero quindi ingiustificate sul piano tecnico. A questo riguardo si ribadisce che il sopra menzionato allegato 1 al provvedimento impugnato «certifica che la quasi totalità delle BAT sia stata già applicata» vigente la precedente autorizzazione integrata ambientale. La medesima pronuncia appellata avrebbe quindi falsamente applicato gli artt. 29-octies, comma 5, e 29-decies, comma 3, del testo unico ambientale, sulla base di una «inammissibile identificazione» tra la consulenza tecnica svolta in sede penale e controlli e alle ispezioni della competente autorità amministrativa (Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente - APPA), risalenti al biennio -OMISSIS-. Per essi si assume la loro sopravvenuta inefficacia a decorrere dal -OMISSIS-, con l’adozione da parte dell’amministrazione provinciale di una diffida -OMISSIS- e nell’aggiornamento d’ufficio dell’autorizzazione integrata ambientale (determinazione provinciale-OMISSIS-. Ne deriverebbe pertanto che gli accertamenti amministrativi in questione non avrebbero potuto giustificare le contestate prescrizioni in sede di riesame dell’autorizzazione.
3. Con riguardo a queste ultime, con un ulteriore motivo d’appello sono riproposte le censure di violazione dell’art. 29-septies del testo unico ambientale e di carenza di istruttoria e motivazione a base delle nuove prescrizioni, che si sottolinea essere «“più rigorose” rispetto alla normativa vigente e alle BAT senza che ne ricorressero i presupposti di legge». Al riguardo la statuizione di rigetto resa in primo grado sarebbe erroneamente basata sull’apodittico assunto secondo cui nessuna di esse «è più rigorosa» delle nuove BAT per il trattamento dei rifiuti introdotte con la sopra citata decisione di esecuzione 2018/1147/UE del 10 agosto 2018. La prova contraria sarebbe ricavabile sul piano documentale dal fatto che, come sopra esposto, il più volte richiamato allegato 1 al provvedimento impugnato dà atto che tutte le BAT applicabili erano già applicate nell’impianto gestito dalla società ricorrente, con la sola eccezione delle nn. 7 e 23, applicate parzialmente. Su questa base sarebbe dunque violata la disposizione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da ultimo richiamata, il quale ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2, consente «misure supplementari particolari più rigorose», ma solo nei casi tassativi ivi previsti, nel caso di specie nemmeno prospettati nel provvedimento impugnato, né tanto meno in sede istruttoria, nell’apposita conferenza di servizi.
4. Sono poi riproposte le censure di motivazione carente a base delle prescrizioni previste dall’allegato 2 al provvedimento impugnato. Sarebbe al riguardo generico e pertanto insufficiente il richiamo contenuto nella parte generale alla sopra menzionata decisione2018/1147/UE, di approvazione delle nuove BAT per il trattamento dei rifiuti e all’altrettanto indefinito «confronto con impianti simili autorizzati nelle Regioni limitrofe». Viene poi sottolineato che si tratta di misure di carattere discrezionale, come peraltro evincibile dalla perplessa motivazione della sentenza di primo grado, che nel respingere le censure ha nondimeno riconosciuto che le precedenti prescrizioni sono state «riviste nella formulazione» e/o oggetto di «rivalutazione». Se ne trae il corollario per cui per esse sarebbe configurabile «un obbligo di motivazione stringente», nel caso di specie non assolto.
5. Quindi, sono riproposte le censure nei confronti delle singole prescrizioni.
6. Innanzitutto quella sub c), con cui è stato imposto di «controllare che i rifiuti in entrata all’impianto in oggetto, ai fini dell’eventuale caratterizzazione chimico-fisica, siano già stati campionati ed analizzati da parte del produttore secondo quanto disposto dall’art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998 e dall’art. 7 del D.M. 12 giugno 2002, n. 161» (c). Vengono al riguardo prospettati profili di eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di proporzione, desumibili dagli oneri gestionali da essa derivanti, ulteriori rispetto a quelli di mero controllo dei rifiuti in ingresso. Si assume in primo luogo che l’innovativo obbligo di verifica che i produttori che conferiscono rifiuti nell’impianto li abbiano campionati ed analizzati secondo la citata normativa ministeriale sarebbe privo di plausibile giustificazione sul piano tecnico, posto che l’impianto gestito dalla ricorrente non svolge attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata ex art. 214 e 216 del testo unico dell’ambiente. Inoltre, contrariamente all’assunto della sentenza secondo cui la prescrizione sarebbe riproduttiva di quella già applicata, si oppone che in base ad essa il controllo del gestore dell’impianto era in precedenza limitato alla corretta individuazione dell’operazione di smaltimento, ai sensi dell’allegato D, alla parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e della classificazione (cioè l’indicazione del codice CER) per lo specifico rifiuto, mentre per effetto della nuova prescrizione ricadrebbe sul gestore dell’impianto di smaltimento anche il controllo del campionamento e delle analisi, e quindi di operazioni che il produttore svolge prima di (e per) individuare l’operazione di smaltimento e la classificazione del rifiuto. Sarebbe del pari erronea la giustificazione tecnica a base della contestata prescrizione individuata dalla sentenza di primo grado, ovvero quella di assicurare l’attendibilità dell’omologa dei rifiuti, in relazione alla quale si oppone che essa non richiede «ripercorrere i passi svolti dal produttore per indicare le corrette caratteristiche al rifiuto a partire dalle analisi e dal campionamento», secondo la normativa tecnica prevista dalla normativa ministeriale richiamata dalla prescrizione (UNI 10802). Quindi, lungi dal porsi nella limitata prospettiva di una verifica di carattere documentale, a specificazione delle vigenti prescrizioni, come del pari supposto dalla pronuncia di primo grado, si sostiene che la prescrizione contestata determinerebbe un’illegittima restrizione di mercato, per via dell’obbligo per il gestore dell’impianto, privo di base normativa, di respingere i rifiuti ivi conferiti non conformi. Del pari sarebbe erronea la supposizione del carattere vincolante della citata normativa tecnica, in quanto smentita dalle stesse BAT di riferimento (BAT reference document for Waste Treatment - BRef -OMISSIS-) ed inoltre dalla giurisprudenza di legittimità penale. Diversamente da quanto sul punto statuito dalla sentenza di primo grado non varrebbe infatti a conferire carattere vincolante allo standard UNI 10802 il loro recepimento a livello ministeriale, con decreto direttoriale del Ministero della transizione ecologica del 9 agosto 2021, n. 47, di approvazione delle linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del sistema nazionale per la protezione dell’ambiente del 18 maggio 2021, in attuazione dell’art. 184, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A questo riguardo si oppone il duplice rilievo secondo cui: l’ora richiamata disposizione del testo unico dell’ambiente non impone l’utilizzo delle tecniche di campionamento previste dalla UNI 10802; l’atto di approvazione delle linee guida sulla classificazione dei rifiuti elaborate dal Consiglio del sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA) - decreto direttoriale - si sostanzia in «un provvedimento amministrativo privo di efficacia vincolante secondo il nostro sistema delle fonti».
7. Per ragioni analoghe si censura la prescrizione d), che obbliga il gestore dell’impianto autorizzato di classificare i rifiuti ivi prodotti secondo la richiamata normativa tecnica UNI 10802, se interpretato estensivamente, nel senso cioè di applicare quest’ultima, che si ribadisce essere priva di forza cogente, «a tutte le miscelazioni, ivi incluse quelle che non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 187 del d.lgs. 152/06». Sono pertanto riproposte le contestazioni formulate nel motivo d’appello precedente e si critica l’assunto della sentenza di primo grado secondo cui la prescrizione sarebbe meramente specificativa e integrativa dei compiti del gestore dell’impianto e dunque non necessitante di una puntuale motivazione.
8. Sarebbe poi illegittima anche la prescrizione e), la quale impone al gestore di svolgere l’omologa dei rifiuti conferiti nell’impianto sulla base delle modalità e delle informazioni dettagliatamente previste dalla prescrizione medesima, quando invece - si sottolinea - esse erano in precedenza stabilite dal gestore nel piano di gestione operativa dell’impianto. Sul punto viene prospettato uno stravolgimento dei contenuti dell’autorizzazione integrata ambientale, ed inoltre si lamenta che non sia stata considerata l’«inutilità ai fini ambientali delle modalità di omologa», come a suo tempo rappresentato all’amministrazione provinciale in sede procedimentale. Oggetto di specifiche censure è la parte della contestata prescrizione in cui si include tra le informazioni relative all’omologa dei rifiuti «l’elenco degli inquinanti caratteristici del rifiuto (“traccianti” - inquinanti per i quali è necessario un abbattimento ai fini del rispetto dei limiti imposti allo scarico) e le relative concentrazioni». Viene al riguardo precisato che in precedenza i traccianti erano indicatori definiti dal gestore e usati come parametri sintetici per verificare la contaminazione tipica di alcuni rifiuti dallo stesso stabiliti, mentre con la prescrizione censurata l’individuazione dei traccianti è rimessa all’amministrazione provinciale. Diversamente da quanto statuito dalla sentenza, che ha individuato nella prescrizione la legittima finalità di ricondurre gli inquinanti che eccedono la concentrazione massima allo scarico entro i limiti imposti dall’autorizzazione integrata ambientale, si paleserebbe invece come irragionevole l’imposizione di metodi di omologa maggiormente articolati e onerosi, in un impianto che non ha mai fatto registrare problematiche ambientale e che in particolare è risultato conforme alle BAT applicabili, come risulta dallo stesso provvedimento impugnato. Viene inoltre ribadito che la definizione dei traccianti da parte dell’amministrazione provinciale, quali «inquinanti per i quali è necessario un abbattimento ai fini del rispetto dei limiti imposti allo scarico», lungi dal porsi nella direzione di specificare i compiti di analisi del gestore dell’impianto, sarebbe in tesi irragionevolmente destinato a determinare un incremento dei costi di gestione per effetto delle analisi imposte dall’amministrazione. Sul punto si sottolinea che con il termine traccianti si definiscono sul piano tecnico «le sostanze pertinenti e identificative dei rifiuti, al fine di tracciare la compatibilità con l’omologa e la successiva trattabilità», la cui individuazione si afferma essere rimessa al gestore. La loro fissazione da parte dell’amministrazione sarebbe pertanto illegittima per contraddittorietà, oltre che foriera di oneri di gestione per la moltiplicazione delle verifiche e dei monitoraggi «con periodicità anche giornaliera» dei traccianti in relazione alle varie operazioni di trattamento dei rifiuti svolte nell’impianto. Ciò sarebbe in particolare evincibile dal fatto che la nuova definizione viene ripresa per altre prescrizioni introdotte con il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (prescrizioni ll, mm, oo, pp, qq, tt e xx). Analoghe contestazioni di illogicità e difetto di proporzione sono svolte con riguardo agli obblighi di definire in fase di omologa la compatibilità con altri rifiuti, per via della vastità qualitativa e numerica dei rifiuti trattati nell’impianto; e di procedere con la «separazione polifasica» dei rifiuti, alla quale si oppone l’assenza di base normativa, e l’inutilità a fini ambientali dell’onere aggiuntivo, posto che la sottesa valutazione «è già sempre e comunque considerata in fase di scarico», sia per i trattamenti dei rifiuti con due fasi liquide (es. acqua e olio), per i quali è previsto un passaggio in linea di disoleazione, sia per quelli in cui vi è coesistenza di solidi e liquidi destinati ad un passaggio in linea di dissabbiatura sgrigliatura.
9. In via consequenziale, sarebbe quindi illegittima la prescrizione f), relativa alla frequenza delle operazioni di omologa dei rifiuti con le modalità stabilite nella prescrizione e).
10. Di seguito sono censurate le prescrizioni g), h) e j), nella misura in cui impongono il respingimento automatico dei rifiuti in caso di non rispondenza all’omologa, con asserito svuotamento della funzione del responsabile tecnico dell’impianto, senza che da ciò derivi alcun effettivo beneficio per l’ambiente.
11. Con ulteriori censure si contesta la prescrizione k), la quale prevede che l’organizzazione impiantistica e la dislocazione delle aree dedicate alle operazioni di stoccaggio e di trattamento dei rifiuti devono essere gestite in conformità alla «planimetria denominata “Zonizzazione rifiuti” datata -OMISSIS- e allegata alla domanda di riesame». Ne sarebbe così derivato un immotivato mutamento del parametro di riferimento per l’ordinaria conduzione dell’impianto, che la sentenza non avrebbe esattamente colto, sulla base dell’indimostrata corrispondenza con la planimetria assunta a riferimento della precedente autorizzazione integrata ambientale.
12. Da analoga carenza motivazionale sarebbe affetta anche la prescrizione m), la quale richiede di dotare le aree dell’impianto di «opportuni sistemi e mezzi antincendio di rapido impiego». La misura, immotivata ed espressa attraverso generici riferimenti, sarebbe fonte di oneri gestionali aggiuntivi sproporzionati. Inoltre, diversamente da quanto affermato dalla sentenza di primo grado, questi ultimi non sarebbero giustificati dalla necessità di rispettare la vigente disciplina di settore (circolare del Ministero dell’ambiente del 21 gennaio 2019; recante Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi), come peraltro ipotizzato dall’amministrazione provinciale solo nelle proprie difese in giudizio, con relativa integrazione in sede processuale della motivazione del provvedimento impugnato.
13. Viene poi censurata la prescrizione ee), così formulata: «le operazioni di accorpamento (operazione di smaltimento D15) possono essere effettuate esclusivamente sui rifiuti individuati dal medesimo codice CER; nel caso in cui l’accorpamento riguardi rifiuti pericolosi, essi devono avere anche le medesime caratteristiche di pericolosità». Al riguardo, si deduce che non sarebbe sufficiente a classificare l’accorpamento dei rifiuti come operazione di smaltimento D15 (Deposito preliminare), e su questa base ad imporre le contestate limitazioni, il richiamo alla «prassi corrente», come statuito invece dalla sentenza di primo grado, ancora una volta sulla base delle difese in giudizio dell’amministrazione provinciale, con non consentita integrazione postuma del provvedimento impugnato. Il riferimento alla prassi corrente, peraltro di segno contraddittorio nelle varie regioni, non costituirebbe inoltre idonea base per giustificazione una limitazione del precetto normativo ex art. 187, comma 2, del testo unico ambientale, secondo cui «la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata», con incisione della portata dell’autorizzazione integrata ambientale rispetto all’operazione di miscelazione di rifiuti nella fase preliminare di un processo di trattamento nell’impianto.
14. Di seguito vengono riproposte le censure in via derivata nei confronti delle prescrizioni jj) e kk), che impongono di adeguare alla nuova autorizzazione gli strumenti di pianificazione interni all’impianto e nelle more ne affermano l’eterointegrazione alle nuove prescrizioni. Le medesime prescrizioni sarebbero peraltro autonomamente illegittime nella parte in cui avrebbero immotivatamente innovato rispetto alle corrispondenti prescrizioni della previgente autorizzazione integrata ambientale.
15. Quindi sono del pari riproposte le censure nei confronti delle prescrizioni ll), mm) e oo), la prima delle quali impone l’installazione di «un campionatore automatico in uscita dall’impianto chimico-fisico (…) in grado di prelevare un campione medio giornaliero rappresentativo su cui devono essere verificate quotidianamente le concentrazioni degli inquinanti traccianti individuati in fase di omologa»; la seconda prevede obblighi di comunicazione alle autorità competenti (Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente - APPA e -OMISSIS-) nel caso in cui nelle analisi di cui alla precedente lettera ll), si verificasse il superamento dei valori di riferimento; e l’ultima richiede che sia predisposta una specifica procedura per la gestione dei superamenti delle concentrazioni rilevate nel corso dei monitoraggi di cui alla prescrizione mm). Le contestazioni si indirizzano all’obbligo di campionamento con frequenza giornaliera anziché settimanale, in tesi introdotto in mancanza di basi normative, di previsioni conformi nell’ambito delle BAT e di ragioni tecnico-scientifiche plausibili sul piano della tutela dell’ambiente. Viene al riguardo sottolineato, in primo luogo, che contrariamente a quanto statuito dalla sentenza di primo grado i sistemi di misurazione e monitoraggio adottati nell’impianto gestito dalla ricorrente sono già conformi alle BAT, come in particolare attestato in sede di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (allegato 1). Si ribadisce inoltre che sarebbe violato l’art. 29-sexies, comma 4-quater, del testo unico ambientale, secondo il quale «(i) valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto». Sarebbe a quest’ultimo riguardo erronea la statuizione di rigetto della censura, basata sull’assunto che i valori di cui la prescrizione mm) impone la verifica in uscita dal comparto chimico-fisico non sarebbero valori limite di emissione, ai sensi della citata disposizione di legge, ma meri «valori di riferimento». In contrario, si oppone che il divieto di superamento per essi imposto, con la conseguente attivazione delle procedure correttive di carattere emergenziale, li renderebbe assimilabili ai valori limite di emissione di cui all’art. 5, comma 1, lett. i-octies), del testo unico dell’ambiente, illegittimamente applicati ai flussi in uscita dal comparto chimico-fisico nell’ambito del processo di trattamento dei rifiuti all’interno dell’impianto autorizzato. Sotto il profilo ora evidenziato sarebbe dunque palese il difetto di proporzione e l’irragionevolezza delle misure imposte in sede di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale.
16. Di seguito è contestata la prescrizione pp), la quale impone, tra l’altro, di prevedere un «punto di prelievo in uscita dalla “linea oleosi” in corrispondenza del quale devono essere monitorati quotidianamente gli inquinanti traccianti e, in ogni caso, almeno gli inquinanti “Oli minerali” e “Boro”, al fine di verificare l’efficienza di abbattimento del comparto; il campione medio-composito giornaliero deve essere ponderato nell’arco delle ore di esercizio e statisticamente rappresentativo». L’illegittimità è prospettata nella misura in cui si determinerebbe con essa un’estensione degli obblighi precedentemente contestati di monitoraggio quotidiano ad un punto intermedio del processo di trattamento, in particolare in uscita dalla “linea oleosi”, i cui effluenti vengono ulteriormente trattati nella successiva linea D9-rifiuti diversi. Sarebbero dunque carenti ragioni di carattere tecnico e non si sarebbe considerato che in sede procedimentale era stata rappresentata l’impossibilità di definire un limite massimo di concentrazione in uscita dalla linea in questione.
17. Da analoghe illegittimità sarebbe inoltre affetta la prescrizione qq), che impone l’inserimento di un «campionatore automatico in uscita dalla vasca V2B», con lo scopo di monitorare con frequenza settimanale le concentrazioni degli inquinanti traccianti individuati in fase di omologa dei rifiuti sottoposti a trattamento.
18. Plurime censure sono rivolte alla prescrizione ss), recante il seguente divieto: «i rifiuti prodotti dalle diverse linee di trattamento (sgrigliatura, oleosi, diversi e biologico) non devono essere miscelati, ai sensi dell’art. 187 del D.Lgs. 152/2006, tra loro o con altri rifiuti; non sono in via generale consentite diluizioni e/o miscelazioni dei rifiuti prodotti dall’impianto allo scopo di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di un impianto di destinazione». Rispetto al suo scopo di evitare la miscelazione di categorie non omogenee di rifiuti e di rispettare la normativa di legge (artt. 177, comma 4, e 187 del testo unico ambientale) e le BAT di riferimento, si oppone il difetto dei relativi presupposti. Viene in particolare contestato che le operazioni di trattamento già autorizzate - ed in particolare l’unione dei «rifiuti derivanti dall’operazione di flottazione nella ‘linea oleosi’ con i fanghi chimico-fisici prodotti, dalla ‘linea diversi’», secondo l’attuale configurazione impiantistica, di cui dà atto il provvedimento impugnato - si sostanzierebbe in un’operazione di miscelazione di rifiuti. Sarebbe per contro applicabile la disciplina dei reflui contenuta nell’art. 127 del testo unico ambientale, secondo cui «i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione». Viene al riguardo sottolineato che i fanghi trattati non sono prodotti di cui il gestore dell’impianto intende disfarsi, quindi destinati allo smaltimento, con conseguente applicazione dell’art. 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, falsamente applicato al caso di specie. Si tratterebbe invece di sostanze utilizzate nel processo produttivo dell’impianto, come posto in evidenza in sede procedimentale, con puntuali apporti di carattere tecnico, intesi a sottolineare che un impianto autorizzato per operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti può trattare categorie con diversi CER, sulla base dei processi ivi previsti, senza necessità di un’esplicita autorizzazione per l’operazione di miscelazione degli stessi. Nondimeno il provvedimento impugnato, fondato sui rilievi tecnici contenuti nella relazione del consulente tecnico nominato nel procedimento penale, di essi non avrebbe tenuto minimamente conto, con conseguente carenza motivazionale. Del pari non si sarebbe tenuto conto della prassi adottata in altre regioni (in particolare in Lombardia, in virtù della delibera di giunta regionale del 6 giugno 2012, n. 3596), in cui si è chiarito che la miscelazione infra-processo è inclusa nell’autorizzazione integrata ambientale e che solo dopo i vari trattamenti previsti viene prodotto il rifiuto, come ulteriormente previsto anche dalla disciplina tecnica in materia (BAT Reference Document for Waste Treatment - BReF -OMISSIS-). Al medesimo riguardo si ripropongono le censure di falsa applicazione della disciplina del testo unico ambientale sulla cessazione della qualifica di rifiuto, di cui all’art. 184-ter, richiamato nel provvedimento impugnato. Si oppone sul punto che «trattare un rifiuto all’interno di un impianto di smaltimento con operazioni D8 e D9 (cioè appunto di smaltimento) non significa sottoporlo a un’operazione di recupero, che è il presupposto per l’applicazione di tale disposizione». In conseguenza di tutto quanto esposto sarebbe erronea la classificazione dell’operazione di miscelazione tra «i rifiuti prodotti dalla flottazione nella linea oleosi e i rifiuti costituiti da fanghi chimici» come operazione D13 e D9, a seconda che si tratti di miscelazione in deroga o non in deroga, da cui la sua sottoposizione alle prescrizioni relative alla miscelazione dei rifiuti, per le quali si ribadisce che sarebbero pertanto carenti i relativi presupposti di legge. A questo riguardo si sottolinea che «il rifiuto conferito all’impianto viene sottoposto al processo di trattamento in continuo e diviene flusso in trattamento»; più precisamente, viene scaricata in fognatura la parte liquida del refluo ricondotta nei limiti di legge, mentre la restante parte viene avviata ad impianti terzi di smaltimento, per cui solo in questo momento assume la qualifica normativa di rifiuto. Se ne desume che ciò che viene trattato nell’impianto «non può essere soggetto all’applicazione della disciplina della miscelazione ex art. 187 d.lgs. 152/06», ma è già incluso nell’autorizzazione integrata ambientale per esso rilasciata. Una specifica censura viene enucleata con riguardo al flottato, espressamente contemplato nella prescrizione contestata, in relazione al quale si ribadisce che esso è una miscela di acqua contenente varie sostanze, tra cui una parte della sostanza organica liberata dalla rottura dell’emulsione, ma anche altri prodotti organici come polimeri e agenti disemulsionanti aggiunti, destinato ad essere necessariamente ridotto in umidità attraverso processi di condizionamento chimico e disidratazione, dello stesso tipo di quelli che si attuano per i fanghi provenienti dall’impianto chimico-fisico. Si sottolinea al riguardo che le descritte operazioni sono incluse nell’autorizzazione integrata ambientale e sono riconducibili ad un’operazione di miscelazione di «due flussi di reflui», la quale presuppone la non applicabilità della disciplina sui rifiuti con la connessa necessità di autorizzazione specifica per la relativa miscelazione.
19. Sono poi riproposte le censure nei confronti della prescrizione tt), in base alla quale «l’equalizzazione/omogeneizzazione dei rifiuti nelle vasche V1A, V1B e V2B è consentita esclusivamente nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili, di cui alle BAT specifiche relative agli impianti di trattamento dei rifiuti; possono essere equalizzati rifiuti omogenei per inquinanti traccianti e livello di trattabilità al fine di ottimizzare efficienza ed efficacia dei processi; devono risultare chiaramente le informazioni inerenti i “traccianti”, i reagenti utilizzati e le loro quantità in relazione alle finalità del trattamento; tali informazioni devono essere registrate su apposito registro». Anche a questo riguardo, in assenza di vincoli normativi o derivanti dalle BAT si sarebbe illegittimamente imposta un’irragionevole restrizione alle operazioni di trattamento dei rifiuti all’interno dell’impianto di smaltimento, sulla base della erronea equiparazione dell’equalizzazione alla miscelazione/accorpamento di rifiuti, da cui conseguirebbero oneri di gestione aggiuntivi a carico della società ricorrente e una notevole restrizione di mercato, come prospettato per le altre prescrizioni contestate nel presente giudizio. Diversamente da quanto supposto dalla sentenza di primo grado, si sottolinea il carattere innovativo della prescrizione introdotta in sede di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale, nella misura in cui con essa si introducono limitazioni all’operatività all’interno dell’impianto, in precedenza non previste, a causa dell’ambiguo riferimento alla nozione di «rifiuti omogenei». La fondatezza delle contestazioni svolte sul punto emergerebbe dalla giustificazione postuma addotta dalla sentenza appellata a fondamento della prescrizione, consistente nell’esigenza, non ricavabile dal tenore motivazionale del provvedimento impugnato, di consentire l’equalizzazione a condizione che «gli inquinanti contenuti nei rifiuti che si vanno a omogeneizzare/equalizzare siano trattabili con la stessa sequenza di trattamento e con un omogeneo livello di trattabilità». Si ribadisce quindi l’illegittimità della prescrizione se intesa nel senso che sia sempre necessaria «un’identità di rifiuti e di traccianti», quale condizione per svolgere l’operazione di equalizzazione (creazione di un refluo con caratteristiche il più costanti possibile ed in cui il carico di contaminanti da rimuovere possa essere adeguatamente controllato, per permettere il funzionamento ottimale dei processi di trattamento a valle e l’individuazione di un’adeguata “ricetta”).
20. Sono poi riproposte le censure nei confronti della prescrizione uu), in base alla quale il gestore dell’impianto «deve gestire i rifiuti conferiti al fine di programmare le tipologie omogenee dei rifiuti che possono essere avviate a trattamento D9 e D8 nelle vasche di equalizzazione preventivamente (indicativamente 72 ore) rispetto all’effettuazione del trattamento stesso», tanto in via derivata rispetto alla precedente prescrizione tt), quanto in via autonoma. Sotto questo profilo se ne contesta l’attuabilità, sul rilievo che la disponibilità per il trattamento dipende dal carico giornaliero di rifiuti in entrata nell’impianto e dei dati di esercizio all’interno dello stesso.
21. Con riguardo alla prescrizione ww), la quale impone di trasmettere «entro sei mesi dalla messa in esercizio del comparto chimico-fisico, uno studio di fattibilità» per il «miglioramento del trattamento dei rifiuti, mediante l’individuazione di specifici pretrattamenti su rifiuti pericolosi» (in particolare contenenti boro, piombo, zinco, nichel, solventi organici, solventi clorurati). Se ne contesta il presupposto, testualmente riferibile a «dubbi» formulati dai competenti organi preposti ai controlli sull’impianto in merito all’effettiva capacità di trattamento di alcuni contaminanti. In contrario, oltre a ribadirsi l’inutilizzabilità dei precedenti accertamenti, nondimeno ripresi dalla relazione consulenza tecnica d’ufficio in sede penale su cui si fonda il provvedimento impugnato, si sottolinea che in base alle relazioni tecniche di parte ricorrente sarebbe stata dimostrata l’adeguatezza alle BAT di riferimento delle metodologie adottate nell’impianto gestito dalla società ricorrente.
22. Di seguito si ripropongono le censure nei confronti della prescrizione xx), così formulata: «relativamente alla possibilità di utilizzo di rifiuti in sostituzione delle materie prime, lo stesso deve essere effettuato nel rispetto della BAT 22; in particolare, per i rifiuti alimentati ‘in linea’, deve essere dimostrato analiticamente che eventuali impurità, quali quelle richiamate dalla medesima BAT (in particolare metalli), possono essere efficacemente trattate ed abbattute tramite i trattamenti applicati; dette impurità devono essere compatibili rispetto alla miscela di rifiuti sottoposta a trattamento, ossia le impurità presenti nel rifiuto utilizzato in sostituzione della materia prima devono essere ricomprese tra gli inquinanti traccianti della miscela in trattamento». Viene in contrario dedotto che la citata BAT 22 nell’imporre la «compatibilità dei rifiuti che sostituiscono altri materiali con i rifiuti in ingresso», non reca alcun riferimento né alle impurità né ai traccianti, come definiti dall’amministrazione provinciale nella prescrizione e), di cui sopra.
23. Del pari si contestano nuovamente le prescrizioni generali relative alle operazioni di miscelazione (smaltimento D13), applicate alle fasi preliminari del processo di trattamento sull’erroneo presupposto che per le sostanze trattate nell’impianto si applichi la disciplina ex art. 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A fondamento delle contestazioni, e a confutazione dell’assunto secondo cui nella Provincia di Trento non vigerebbero «provvedimenti di carattere generale per disciplinare le operazioni di miscelazione», si richiama la posizione assunta in materia dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (documento 12/165/CR8C/C5, par. 2), che nel trattare le “esclusioni” dalla normativa delle miscelazioni ha così statuito: «(u)n impianto autorizzato ad effettuare operazioni di recupero o smaltimento, ad eccezione del mero stoccaggio (D15, R13), può trattare i diversi codici CER autorizzati per tale operazione, senza che sia esplicitamente autorizzata l’operazione di miscelazione degli stessi, laddove questa risulti essere fase che costituisce parte integrante del procedimento tecnologico autorizzato. Questo in quanto l’autorizzazione delle operazioni citate valuta già il trattamento congiunto dei diversi rifiuti e disciplina la tracciabilità delle partite di rifiuti in ingresso e in uscita». Con un distinto ordine di censure svolte al medesimo riguardo si ripropone l’assunto secondo cui la società ricorrente sarebbe autorizzata ai sensi della citata disposizione del testo unico ambientale alle operazioni «per tutte le ipotesi in cui la miscela formata all’interno del parco serbatoi venga inviata al trattamento presso terzi, e quindi esca dall’impianto per essere trattata». Sarebbe pertanto erronea sul punto la motivazione posta a fondamento del rigetto delle censure dalla sentenza di primo grado, secondo cui l’obbligo di autorizzazione specifica ai sensi dell’art. 187 del testo unico ambientale si applica «senza distinzione basata sul destino della miscela (a trattamento nell’impianto o presso un impianto terzo)». In contrario viene sottolineato che ai sensi dell’art. 183, lett. a), del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il destino della sostanza sarebbe invece determinante ai fini della sua qualificazione come rifiuto, posto che in base alla disposizione di legge ora richiamata per quest’ultimo si intende «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi».
24. Quindi vengono riproposte le censure relative alla prescrizione concernente lo «scarico S1», per il quale si precisa che esso «convoglia in fognatura nera: previo trattamento nel comparto biologico, le acque…». L’illegittimità sul punto è desunta dal fatto che a valle del comparto biologico e prima della fognatura «vi è una sezione di filtrazione su sabbia e una su carboni composta da filtri in serie», per cui la contestata misura avrebbe l’irragionevole effetto di imporne la rimozione.
25. Viene poi criticata la dichiarazione di inammissibilità delle censure con cui si lamenta che le contestate prescrizioni condurrebbero la gestione dell’impianto in perdita economica, a causa dei maggiori costi in conto capitale e di esercizio da esse derivanti. In contrario si ribadisce l’interesse alla prospettazione, perché in tesi necessaria a dimostrare l’irragionevolezza e il difetto di proporzionalità delle prescrizioni contestate.
26. Inoltre, sono riproposte le censure concernenti i tempi assegnati per ottemperare alle prescrizioni introdotte in sede di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale, erroneamente respinta in parte dalla sentenza di primo grado, sull’assunto che alcune sarebbero meramente riproduttive o specificative di quelle dell’autorizzazione previgente. La distinzione di queste rispetto a quelle innovative sarebbe in primo luogo in contrasto con l’art. 29-quater, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo il quale l’autorizzazione integrata ambientale «deve includere le modalità previste dal presente decreto per la protezione dell’ambiente, nonché, la data entro la quale le prescrizioni debbono essere attuate»; ed inoltre sarebbe infondata in fatto, per le ragioni esposte nei motivi precedenti. Viene poi riproposta la domanda contro il silenzio ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. serbato sul punto dall’amministrazione provinciale, proposta con il ricorso di primo grado, in via di subordine, su cui la sentenza appellata non si sarebbe pronunciata.
27. Infine, si censura la condanna alla refusione delle spese di giudizio in favore dell’amministrazione provinciale, pronunciata dalla sentenza «(n)onostante il parziale accoglimento del ricorso», relativamente all’efficacia immediata delle prescrizioni riconosciute come innovative dalla stessa pronuncia.
28. Così sintetizzati i motivi d’appello, le censure svolte nel primo motivo si rivolgono a considerazioni svolte in premessa dalla sentenza rispetto all’esame dei motivi di impugnazione. Esse possono pertanto essere esaminate in relazione a questi ultimi, nei termini in cui essi sono riproposti nel presente giudizio di secondo grado.
29. Ciò precisato, le censure nei confronti dell’utilizzo della consulenza tecnica d’ufficio disposta nel procedimento penale, oggetto del secondo motivo d’appello, sono infondate.
30. In primo luogo, nel supporre che le contestate prescrizioni contenute nell’allegato 2 all’autorizzazione integrata ambientale rilasciata all’esito del riesame ex art. 29-octies del testo unico ambientale deriverebbero da un acritico recepimento della consulenza tecnica il motivo d’appello in esame non pone in discussione che, come accertato dalla sentenza di primo grado, il provvedimento impugnato reca riferimenti testuali all’atto istruttorio in sede penale «solamente nelle motivazioni relative alle prescrizioni n. 10 e n. 14 - corrispondenti, rispettivamente, alla prescrizione di cui alla lettera ss) dell’Allegato 2, concernente il divieto di miscelare i rifiuti, e alla prescrizione di cui alla lettera ww) dell’Allegato 2, con cui è stato richiesto uno studio di fattibilità sulle soluzioni tecnologiche implementabili ai fini del miglioramento del trattamento dei rifiuti». L’ipotesi prospettata va poi smentita sulla base della corretta ricostruzione delle effettive ragioni delle prescrizioni contestae, le quali, come ulteriormente precisato la pronuncia di primo grado, afferiscono al fondamento normativo del potere esercitato, consistente nella revisione dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 29, comma 3, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale impone la revisione generale dell’autorizzazione integrata ambientale «entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un’installazione». La diretta riconducibilità delle contestate misure al paradigma legale ora richiamato trova quindi conferma sul piano motivazionale attraverso il richiamo alla decisione di esecuzione della Commissione europea 2018/1147/UE del 10 agosto 2018 relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti.
31. Al medesimo riguardo è stato inoltre dato atto, per un verso, che ai sensi dell’art. 129, comma 3-ter, disp. atto proc. pen. – che per quanto di interesse nel presente giudizio con riguardo ai «reati previsti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», prevede che «(i) procedimenti di competenza delle amministrazioni di cui ai periodi precedenti, che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, possono essere avviati o proseguiti anche in pendenza del procedimento penale, in conformità alle norme vigenti». - l’amministrazione provinciale ha proceduto al riesame autonomamente rispetto agli accertamenti dell’autorità giudiziaria penale. Per altro verso la pronuncia di primo grado ha richiamato la circostanza che «il comparto di trattamento chimico-fisico D9 presso l’installazione -OMISSIS-», e che pertanto, come del pari specificato nel provvedimento impugnato, sin dalla comunicazione di avvio del procedimento, la società ricorrente è stata resa edotta della possibilità che «in sede istruttoria sarebbero stati valutati gli esiti dei controlli e delle ispezioni eseguite presso l’installazione (…), nonché i contenuti della relazione peritale», come consentito ai sensi dell’art. 29-octies, comma 5, del testo unico dell’ambiente.
32. I rilievi della sentenza sulla motivazione complessiva del provvedimento rilievo valgono pertanto a smentire l’ipotesi di acritico recepimento dell’atto istruttorio in sede penale, mentre quelli sulle modalità procedimentali seguite dall’amministrazione sono sufficienti a confutare l’assunto di inutilizzabilità dello stesso nel diverso contesto amministrativo oggetto della presente controversia. A quest’ultimo riguardo, va confermata la statuizione della pronuncia di primo grado secondo cui in base alla disposizione del testo unico ambientale da ultimo richiamata l’amministrazione è titolata ad utilizzare tutte le informazioni pertinenti in possesso, e che nello specifico si palesa utile il quadro sulla situazione impiantistica e gestionale fornito dalla consulenza tecnica disposta in sede penale. Come quest’ultima deduce, inoltre, le contestazioni secondo cui non si sarebbero invece considerate le deduzioni tecniche della ricorrente in sede procedimentale sono apodittiche, come parimenti statuito dalla sentenza di primo grado, ed avulse dal tenore motivazionale complessivo del provvedimento impugnato.
33. Considerazioni analoghe a quelle ora svolte possono poi essere estese alla relazione conclusiva dell’attività di verifica svolta dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente - APPA per il biennio -OMISSIS-, utilizzabile ai sensi dell’ampia formulazione del citato art. 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a prescindere dal fatto che su di essa si siano fondati precedenti provvedimenti dell’amministrazione provinciale relativi al medesimo impianto. A questo riguardo sono pienamente condivisibili le deduzioni difensive svolte sul punto da quest’ultima, secondo cui il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale ai sensi del più volte richiamato art. 29-octies del testo unico dell’ambiente implica una nuova, approfondita e generale valutazione dei presupposti per il rilascio del titolo ad esercitare un impianto di smaltimento di rifiuti. Nell’ambito di quest’ampia rivalutazione l’utilizzo delle verifiche APPA per il biennio -OMISSIS- si palesa nel caso specifico ragionevole, dal momento che - come incontroverso tra le parti - con esse si era accertato che nell’impianto gestito dalla ricorrente erano stati conferiti rifiuti con concentrazione di inquinanti superiore alla capacità di trattamento.
34. Sono poi infondati gli assunti secondo cui le contestate prescrizioni formulate nell’allegato 2 al provvedimento di riesame impugnato sarebbero innovative e più rigorose delle BAT applicabili, come in tesi evincibile dal fatto che nell’allegato 1 vi è l’attestazione del loro rispetto. La distinzione su cui si imperniano le censure ora in esame, tra mera specificazione di prescrizioni vigenti e applicate e innovazione rispetto ad esse non si presta a delimitare con adeguata precisione le misure che la competente autorità amministrativa può imporre in generale in sede di autorizzazione integrata ambientale, in ragione dell’esigenza di interesse pubblico, propria del riesame ex art. 29-octies del testo unico dell’ambiente, di adeguamento alle BAT applicabili, attraverso l’individuazione delle misure e delle soluzioni di carattere impiantistico-gestionale in grado di realizzare il miglior rendimento sul piano ambientale. Il potere prescrittivo dell’autorità si correla ai contenuti sostanziali del titolo autorizzativo, enunciati in via generale dall’art. 29-sexies del testo unico ambientale, in base ai quali il provvedimento abilitativo è titolato ad stabilire «valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti» (comma 3) con specifico riferimento «all’applicazione delle migliori tecniche disponibili» (comma 4); ed inoltre «ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee» (comma 3-bis); e infine, con norma di chiusura, le «ulteriori condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate opportune dell’autorità competente» (comma 9).
35. Del pari sono quindi infondate le censure di motivazione carente a base delle prescrizioni di cui all’allegato 2 al provvedimento impugnato, di cui si suppone il carattere innovativo rispetto a quelle della previgente autorizzazione, sulla base degli asseriti insufficienti richiami alla decisione2018/1147/UE di approvazione delle nuove BAT per il trattamento dei rifiuti e al «confronto con impianti simili autorizzati nelle Regioni limitrofe». Sul punto è sufficiente richiamare la precedentemente esposta ampia discrezionalità riservata all’autorità competente a livello normativo e tecnico - in questo secondo caso dalle BAT applicabili - i richiami qui contestati si palesano sufficienti a rendere palese la base legittimante il potere prescrittivo dell’amministrazione. Analogamente va ribadito il carattere opinabile della distinzione tra prescrizioni riproduttive e/o meramente specificative di quelle vigenti e prescrizioni innovative, una volta chiarito che anche queste ultime sono riconducibili all’ampio potere di rivalutazione dei presupposti per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale in sede di riesame ex art. 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Al medesimo riguardo va ribadito che l’evoluzione tecnica che caratterizza i processi di gestione e trattamento dei rifiuti rende immanente l’esigenza di continuo adeguamento delle misure di gestione e delle soluzioni impiantistiche da imporre in sede di rilascio dei titoli autorizzatori, di cui il potere di revisione sancito dalla disposizione di legge da ultimo richiamata è espressione. Ciò è del resto palese nel caso di specie, in cui - come puntualmente rilevato dalla sentenza - la revisione deriva dalla necessità di dare attuazione alle BAT per il trattamento dei rifiuti approvate con decisione della Commissione europea2018/1147/UE, con la previsione di un termine massimo di quattro anni dalla data di pubblicazione del provvedimento, ai sensi del comma 3, lett. a), della medesima disposizione del testo unico dell’ambiente.
36. Si possono quindi esaminare le contestazioni relative alle singole prescrizioni.
37. Va innanzitutto confermata l’assenza di profili di illegittimità nella prescrizione c), impositiva dell’obbligo per i rifiuti in ingresso di accertamento che il soggetto conferitore li abbia caratterizzati in conformità alla normativa vigente (decreti del ministro dell’ambiente del 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; e del 2 giugno 2002, n. 161 - Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate). Come statuito dalla sentenza l’obbligo è innanzitutto da considerarsi riproduttivo di quello previsto nella previgente autorizzazione integrata ambientale di procedere alla classificazione dei rifiuti «applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell’Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, nonché secondo quanto disposto dall’art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998 (rifiuti non pericolosi) e dall’art. 7 del D.M. 12 giugno 2002, n.161 (rifiuti pericolosi)». Oltre all’assenza di contenuti innovativi, il cui riscontro vale di per sé ad infirmare il fondamento logico delle censure in esame, è evidente anche la ragionevolezza e proporzionalità della prescrizione, necessaria per l’omologazione del rifiuto, sulla base della doverosa verifica, comunque di carattere documentale, che esso possa essere ammesso al trattamento in impianto; e dunque che i rifiuti accettati dall’impianto corrispondano a quelli autorizzati.
38. La sentenza appellata ha anche correttamente precisato che la normativa ministeriale richiamata, pur concernente le procedure semplificate per il recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, definisce comunque «le modalità di campionamento rinviando all’applicazione della normativa tecnica UNI 10802». La pronuncia di primo grado ha anche adeguatamente motivato sul carattere vincolante per i produttori di rifiuti della normativa tecnica UNI 10802, attraverso il pertinente riferimento all’art. 184, comma 5, del testo unico dell’ambiente, il quale prevede che «(l)a corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare». Ne deriva che contrariamente a quanto assume l’appello, è immune da profili di illegittimità il rinvio alla ora menzionata disciplina tecnica da parte della fonte normativa istituita per legge, di cui al menzionato decreto del Ministero della transizione ecologica del 9 agosto 2021, n. 47, di approvazione delle linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del sistema nazionale per la protezione dell’ambiente del 18 maggio 2021.
39. Del pari, come dedotto dall’amministrazione provinciale resistente, la prescrizione è conforme alle BAT di riferimento per il trattamento dei rifiuti (BAT Reference Document for Waste Treatment - Bref -OMISSIS-; § 2.3.2.1 - Waste pre-acceptance), le quali prevedono che debbano essere verificate le informazioni fornite dal produttore e che si dovrebbe provvedere ad un autonomo campionamento laddove ci siano dubbi sulla rappresentatività del campione analizzato).
40. Per ragioni analoghe vanne respinte le censure proposte nei confronti della prescrizione d), relativa alla classificazione dei rifiuti prodotti dall’impianto gestito dalla società ricorrente all’esito dei trattamenti autorizzati, da svolgersi secondo la richiamata norma tecnica UNI 10802. All’assunto secondo cui sarebbe illegittima l’estensione da essa derivante «a tutte le miscelazioni, ivi incluse quelle che non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 187 del d.lgs. 152/06», con conseguente aggravio gestionale, viene fondatamente contrapposto il fatto che il richiamo alla normativa tecnica applicabile trova la propria legittima base normativa nella qualità di produttore di rifiuti tra l’altro attribuibile, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. f), del testo unico ambientale, a «chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)». Ne deriva l’ulteriore corollario dell’obbligo a suo carico di «corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti (…) sulla base delle Linee guida» in materia, ai sensi dell’art. 184, comma 5, del medesimo testo unico ambientale. Sono così smentite le censure di illegittimità per irragionevolezza e sproporzione al riguardo formulate.
41. Non è illegittima nemmeno la prescrizione e), impositiva dell’obbligo di svolgere l’omologa dei rifiuti conferiti nell’impianto sulla base le modalità e le informazioni minime previste dal provvedimento impugnato. Si tratta di una misura che si palesa coerente con la definizione di «traccianti» risultante delle citate BAT di riferimento (BAT - Reference Document for Waste Treatment; § 2.3.2 Operational techniques to improve environmental performance), e con la loro funzione, quale esplicitata nelle BAT di cui alla più volte citata decisione della Commissione europea2018/1147/UE, di «garantire l’idoneità tecnica (e giuridica) delle operazioni di trattamento di un determinato rifiuto prima del suo arrivo all’impianto». La prescrizione si colloca dunque nella doverosa prospettiva di ricondurre il rifiuto trattato nell’impianto ai limiti allo scarico imposti dall’autorizzazione integrata ambientale. Al medesimo riguardo, nessuna contestazione è inoltre svolta dalla società ricorrente sul fatto, oggetto di specifica deduzione dell’amministrazione provinciale resistente, che simili caratteristiche dell’operazione sono previste nel piano di gestione operativa dell’impianto dalla stessa predisposto. Pertanto, nella prospettiva finora delineata si giustificano le contestate caratteristiche dell’omologa, funzionali all’individuazione preventiva dei contaminanti e delle loro concentrazioni nel rifiuto, onde stabilirne la sua conferibilità nell’impianto e l’efficacia dei successivi trattamenti finalizzati alla rimozione di tutti gli inquinanti, quali indicati nelle analisi svolte dal produttore e verificate in ingresso dal gestore dell’impianto di smaltimento.
42. Avuto riguardo all’ora evidenziato scopo della prescrizione, complementare a quelle precedentemente trattate, non se ne può dunque predicare l’illegittimità per il fatto che manchi a livello normativo una definizione di traccianti. La lacuna normativa non equivale infatti a divieto sul piano amministrativo. Non esorbita pertanto dalla discrezionalità tecnica attribuita dalla legge all’autorità competente di qualificare come traccianti tutti gli inquinanti presenti nel rifiuto conferito presso l’impianto in misura superiore ai limiti di concentrazione allo scarico. Essa risulta per contro esercitata in modo coerente con l’esigenza di raggiungere gli obiettivi di eliminazione degli inquinanti inerenti all’autorizzazione integrata ambientale, ed in particolare con le sopra richiamate disposizioni contenute nell’art. 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Palese sotto questo profilo la maggiore rispondenza rispetto alla causa normativa del potere autorizzatorio la scelta a base della contestata prescrizione rispetto all’alternativa invocata dalla società ricorrente, secondo cui l’individuazione dei traccianti dovrebbe esserle riservata. Al medesimo riguardo, peraltro, non emergono plausibili oneri gestionali aggiuntivi rispetto ad attività che, come deduce l’amministrazione provinciale, sono comunque insite nella gestione dell’impianto di smaltimento dei rifiuti e dunque nella relativa autorizzazione.
43. Considerazioni non dissimili possono essere svolte con riguardo alla prescrizione f), concernente l’aggiornamento dell’omologa: «annualmente» o «quando ricorrono significative variazioni nel processo produttivo da cui si genera il rifiuto che viene poi conferito alla Ditta, nonché ogniqualvolta, a seguito di verifiche all’atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell’omologazione e l’effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta». In assenza di previsioni normative puntuali sulla frequenza della riclassificazione dei rifiuti, la contestata misura non può essere considerata illegittima per il supposto aggravio di oneri gestionali, in un impianto comunque predisposto ed autorizzato per svolgere operazioni della specie. A smentita degli assunti in esame si pone peraltro lo stesso piano di gestione operativa dell’impianto predisposto dalla società ricorrente, che prevede una validità annuale della scheda di omologa, con salvezza del caso «in cui si verifichino variazioni del processo produttivo che genera il rifiuto tali da modificarne potenzialmente od effettivamente le caratteristiche». In definitiva, l’aggiornamento così come previsto dalla contestata prescrizione si palesa coerente con i principi normativi regolatrici della materia, in base ai quali con la sottoposizione a trattamento autorizzato del rifiuto prodotto richiede che esso sia ricaratterizzato/riclassificato.
44. Non diversamente da quanto finora esposto, sono legittime anche le prescrizioni g), h), j), relative alla verifica di corrispondenza del rifiuto all’omologa e impositive dell’obbligo respingimento del rifiuto non conforme. In relazione ad esse non trova alcuna conferma l’assunto secondo cui l’obbligo così definito, di verificare che i rifiuti in ingresso all’impianto corrispondano alle tipologie di rifiuto omologate, svuoterebbe l’autonomia decisionale del responsabile tecnico dell’impianto, invece destinata ad esplicarsi nelle operazioni disciplinare dalle misure contestate. Rimangono infatti intatti i compiti di omologa in ingresso, di verifica analitica delle caratteristiche dei rifiuti e della presenza di inquinanti e del relativo livello di concentrazione, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione all’esito del relativo trattamento. Come peraltro deduce l’amministrazione provinciale, si tratta di prescrizioni riconducibili a quelle dell’autorizzazione previgente, con l’eccezione dell’obbligo di registrazione delle schede di omologa sub j), («le schede di omologa devono essere raccolte in apposito registro e tenute a disposizione dell’Autorità di controllo»), di cui non si intravvedono tuttavia profili di illegittimità apprezzabili nella presente sede giurisdizionale.
45. Considerazioni analoghe a quelle da ultimo svolte possono essere estese nei confronti delle censure relative alla prescrizione k), relativa all’organizzazione impiantistica, alle dotazioni le attrezzature utilizzate e alla dislocazione delle aree dedicate alle operazioni di stoccaccio e smaltimento dei rifiuti; e a questo scopo recante il riferimento alla planimetria «Zonizzazione rifiuti». Le contestazioni sul punto hanno carattere meramente formale, dal momento che la società ricorrente assume che, venuto meno il richiamo espresso del numero di protocollo e della data del documento, come nella previgente autorizzazione, la planimetria di riferimento sarebbe diversa. L’assunto è tuttavia indimostrato ed è stato documentalmente smentito dall’amministrazione provinciale, sulla base del confronto con la precedente planimetria.
46. Non sono ravvisabili profili di illegittimità nemmeno nella prescrizione m), con cui il gestore è stato richiesto di dotare di sistemi di prevenzione incendi tutte le aree in cui si svolgono le operazioni autorizzate di trattamento dei rifiuti (D15, D14, D13, D9 e D8). La misura si palesa in primo luogo come legittima applicazione della circolare del Ministero dell’ambiente del 21 gennaio 2019, recante Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi), la quale prescrive dispositivi di protezione attiva antincendio in «tutti gli impianti che gestiscono rifiuti» (punto 5.3); ed inoltre come manifestazione di discrezionalità tecnica coerente con adeguati standard di sicurezza e prevenzione nella gestione di impianti di trattamento dei rifiuti.
47. Anche la prescrizione ee), relativa alle «operazioni di accorpamento» (operazione D15 - deposito preliminare, di cui all’allegato B alla parte IV del testo unico dell’ambiente), da svolgersi «esclusivamente sui rifiuti individuati dal medesimo codice CER», si sottrae alle censure di illegittimità formulate dalla società ricorrente. Questa sostiene che la prescrizione estenderebbe l’obbligo autorizzativo ex art. 187 del testo unico ambientale ad operazioni di miscelazione dei rifiuti svolte all’interno dell’impianto, nell’ambito dei trattamenti previsti dall’autorizzazione integrata ambientale, con conseguente aggravio gestionale. Al contrario, come statuito dalla sentenza di primo grado, sulla base della complessiva motivazione del provvedimento impugnato e delle deduzioni difensive dell’amministrazione provinciale, la prescrizione afferisce alle operazioni preliminari di stoccaggio dei rifiuti, riconducibili al deposito preliminare di cui alla lettera D15, «la quale colloca in una fase del ciclo di trattamento dei rifiuti anteriore alle operazioni D13», relativo al raggruppamento preliminare rispetto ad una delle operazioni di trattamento previste. Per esse rimane invece inalterata la possibilità di procedere alla miscelazione dei rifiuti tramite miscelazione, in deroga e non in deroga, sulla base dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla società ricorrente. Dalla prescrizione censurata non emerge pertanto alcun aggravio gestionale che valga a configurare i prospettati profili di eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di proporzione, né tanto meno una violazione del sopra citato art. 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
48. Costituiscono poi misure meramente specificative di quelle previgenti, correlate all’intervenuto riesame dell’autorizzazione integrata ambientale, e dunque evidentemente legittime, le prescrizioni jj) e kk), le quali impongono al gestore l’adeguamento dei documenti di pianificazione dell’impianto autorizzato (piano di gestione operativa e monitoraggio ambientale - PGO e piano di monitoraggio e controllo - PMC), con effetto di integrazione automatica da parte del provvedimento impugnato di quelli vigenti alla data della sua adozione.
49. Si prestano quindi ad un esame congiunto le censure svolte nei confronti delle prescrizioni ll), mm), oo), con le quali si richiede al gestore di installare un campionatore automatico in ingresso/uscita dal comparto chimico-fisico, «in grado di prelevare un campione medio giornaliero rappresentativo su cui devono essere verificate quotidianamente le concentrazioni degli inquinanti traccianti individuati in fase di omologa dei rifiuti sottoposti a trattamento»; e si prevedono i conseguenti obblighi di comunicazione alle autorità competenti in caso di superamento e di predisposizione di una «procedura per la gestione dei superamenti delle concentrazioni rilevate nel corso dei monitoraggi»; pp), impositiva della presenza di «un punto di prelievo in uscita dalla “linea oleosi” in corrispondenza del quale devono essere monitorati quotidianamente gli inquinanti traccianti e, in ogni caso, almeno gli inquinanti “Oli minerali” e “Boro”»; e qq), relativa al campionatore automatico in uscita dalla vasca V2B, «in corrispondenza del quale devono essere monitorate, con frequenza settimanale, le concentrazioni degli inquinanti traccianti individuati in fase di omologa dei rifiuti sottoposti a trattamento». Sul punto, la sentenza di primo grado ha innanzitutto dato atto che le prescrizioni rispondono a proposte formulate in sede procedimentale dal gestore dell’impianto, in particolare per quanto concerne il campionamento in uscita dal trattamento chimico-fisico; o che comunque lo stesso gestore ha dichiarato di svolgere in via ordinaria: «già nella nota -OMISSIS- aveva dichiarato di effettuare quotidianamente le analisi in uscita dalla linea oleosi, così riconoscendo l’imprescindibilità di tali analisi». Inoltre ha diffusamente motivato sulla loro coerenza con le BAT di riferimento, nella cui direzione è stata esercitata la discrezionalità tecnica spettante alla competente amministrazione provinciale. A quest’ultimo riguardo ha richiamato i fini da queste ultime enunciati, consistenti nel migliorare le prestazioni ambientali dell’impianto con la riduzione delle emissioni, per raggiungere i quali è legittimo introdurre «valori di riferimento» in uscita dai comparti ulteriori rispetto a quelli autorizzati allo scarico, ulteriori ma comunque strumentali rispetto ai «valori limite di emissione», come definiti dal sopra citato art. 5, comma 1, lett. i-octies), del testo unico dell’ambiente.
50. Se ne ricava che lo scopo perseguito è quello di monitorare in corso di processo l’efficacia dei trattamenti applicati per l’abbattimento degli inquinanti nei rifiuti la loro base legittimamente è individuabile sul piano tecnico nelle BAT appositamente richiamate nel provvedimento impugnato, nell’ambito della cornice normativa delineata dal sopra citato art. 29-sexies, comma 9, del testo unico ambientale, attributivo del potere discrezionale di introdurre nel titolo autorizzativo ulteriori specifiche condizioni di esercizio «giudicate opportune». Peraltro, nell’installazione di dispositivi di campionamento e prelievo e negli obblighi di rilevamento così imposti al gestore, evidentemente riconducibili alle operazioni di trattamento dei rifiuti autorizzate, non sono ravvisabili particolari aggravi gestionali che possano valere a configurare profili di illegittimità nella sottostante valutazione di carattere tecnico-discrezionale dell’autorità competente.
51. Un discorso articolato va svolto con riguardo alla prescrizione ss) con cui sono disciplinate le operazioni di miscelazione dei rifiuti, la quale si prefigge di mantenere separati i rifiuti trattati nelle diverse linee dell’impianto, onde evitare «diluizioni e/o miscelazioni dei rifiuti prodotti dall’impianto allo scopo di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di un impianto di destinazione». Viene al riguardo prospettata la falsa applicazione degli artt. 183, lett. a), recante la definizione di rifiuto («qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi»), e 187 del testo unico ambientale, il quale a sua volta enuncia il divieto di «miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi», e precisa che la miscelazione «comprende la diluizione di sostanze pericolose». Si sostiene al riguardo che l’unione dei flussi provenienti dai vari comparti dell’impianto non ricadrebbero nel divieto da ultimo richiamato, poiché esse concernerebbero flussi di processo, ai sensi dell’art. 127 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed afferirebbero ad operazioni incluse nell’autorizzazione integrata ambientale.
52. Sennonché le censure si fondano su un presupposto erroneo, secondo cui le operazioni di miscelazione all’interno dell’impianto gestito dalla ricorrente non concernerebbero sostanze qualificabili come rifiuti. Sul punto, la sentenza di primo grado ha diffusamente motivato in ordine al fatto che i flussi di sostanze provenienti dalle diverse linee di trattamento sono giuridicamente inquadrabili come rifiuti, derivanti da operazioni di smaltimento previste dal sopra citato allegato B alla parte IV del testo unico dell’ambiente (in particolare: D9 - trattamento fisico-chimico che dia origine a composti o a miscugli eliminati), e svolte in un impianto a ciò autorizzato, con conseguente inapplicabilità dell’art. 127 del medesimo testo unico. Dirimente a questo riguardo - come del pari statuito dalla pronuncia di primo grado - è l’art. 184-ter, comma 5, del testo unico sull’ambiente, che sancisce l’applicazione della disciplina in materia di gestione dei rifiuti «fino alla cessazione della qualifica di rifiuto».
53. La legittimità della contestata prescrizione è quindi ricavabile: innanzitutto dall’art. 184, comma 5-ter, del testo unico, secondo cui «(l)a declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto»; ed inoltre dai principi affermati in materia dalla Corte costituzionale, nella sentenza del 12 aprile 2017, n. 75, richiamata anche dalla sentenza appellata, con la quale si è tra l’altro statuito che la miscelazione di rifiuti è attività che ai sensi della Direttiva 2008/98/CE rientra nel concetto di trattamento di rifiuti. Del resto, sul piano logico la tesi della società ricorrente si pone in urto con l’incontestabile dato di fatto che i trattamenti svolti nell’impianto da essa gestito e concernenti rifiuti liquidi consistono nella separazione degli inquinanti in funzione del suo smaltimento. Risulta pertanto evidente che esso mantenga tale qualificazione dal punto di vista giuridico, laddove si palesa al contrario incongruo predicarne le caratteristiche di refluo trattato in impianti di depurazione. Nel medesimo senso si pone l’art. 3 della direttiva 2008/98/CE, poc’anzi richiamata, che definisce produttore di rifiuto: «chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti». Ne deriva che diversamente da quanto suppone l’appello è pienamente applicabile il poc’anzi richiamato divieto sancito dall’art. 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
54. Deve ancora aggiungersi che la legittimità dei limiti alla miscelazione posti con la contestata prescrizione trova conferme nella normativa tecnica di riferimento (BAT Reference Document for Waste Treatment - Bref -OMISSIS-), relativamente ai rifiuti liquidi a base acquosa (§§ 1.3.4 e 5.7.1). I medesimi limiti sono inoltre coerenti con gli obiettivi di recupero del rifiuto, in un contesto in cui - come sottolinea l’amministrazione provinciale - difetta una definizione a livello legislativo dell’operazione. Ne risulta un quadro in cui la disciplina dell’attività è rimessa alla prassi amministrativa, come nell’ambito provinciale di Trento, la cui definizione - «operazione fisica intenzionale ed elaborata attraverso la quale si ottiene la creazione di un miscuglio nel quale i rifiuti di partenza, messi in contatto intimo tra di loro, diventano indistinguibili e non è più possibile procedere, inversamente, alla loro separazione se non tramite processi industriali spinti» - ha ottenuto la validazione delle autorità nazionali competenti (nota ISPRA in data 19 settembre 2014, prot. n. 37561).
55. Sul piano strettamente tecnico sono emerse le ragioni del divieto, riconducibili all’esigenza, derivante dal divieto sancito dal citato art. 184, comma 5-ter, del testo unico ambientale, di tenere separati i rifiuti prodotti nelle due sezioni del comparto chimico-fisico dell’impianto (linea oleosi e frazione “diversi”) per le diverse caratteristiche fisico-chimiche e di pericolosità delle sostanze ivi trattate. Le considerazioni ora svolte si addicono alle diverse operazioni autorizzate con il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale: miscelazione tra fanghi chimico-fisici e fondami di autobotte e tra fanghi e flottato.
56. Non diversamente va affermato con riguardo alla prescrizione tt), relativa ai requisiti delle operazioni di equalizzazione-omgeneizzazione, ed in relazione al quale viene contestata, in chiave limitativa dei medesimi trattamenti autorizzati, la previsione del requisito dell’omogeneità di rifiuti per inquinanti traccianti e livello di trattabilità; e la registrazione delle informazioni sui traccianti, sui reagenti impiegati e sulle relative quantità. La prescrizione si palesa infatti come coerente applicazione dell’esigenza, sancita dalle BAT applicabili (la sentenza ha sul punto richiamato «i paragrafi 2.1.4 e 2.3.6.2.1 del BRef di settore»), di eliminare le sostanze contaminanti dei rifiuti sulla base dei trattamenti autorizzati, rispetto al quale costituisce pre-condizione l’omogeneità del rifiuto quanto a inquinanti traccianti e livello di trattabilità.
57. Non costituisce misura inattuabile la prescrizione uu), recante l’obbligo di programmazione del trattamento D9 e D8 con un anticipo di almeno 72 ore. Si tratta di una previsione rispondente alle esigenze manifestate dalla stessa società ricorrente e formalizzate nel programma di gestione operativa, di stabilizzare il funzionamento dell’impianto, attraverso una regolare alimentazione delle diverse linee produttive.
58. Nella legittima direzione di migliorare il rendimento ambientale dell’impianto si pone poi la prescrizione ww), impositiva di uno studio di fattibilità per miglioramenti strutturali relativi al pretrattamento di rifiuti pericolosi contenenti boro, piombo, nichel, solventi organici e solventi clorurati. Come rilevato dalla sentenza di primo grado, essa trova fondamento giustificativo negli esiti della relazione APPA per il biennio -OMISSIS-, recante rilievi critici sui trattamenti riguardanti gli inquinanti ora menzionati.
59. Sono poi infondate le contestazioni nei confronti della prescrizione xx), nella misura in cui essa si limita a disciplinare l’utilizzo di rifiuti, in luogo di materie prime, ai fini del trattamento, in conformità alle BAT applicabile (22), e non già in senso impeditivo, come invece supposto dalla società ricorrente. Gli assunti si imperniano sul fatto che l’ora richiamata BAT non recherebbe alcun riferimento a impurità e traccianti, che invece la contestata prescrizione richiede di abbattere. Sennonché in contrario è sufficiente rilevare che la BAT prevede testualmente il «rischio di contaminazione rappresentato dalla presenza di impurità (ad esempio metalli pesanti, POP, sali, agenti patogeni) nei rifiuti che sostituiscono altri materiali», per cui la prescrizione si palesa legittima sotto il profilo ora evidenziato.
60. Con riguardo alle ulteriori contestazioni relative alle prescrizioni generali concernenti la miscelazione è sufficiente richiamare i rilievi in precedenza svolti, ed in particolare la sopra esposta conformità delle misure adottate dall’amministrazione provinciale rispetto all’art. 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai principi affermati in materia dalla sopra richiamata sentenza della Corte costituzionale del 12 aprile 2017, n. 75. Non emergono poi profili scorretto esercizio della discrezionalità tecnica nel fatto di avere richiesto che la miscelazione deve avvenire «secondo il presupposto di unire rifiuti con caratteristiche chimico-fisiche analoghe e in modo tale da ottenere la rispondenza a specifiche tecniche richieste dalle successive operazioni di trattamento nell’installazione o in altri impianti» (c), e che le miscele di rifiuti «devono essere ottimizzate ed omogenee in base alle specifiche tecniche richieste dalle successive operazioni di trattamento nell’installazione o in altri impianti» (d). Entrambe sono dirette a consentire un ottimale trattamento sulla base delle caratteristiche dei rifiuti. Del pari la prescrizione e), a mente della quale la miscelazione va svolta «esclusivamente tra rifiuti con il medesimo stato fisico (es. liquido con liquido o fangoso pompabile)», non appare tale da comportare alcuna limitazione operativa ma risponde ad un incontestabile dato di natura.
61. Nessun preteso ordine di rimozione della sezione di filtrazione su sabbia e carboni attivi installata presso lo scarico S1 è inoltre ricavabile dalla relativa prescrizione, alla luce della descrizione dei trattamenti contenuta nel rapporto istruttorio oltre che nel capoverso successivo della prescrizione contestata.
62. Risultano conseguentemente infondate tutti gli assunti intesi a sostenere aggravi di costi di gestione dell’impianto.
63. Va inoltre confermata la statuizione di rigetto parziale delle censure relative ai termini di adempimento alle prescrizioni, condivisibilmente fondata sulla mancanza di necessità di intervenire attraverso adeguamenti impiantistici.
64. Le considerazioni finora svolte inducono a ritenere irrilevante l’assoluzione in sede penale riportata dalla società ricorrente per imputazioni varie, relative alle operazioni di trattamento dei rifiuti autorizzate nell’impianto di smaltimento gestito dalla società ricorrente, tra cui la miscelazione non autorizzata per partite non omogenee. Nella presente sede amministrativa, concernente il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell’art. 29-octies, comma 3, lett. a), del testo unico ambientale, si controverte in ordine al distinto profili concernente la conformità a legge delle misure imposte dall’autorità competente per il legittimo scopo di migliorare il rendimento ambientale dell’impianto di smaltimento dei rifiuti, nell’ambito dell’ampia discrezionalità a quest’ultimo attribuita dalla legge, e sulla base degli elementi di carattere tecnico a disposizione, perché forniti dal soggetto autorizzato o acquisiti attraverso gli appositi controlli di legge. In questo ambito, la mancata dimostrazione in sede penale del superamento dei limiti autorizzati allo scarico non vale evidentemente ad elidere il potere amministrativo di disciplina delle attività di trattamento dei rifiuti nell’ambito dell’impianto autorizzato, il quale anzi si pone nella medesima direzione di raggiungere gli obiettivi di carattere ambientale penalmente tutelati.
65. Sono invece fondate le contestazioni relative alla condanna alle spese del giudizio di primo grado nei confronti della società ricorrente, pronunciata malgrado l’accoglimento sia pure solo parziale delle censure da essa dedotte, la quale impedisce di configurare nei suoi confronti una piena soccombenza ex art. 91, comma 1, cod. proc. civ., ed inoltre senza considerare l’estrema complessità tecnico-giuridica delle questioni controverse.
66. Pertanto, in riforma della statuizione sulle spese del giudizio di primo grado, queste vanno compensate, come anche quelle del presente appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, limitatamente alla condanna alle spese del giudizio di primo grado, con conferma nel resto.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF, Estensore
Giordano Lamberti, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere