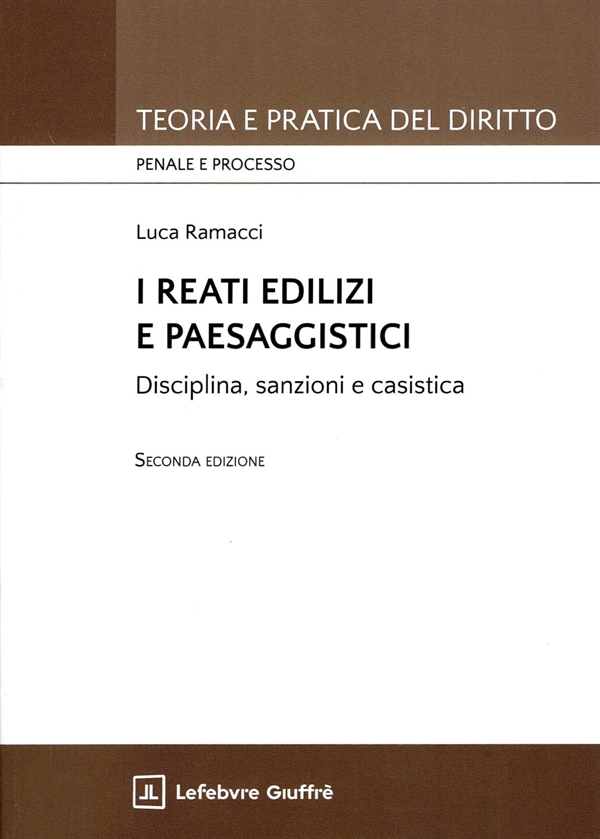Le opere di urbanizzazione e gli impianti dei rifiuti (da una lettura sul regime Iva)
Le opere di urbanizzazione e gli impianti dei rifiuti (da una lettura sul regime Iva)
di Alberto PIEROBON
(1)
Com’è noto, le operazioni Iva sono assoggettate, ordinariamente, alla aliquota generale del 20%, salvo espressa, specifica, elencazione nelle tabelle allegate al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per le quali sono previste aliquote ridotte “speciali”.
Così, il numero 127-quinquies della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 recante l’“Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”, individua, tra le operazioni soggette all’aliquota Iva del 10%:
- le opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
- linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso;
- impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica;
- impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione;
- edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949 n. 408, e successive modificazioni>.
La legge 29 settembre 1964, n. 847, sintomaticamente titolata “Autorizzazione ai comuni e loro consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167”, all’articolo 4 indica le “Opere di urbanizzazione primaria” precisando che:
“Le opere di cui all'art. 1, lettera b), sono quelle di urbanizzazione primaria e cioè:
a. strade residenziali;
b. spazi di sosta o di parcheggio;
c. fognature;
d. rete idrica;
e. rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
f. pubblica illuminazione;
g. spazi di verde attrezzato” .
Mentre le opere di urbanizzazione secondaria sono le opere di cui all'art. 1, lettera c), ovvero “le seguenti:
a. asili nido e scuole materne;
b. scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo;
c. mercati di quartiere;
d. delegazioni comunali;
e. chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
f. impianti sportivi di quartiere;
g. centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
h. aree verdi di quartiere”.
La previgente normativa sui rifiuti (conosciuta anche come “decreto Ronchi”), cioè il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 “Attuazione delle direttive 91/156/CE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” al comma 1, dell’art. 58 (“Disposizioni finali”) stabilisce che:
“Nelle attrezzature sanitarie di cui all’art. 4, secondo comma, lett. g), della L. 29 settembre 1964, n.847, sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate”.
L’attuale codice ambientale, ovvero il comma 1 dell’art. 266 (“disposizioni finali”), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm. e ii. si limita a pedissequamente ripetere la predetta disposizione.
Per cui gli (si badi) anzidetti (non altri, per quanto si dirà) impianti di rifiuti rientrano tra le “opere di urbanizzazione secondaria” (sub “attrezzature sanitarie”).
La catalogazione delle opere di urbanizzazione, riferite al regime Iva ridotto, risponde a diversi criteri (e funzioni):
- indispensabilità: citasi, richiamando i criteri di cui oltre, le strade residenziali (anche se realizzate fuori dall’ambito urbano, ovvero in aree destinate ad accogliere centri abitativi, ma non le strade a servizio di aree industriali destinate ad attività produttive, se non a destinazione aziendale) spazi di sosta e di parcheggio, fognature, rete di distribuzione elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato, acquedotto o rete idrica (ivi compresi gli impianti di captazione dell’acqua alla sorgente).
- tassatività: non potendosi interpretare in senso estensivo o analogico gli intereventi di cui trattasi;
- eccezionalità: rispetto alla regola generale o “ordinaria”, per cui spetta al’interessato (nella veste di contribuente), che voglia godere del regime Iva al 10% anziché al 20% far valere tali circostanze, provando l'esistenza dei presupposti per la loro applicazione (e cioè dei fatti costituenti il fondamento della sua eccezione);
- funzionalizzazione allo interesse collettivo, aggregato, per soddisfare (anche potenzialmente) un bisogno (dell’igiene, della viabilità e sicurezza).
Occorre, ora, domandarsi il senso di una siffatta previsione normativa, ovvero dell’inserire gli impianti di smaltimento, di riciclaggio e di distruzione riferiti a tutti i rifiuti entro questo regime Iva.
Anzitutto, l’aver inserito gli impianti di smaltimento, di distruzione e di riciclaggio dei rifiuti tra le attrezzature sanitarie (entro, appunto, la elencazione delle opere di urbanizzazione secondaria) è sintomatico della risalente visione igienico-sanitaria che contrassegna ancora la gestione dei rifiuti, anche nella normativa recente (si veda per esempio quella cosiddetta “emergenziale” adottata, soprattutto, per la Regione Campania). Visione, come sanno gli operatori del settore, sbiaditasi nel tempo così come si è, al contempo, opacizzato il confine della “gestione” pubblica (la quale ultima strizza l’occhio alla “funzione” esercitata dai soggetti pubblici, in un reciproco gioco di “favori”).
Si attenziona, poi, il lettore sul fatto che trattasi, questi, di impianti riferiti a tutti i rifiuti, qualunque essi siano (urbani, speciali, pericolosi, non pericolosi, solidi e liquidi) oltre alle bonifiche.
Inoltre, ricordando i criteri che ricorrono per la lettura di queste disposizioni “speciali” sull’Iva ridotta per le opere di urbanizzazione, pare – in prima battuta - doversi concludere, paradossalmente, che gli impianti di recupero dei rifiuti non possano beneficiare dell’Iva al 10%, proprio perché il legislatore ha utilizzato (inconsapevolmente, ovvero nelle definizioni di vecchio conio, echeggianti il d.P.R. n. 915 del 1982) il termine <riciclaggio>, che è una species del genus recupero di materia (2).
Tra altro, non si comprende perché la risoluzione ministeriale dell’Agenzia delle entrate - Direzione centrale normativa in data 15 marzo 2011 n. 34 relativa agli “Impianti di captazione del biogas - Aliquota Iva agevolata” debba rifarsi ad una nota del Ministero dello sviluppo economico per affermare che “gli impianti di captazione del biogas rientrano tra gli impianti di smaltimento dei rifiuti, dei quali costituiscono parte integrante e conclusiva del processo”: la normativa tecnica sul punto è chiara e, come dire, “consolidata” (3).
Inoltre, la formulazione del MSE è certamente erronea allorquando parla di riutilizzo delle varie categorie di rifiuti, poiché il termine “riutilizzo” collide con la qualificazione di rifiuto, in quanto il riutilizzo (4), come sappiamo, presuppone l’esistenza di beni (non di rifiuti) non necessitanti di trattamento.
Manca quindi una lettura sincretica e concreta della disciplina in parola. Manca altresì un confronto tra le diverse discipline e i diversi soggetti ad esse riferite (quantomeno per la prassi – circolari, pareri, risoluzioni, indirizzi, eccetera – dei diversi Ministeri: delle economia e delle finanze; dello sviluppo economico; dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare).
Ma, soprattutto, manca la consapevolezza della necessità, in parte qua, di bilanciare i diversi interessi compresenti, in una scelta che non può essere rimessa al soggetto tecnico (in quanto trattasi di scelta assiologica), bensì politica dove entrano in gioco elementi valoriali di mercato, ambientali e dei diversi interessi (soprattutto pubblico) i quali elementi, a nostro avviso, sono stati pigramente ripetuti dal legislatore al di là dell’evoluzione storico-sociale-economica nel frattempo avvenuta, oltre che di quella normativa (5).
--------
(1) La tematica è stata da noi disaminata, in modo più completo e approfondito, in uno scritto (di prossima pubblicazione) per la rivista “L’Ufficio Tecnico” delle Edizioni Maggioli, al quale si rinvia.
(2) Secondo la direttiva 2008/98/CE, il riciclaggio è “qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non ….” art. 3, punto 17, il riciclo tende quindi ad un recupero degli oggetti, sostanze e materiale per la loro funzione originaria o per altri fini (quindi abbiamo ancora un rifiuto: art. 6/1 e 3, fino all’operazione completa di recupero: art. 15/2). Il recupero è “qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. L’allegato II riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero” art. 3, punto 15 cit. direttiva. Per recupero di energia si intende l'utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti, ma con recupero del calore. L’art. 4 della direttiva 2008/98/CE fissa la nuova gerarchia dei rifiuti che si scansiona nelle seguenti attività: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e; e) smaltimento.
(3) Si rinvia, ancora, allo scritto in pubblicazione per la rivista “L’Ufficio Tecnico” della Maggioli.
(4) Che per la direttiva 2008/98/CE viene definito “qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti” art.3 punto 13.
(5) In proposito ci si permette rinviare, ancora, allo esempio contenuto nel già citato scritto di cui alla rivista “L’ufficio Tecnico” delle Edizioni Maggioli.