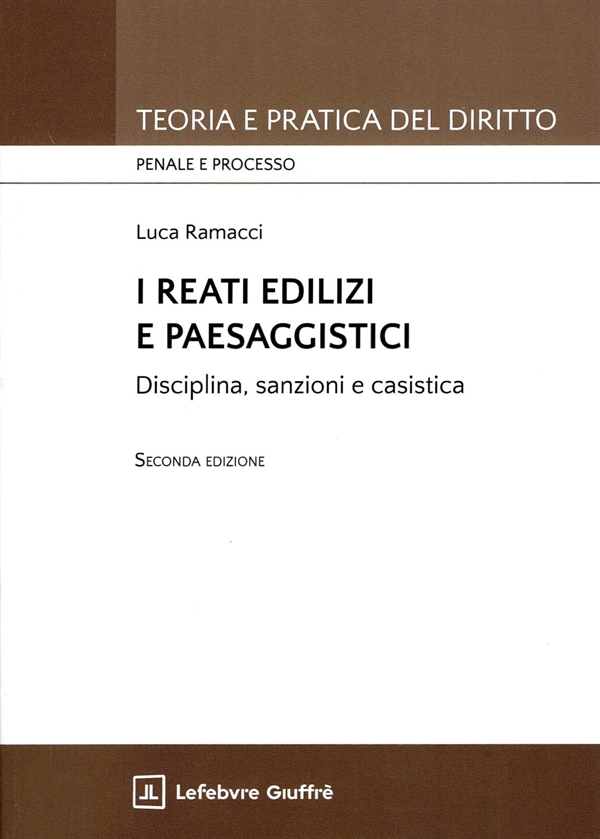Procedura estintiva delle contravvenzioni alimentari: le prime risposte della Cassazione
Procedura estintiva delle contravvenzioni alimentari: le prime risposte della Cassazione
di Vincenzo PAONE
pubblicato su www.rivistadga.it. Si ringraziano Autore ed Editore
1. La nuova causa estintiva delle contravvenzioni alimentari. – 2. Obbligatorietà della prescrizione di regolarizzazione. - 3. Quando non vi è nulla da regolarizzare, la procedura si applica? – 4. Concorso tra delitto e contravvenzione.
1. -La nuova causa estintiva delle contravvenzioni alimentari.L’art. 70, comma 1, d.lgs. n. 150/2022, c.d. Riforma Cartabia, ha introdotto nel settore dei reati alimentari la procedura di estinzione delle contravvenzioni 1 con il preciso scopo di ottenere consistenti risultati in termini di deflazione del carico giudiziario. Nella Relazione illustrativa al decreto (pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 245 del 19 ottobre 2022 - Suppl. straordinario n. 5) si evidenzia, infatti, che «Nel contesto di un intervento volto a migliorare l’efficienza del processo penale, in linea con gli obiettivi del P.N.R.R. tesi alla riduzione della durata media dei procedimenti, la legge delega intende valorizzare ulteriormente una causa estintiva del reato già prevista nel sistema e destinata a operare nella fase delle indagini preliminari, in rapporto a reati di non particolare gravità».
La disciplina della causa estintiva è stata inserita nella legge n. 283/1962 con una serie di articoli successivi all’art. 12 bis ed è strutturata in alcuni passaggi che possono così riassumersi:
- accertamento di un reato in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande;
- emissione di una prescrizione da parte delle autorità amministrative di vigilanza e dei corpi di polizia o dei Carabinieri (come i Nuclei Anti Sofisticazione e Sanità N.A.S.) specializzati nell’accertamento dei reati nei menzionati ambiti;
- controllo dell’adempimento puntuale e conforme;
- ammissione del trasgressore al pagamento in forma ridotta;
- comunicazione al P.M. (al quale la notizia di reato va trasmessa unitamente alla prescrizione impartita) dell’eventuale mancato adempimento della prescrizione oppure del mancato pagamento della sanzione;
- archiviazione del procedimento o esercizio dell’azione penale.
Nulla di nuovo rispetto al modello introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 758/1994 in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro e replicato in materia di tutela ambientale 2 anche se la riforma del 2022 ha inserito alcune disposizioni che potrebbero dar origine a criticità in sede applicativa.
Tra le novità, segnaliamo l’art. 12 ter, legge n. 283/1962 che ha stabilito che la procedura si applica «Salvo che [le contravvenzioni: ndr ] concorrano con uno o più delitti»: questa disposizione è stata oggetto di analisi da parte della Cassazione in una recente decisione 3 cui ci richiameremo nel corso di questo contributo.
Prima di esaminare la risposta della Corte a questo specifico tema, vale la pena ricordare che la sentenza ha ribadito, con riferimento al settore delle contravvenzioni alimentari, l’orientamento maturato nel settore della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale in relazione a due particolari questioni:
- l’organo di vigilanza ha l’obbligo di impartire al contravventore un’apposita prescrizione e, in caso di omessa sua emanazione, l’azione penale è improcedibile?
- qualora risultasse impossibile impartire una prescrizione, perché non vi è nulla da regolarizzare (ipotesi della c.d. condotta esaurita), il contravventore ha ugualmente diritto ad avvalersi del meccanismo estintivo?
2. -Obbligatorietà della prescrizione di regolarizzazione. La Cassazione ha sostenuto che, anche con riferimento alle contravvenzioni punite dalla legge n. 283/1962, l’omessa indicazione delle prescrizioni di regolarizzazione non è causa di improcedibilità dell’azione penale.
Non siamo del tutto convinti della bontà di questa conclusione per le ragioni che seguono.
La procedura estintiva presenta due momenti che vanno tenuti ben distinti tra di loro: il primo, è la fase in cui l’organo di vigilanza o la polizia giudiziaria impartisce una specifica prescrizione per l’estinzione della contravvenzione accertata; il secondo, è la fase in cui, constatato l’adempimento tempestivo e conforme, l’organo di vigilanza ammette il contravventore al pagamento in forma ridotta.
La distinzione di queste due fasi non compare nell’analisi svolta dalle sentenze che si sono espresse sulla questione. È invece essenziale tenere presente questo profilo perché la normativa non esclude che la procedura possa consistere nell’attuazione della sola seconda fase della medesima.
Ciò si verifica, in primo luogo, in caso di regolarizzazione dell’illecito realizzata autonomamente e spontaneamente dallo stesso contravventore prima dell’intervento prescrittivo dell’organo di vigilanza: è l’ipotesi oggetto della sentenza della Corte cost. 18 febbraio 1998, n. 19 4 che ha stabilito che, in tal caso, l’organo di vigilanza si deve limitare ad ammettere il contravventore all’oblazione amministrativa in virtù del meccanismo denominato “ora per allora”.
In secondo luogo, la regolarizzazione potrebbe non essere più possibile: è l’ipotesi oggetto di Cass. 18 aprile 2019, n. 36405 5 che ha ritenuto che la procedura di estinzione delle contravvenzioni si applichi anche alle c.d. condotte esaurite dovendosi come tali intendere quelle prive di conseguenze dannose o pericolose per cui risulti inutile o impossibile impartire prescrizioni al contravventore.
Nelle appena citate situazioni, la procedura è “contratta” perché vi è l’immediato passaggio alla fase di ammissione al pagamento in sede amministrativa, anche su richiesta del contravventore, con il meccanismo denominato “ora per allora”.
Ciò posto, la questione è se gli organi accertatori abbiano o meno l’obbligo di impartire la prescrizione, allorché vi sia qualcosa da regolarizzare, o di ammettere all’oblazione il contravventore, allorché non vi sia nulla da regolarizzare.
Nonostante l’autorevole opinione contraria del Supremo Consesso, riteniamo che non vi sia spazio per sostenere che l’organo di vigilanza non sia “obbligato” ad impartire la prescrizione di regolarizzazione in tutte le situazioni in cui vi sia “qualcosa da regolarizzare”.
Se così non fosse, e quindi se la norma venisse intesa nel senso che l’organo ha la mera “facoltà” di ingiungere la regolarizzazione, senza neppure dover esplicitare le ragioni di tale scelta, è evidente il rischio di un eccesso di soggettività in capo all’organo di vigilanza che potrebbe originare ingiustificate disparità di trattamento perché, a fronte di identiche contravvenzioni commesse da soggetti diversi, il differenziato comportamento dell’organo pubblico potrebbe impedire al contravventore di utilizzare la causa di non punibilità dal reato, cui invece avrebbe diritto.
Nonostante questa netta presa di posizione, siamo dell’avviso che, all’omessa – ancorché erronea – emanazione della prescrizione, non segua necessariamente l’improcedibilità dell’azione penale. Va infatti tenuto conto che la procedura di estinzione delle contravvenzioni assolve a varie finalità:
a) regolarizzare la situazione alterata dalla commissione del reato;
b) offrire al contravventore la possibilità di godere di un rilevante beneficio;
c) operare una consistente deflazione dei processi penali.
È evidente che il contravventore non abbia alcun interesse concreto al rispetto delle finalità sub a) e c), essendo interessato soltanto alla definizione del procedimento in sede pre-processuale con il pagamento in forma ridotta della sanzione.
Tenendo conto di quanto sopra, riteniamo che la tutela del contravventore non sia garantita dalla predisposizione di una condizione di procedibilità, bensì dalla previsione del suo diritto di ottenere lo stesso risultato favorevole mediante la richiesta di ammissione al pagamento in forma ridotta tutte le volte in cui il soggetto abbia eliminato la contravvenzione spontaneamente, prima dell’intervento dell’organo di vigilanza, oppure non possa oggettivamente provvedere ad alcuna regolarizzazione (c.d. condotta esaurita).
In altri termini, se il trasgressore non è ammesso all’oblazione, il medesimo ha la possibilità (e l’onere) di rivolgersi direttamente all’organo di vigilanza per l’attuazione della seconda fase della procedura estintiva e cioè ammissione al pagamento in forma ridotta.
In proposito, un punto va debitamente chiarito: spesso la Suprema Corte, affrontando questa problematica, ha sostenuto che il soggetto potrebbe anche chiedere al giudice di essere ammesso all’oblazione ai sensi dell’art. 162 bis c.p. L’affermazione è astrattamente corretta, ma il problema è che questa norma prevede che la somma da versare sia pari alla metà del massimo dell’ammenda edittale, mentre in sede amministrativa (v. art. 12 quater, comma 2) la somma è pari ad un sesto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa e perciò le due procedure, da questo punto di vista6, non sono affatto “intercambiabili”.
In termini analoghi, si può affrontare l’ipotesi in cui l’organo di vigilanza non abbia impartito la prescrizione, pur essendovi qualcosa da regolarizzare. Si aprono infatti due scenari:
a) il contravventore ha provveduto autonomamente e spontaneamente alla regolarizzazione, il che fa confluire tale situazione nell’ipotesi in precedenza considerata (con il passaggio immediato all’oblazione in sede amministrativa);
b) il contravventore non ha comunque provveduto alla regolarizzazione e pertanto viene rinviato a giudizio per il reato accertato.
In questa seconda evenienza, anche se volessimo ritenere che la normativa abbia effettivamente configurato una condizione di procedibilità collegata all’omessa ingiunzione alla regolarizzazione, l’imputato non ha alcun motivo di dolersi della violazione per assoluta mancanza di interesse. Infatti, non avendo comunque regolarizzato l’illecito, il contravventore non potrebbe in ogni caso avvalersi del meccanismo “premiale” sicché dall’annullamento della sentenza emessa senza il rispetto della condizione di procedibilità non potrebbe derivare a suo favore un concreto e rilevante effetto positivo.
3. -Quando non vi è nulla da regolarizzare, la procedura si applica?Nel paragrafo che precede, abbiamo dato per pacifico che la procedura estintiva si applichi anche in caso di c.d. condotta esaurita. Ora torniamo sull’argomento per prospettare alcune perplessità alla tesi sostenuta, in modo ormai consolidato, dalla Cassazione orientata nel senso anzidetto.
Partiamo dal fatto che la prescrizione vada impartita quando la contravvenzione sia suscettibile di eliminazione 7 il che non può che voler dire:
a) interrompere la condotta che integra un reato permanente,
b) rimuovere gli effetti della condotta completamente esaurita (a prescindere che il reato sia permanente oppure istantaneo).
Vi sono però casi in cui non è possibile impartire la prescrizione per l’impossibilità giuridica o materiale di ripristinare lo status quo ante .
Come si è ricordato in precedenza, la Suprema Corte8, pronunciandosi in una fattispecie rientrante nel settore della tutela dell’ambiente, ha affermato che la procedura estintiva debba trovare applicazione in tutte le ipotesi di «condotta esaurita», vale a dire tutte le condotte prive di conseguenze dannose o pericolose per cui risulti inutile o impossibile impartire prescrizioni al contravventore9.
Al centro del ragionamento è stato posto l’art. 15 d.lgs. n. 124/2004, razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, che, secondo la tesi qui criticata, avrebbe esteso il meccanismo estintivo alle fattispecie a “condotta esaurita”.
L’articolo citato recita:
«1. Con riferimento alle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale la cui applicazione è affidata alla vigilanza della direzione provinciale del lavoro, qualora il personale ispettivo rilevi violazioni di carattere penale, punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero con la sola ammenda, impartisce al contravventore una apposita prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e per gli effetti degli articoli 23 e 24 e 25, comma 1, dello stesso decreto.
2. L’articolo 22 del citato decreto legislativo n. 758 del 1994, trova applicazione anche nelle ipotesi di cui al comma 1.
3. La procedura di cui al presente articolo si applica anche nelle ipotesi in cui la fattispecie è a condotta esaurita, ovvero nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all’adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all’emanazione della prescrizione».
La prima obiezione alla tesi sostenuta dalla Suprema Corte risiede nel fatto che non vi è un solo elemento che consenta di ritenere l’art. 15 applicabile, in generale, a leggi diverse da quelle lavoristiche menzionate nel comma 1. Inoltre, nel 2004 non esistevano ancora le procedure estintive modellate sulla falsariga di quella contenuta nel d.lgs. n. 758/1994 ed è perciò molto difficile ipotizzare, si ripete, in assenza di precisi riferimenti testuali, che nelle intenzioni del legislatore il precetto di cui trattasi andasse esteso anche alle future normative.
In realtà, per meglio cogliere la portata della disposizione, occorre rievocare il contesto in cui la stessa si colloca.
Dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 758/1994, la Corte cost. è stata chiamata a decidere la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 1, d.lgs. n. 758/1994, per violazione dell’art. 3 Cost., «nella parte in cui non prevede che possano essere ammessi alla definizione in via amministrativa con conseguente dichiarazione di estinzione del reato coloro i quali abbiano regolarizzato la violazione prima che l’autorità di vigilanza abbia impartito la prescrizione», o «abbiano regolarizzato la violazione nonostante l’organo di vigilanza abbia omesso di impartire la prescrizione, ovvero l’abbia impartita senza osservare le forme legislativamente richieste».
Nella sentenza 18 febbraio 1998, n. 19, il Giudice delle leggi ha rilevato che «le lacune segnalate dal giudice rimettente dipendono da una difettosa formulazione tecnica della normativa in esame, derivante dall’obiettiva difficoltà di prevedere in astratto tutte le possibili situazioni equipollenti a quelle espressamente disciplinate dalla legge, e, in quanto tali, non sono dovute ad una consapevole scelta di politica legislativa. Pertanto, è senz’altro possibile un’applicazione della disciplina in base alla quale, in caso di notizia di reato acquisita da un’autorità di polizia giudiziaria diversa dall’organo di vigilanza e di spontanea regolarizzazione da parte del contravventore, l’organo di vigilanza sia autorizzato ad impartire “ora per allora” la prescrizione prevista dall’art. 20, ovvero, ed a maggior ragione, a ratificare nelle forme dovute prescrizioni irritualmente impartite, nonché a verificare l’avvenuta eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e ad ammettere il contravventore al pagamento della somma determinata a norma dell’art. 21, commi 1 e 2, sì che l’autore dell’illecito, previo pagamento della somma stabilita, possa usufruire dell’estinzione del reato disciplinata dall’art. 24».
La Corte cost. ha dunque interpretato la norma come se dicesse che possono essere ammessi alla definizione in via amministrativa anche i contravventori che hanno regolarizzato la violazione prima dell’intervento prescrittivo dell’autorità di vigilanza.
Dopo questa prima pronuncia, è particolarmente significativa l’ord. 10 dicembre 1998, n. 416 10 della stessa Corte cost. concernente proprio i reati a «condotta esaurita».
La Corte ha infatti dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 758/1994 nella parte in cui non prevede l’obbligo dell’organo di vigilanza di ammettere obbligatoriamente il contravventore al pagamento in sede amministrativa anche nel caso in cui non venga impartita alcuna prescrizione per la materiale impossibilità della sua emanazione11.
Due sono le considerazioni che si possono ricavare da questa decisione: in primo luogo, le situazioni oggetto della pronuncia riguardano proprio i casi in cui non è possibile impartire una prescrizione per la materiale impossibilità della sua attuazione ed è agevole comprendere che si tratti esattamente se non di tutti, certamente di una buona parte dei casi che ricadono nell’espressione “condotta esaurita”.
In secondo luogo, la Corte cost. ha messo l’accento sulla circostanza che l’estensione della procedura estintiva ad opera della sentenza n. 19/1998 si basava sul rilievo accordato al comportamento volontario dell’autore dell’infrazione che vi aveva posto rimedio, situazione nettamente diversa da quella di chi non ha nulla da “rimediare” perché il reato commesso è cessato senza conseguenze ulteriori passibili di eliminazione12.
In questo contesto dai contorni ben definiti, si inserisce dunque il d.lgs. n. 124/2004: da un lato, tale normativa aveva il solo scopo di estendere a leggi in materia di lavoro e legislazione sociale diverse da quelle di cui all’allegato I del d.lgs. n. 758/1994 la medesima procedura prescrizionale; dall’altro lato, il comma 3 dell’art. 15 ha esteso a settori diversi dalla sicurezza e igiene sul lavoro il meccanismo di favore previsto dalla sentenza della Corte cost. n. 19/1998.
Ne deriva il perfetto parallelismo della disciplina applicabile nei due ambiti normativi: tanto nell’uno quanto nell’altro, l’oblazione in sede amministrativa è consentita, oltre che nel caso di adempimento a seguito di prescrizione, anche nel caso in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all’adempimento degli obblighi di legge senza attendere l’imposizione della prescrizione da parte dell’organo di vigilanza.
In tal senso va intesa la formulazione dell’art. 15: la congiunzione “ovvero” ha funzione esplicativa e non disgiuntiva con la conseguenza che la fattispecie, indicata con la locuzione “condotta esaurita”, non si aggiunge all’altra fattispecie in cui «il trasgressore abbia autonomamente provveduto alla regolarizzazione del reato precedentemente all’emanazione della prescrizione».
Senonché, la Cassazione ha costantemente letto l’art. 15, comma 3, come se fosse diviso in due parti: a) ipotesi in cui la fattispecie è a condotta esaurita, e cioè non sia più possibile attuare alcuna forma di regolarizzazione; b) ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all’adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all’emanazione della prescrizione.
Per motivare questa conclusione, la giurisprudenza ha sostenuto che il legislatore ha utilizzato la congiunzione “ovvero” come equivalente di “oppure” e non di “cioè”. Invero, dal punto di vista lessicale, il significato del termine “ovvero” non è univoco e pertanto l’interpretazione fornita dalla Suprema Corte in sé è valida.
Però, in presenza di un vocabolo polisenso, il suo significato dipende da criteri diversi da quello strettamente letterale. In questa ottica, si sarebbe anche potuto tener conto che nel 2004 l’istituto estintivo era applicabile non alle “condotte esaurite” tout court, ma solo a quelle riferibili all’intervento volontario, indotto o spontaneo, da parte del contravventore.
Giunti a questo punto, la ragione sostanziale sottostante alla ricostruzione del sistema operata dalla Suprema Corte, tesa a valorizzare, pur in assenza dell’elemento di “meritevolezza” enunciato dalla Corte cost. nel 199813, tutte le ipotesi di impossibilità a rimuovere gli effetti della condotta, è quella enunciata dalla sentenza n. 36405/2019 in cui si afferma che «la Corte cost. (…) ha identificato come “deflattiva” e non “premiale” la ratio sottesa alla procedura di estinzione di cui si discute ed ha quindi implicitamente negato che la stessa sia appannaggio esclusivo del soggetto che – per prescrizione impartita dall’autorità di vigilanza o per spontaneo ravvedimento operoso – rimuova attivamente le conseguenze dell’illecito».
Ma anche questa prospettazione non persuade completamente. Infatti, è vero che la Corte cost. ha dichiarato che la disciplina del 1994 «si propone di conseguire una consistente deflazione processuale», ma è discutibile che tale finalità fosse quella prevalente. Ben altre – e forse più “nobili” – erano le finalità della legge che ha introdotto la causa estintiva di tipo premiale!
I tempi però sono cambiati: oggi soffia forte il vento della deflazione costi quel che costi sicché non ci stupiremmo se dovesse, in futuro, affermarsi, nell’ambito alimentare, la tesi che la procedura estintiva si applichi anche alle situazioni non regolarizzabili.
A questo riguardo, si fa infatti notare che nel settore dei reati alimentari lo scopo della prescrizione [a) interrompere la condotta che integra un reato permanente; b) rimuovere gli effetti della condotta cessata (a prescindere che il reato sia permanente oppure istantaneo] ben raramente potrà essere realizzato.
Infatti, le irregolarità accertate dagli organi di controllo non sono suscettibili di eliminazione mediante contro-condotte per il semplice motivo che le alterazioni/trasformazioni subite dall’alimento, nella quasi totalità dei casi, sono materialmente irreversibili.
Prendendo come esempio la norma più applicata in materia, e cioè l’art. 5, legge n. 283/1962, riscontriamo che nelle lettere da a) ad h ), la legge prevede una serie di ipotesi specifiche riguardanti le sostanze alimentari contraddistinte da non conformità (intrinseca o estrinseca) ai requisiti di igiene, purezza, genuinità e integrità, previsti dalla legge o richiesti dalla comune esperienza. Vengono infatti presi in considerazione prodotti non genuini [art. 5, lett. a)], sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione [art. 5, lett. b)], sostanze alimentari con cariche microbiche superiori ai limiti [art. 5, lett. c )], sostanze alimentari insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione [art. 5, lett. d)] o, infine, prodotti privi di purezza [art. 5, lett. g) e h)]14.
È dunque essenziale puntare l’attenzione sul risultato finale, e cioè lo stato in cui si presenta la sostanza alimentare all’atto del controllo da parte dell’organo di vigilanza.
Orbene, non si può ragionevolmente ipotizzare che una sostanza alimentare, frutto di illecite manipolazioni, di sottrazione di elementi nutritivi, di aggiunta di additivi vietati, di trattamenti con fitofarmaci non consentiti, possa essere “regolarizzata” tenendo la doverosa contro-condotta capace di aggiungere gli elementi nutritivi mancanti; di riportare l’alimento allo stato originario in cui siano distinguibili i componenti originari prima della mescolanza; di modificare la composizione del prodotto alimentare trattato in modo illecito e così via.
Insomma, tendenzialmente, il prodotto finito non può essere “ri-trattato” per offrire al consumatore un alimento genuino, igienicamente salubre e puro. Ne consegue che il ripristino dello status quo ante (vale a dire l’eliminazione dell’irregolarità cui deve essere finalizzata la prescrizione) non è possibile15.
Ciò chiarito, concentrandosi non tanto sulla condizione irregolare dell’alimento, ma sulla condotta posta in essere16, si può tuttavia pensare ad uno spazio applicativo (per vero modesto) nel caso in cui l’organo di vigilanza accerti che l’alimento, con caratteristiche difformi rispetto alle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare, sia detenuto per la vendita. In questa situazione, infatti, la prescrizione, volta ad ottenere l’osservanza tardiva della disciplina in materia, potrà essere efficacemente impartita mediante l’ingiunzione a cessare (immediatamente) la condotta illecita 17 trattandosi di reato permanente a differenza delle altre fattispecie criminose che hanno natura di reati istantanei.
Giunti al termine, si può aggiungere che se la regolarizzazione è materialmente impossibile nella maggioranza delle violazioni alimentari e se ciò nonostante dovesse prendere piede, come è probabile, il meccanismo estintivo in presenza di condotta c.d. esaurita, vi è il rischio di un profondo stravolgimento della nuova legge perché il beneficio premiale è disancorato da qualsiasi intervento volto a elidere il danno o il pericolo insito nella violazione stessa.
4. -Concorso tra delitto e contravvenzione.Come abbiamo detto all’inizio, l’art. 12 ter, legge n. 283/1962 stabilisce che la procedura non si applichi se la contravvenzione concorra con uno o più delitti. Intesa in senso strettamente letterale, la previsione potrebbe ridurre notevolmente i casi in cui la nuova disciplina potrà entrare in gioco perché è frequente che lo stesso fatto integri tanto una contravvenzione (ad es. una delle molteplici fattispecie previste dall’art. 5, legge n. 283/1962) quanto un delitto, come la frode in commercio o la messa in vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine18.
Nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150/2022 si legge che « Rispetto al modello di disciplina già da tempo sperimentato in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente, la legge delega introduce alcuni elementi di novità:
a) esclude che la causa estintiva operi quando le contravvenzioni concorrono con delitti: l’economia processuale realizzata con l’archiviazione del procedimento non si determina, infatti, quando il procedimento stesso deve proseguire per concorrenti delitti».
Tradotto in parole povere, è come se il legislatore avesse detto: visto che il procedimento penale deve comunque proseguire, perché per il delitto la causa estintiva non opera, tanto vale farlo proseguire anche per la contravvenzione!
Sfugge però la logica di un siffatto ragionamento. Infatti, anche nel caso di contravvenzione concorrente con un delitto, l’attivazione della procedura estintiva e il buon esito della stessa consentirebbero comunque di alleggerire il carico di lavoro delle Procure.
La scelta restrittiva del legislatore si sarebbe compresa se la trattazione simultanea delle due ipotesi di reato avesse comportato un aggravio dell’attività processuale con riferimento specifico alla contravvenzione tale da rendere inferiore il beneficio derivante dall’applicazione della causa estintiva rispetto al costo di proseguire per tutti i reati ravvisati.
Peraltro, visto che il decreto ha valorizzato «un modello estintivo già previsto nella legislazione speciale per alcune contravvenzioni», sarebbe stato sufficiente dare uno sguardo alla trentennale esperienza maturata in materia di sicurezza sul lavoro a seguito del d.lgs. n. 758/1994 per rendersi conto della assoluta irrazionalità della disposizione in commento.
Infatti, nel settore lavoristico, è molto frequente che l’organo di vigilanza, in esito agli accertamenti svolti, ipotizzi due distinte notizie di reato, una relativa alla violazione delle molteplici norme in materia antinfortunistica e l’altra relativa alla violazione delle norme dettate a tutela dell’incolumità del singolo lavoratore o dell’intera collettività lavorativa (artt. 589/590 oppure art. 437 c.p.). In via ordinaria, il pubblico ministero apre separati procedimenti in relazione alle due notizie di reato sicché la procedura estintiva del reato contravvenzionale segue il suo corso nel pertinente procedimento e parallelamente procede l’indagine per le diverse ipotesi delittuose. Questa prassi non ha mai dato adito a rilievi per cui la soluzione adottata con la riforma del 2022 non era affatto “obbligata”.
Peraltro, la previsione dell’art. 12 ter, legge n. 283/1962 non solo non realizza alcun vantaggio concreto per la macchina giudiziaria, ma produce anche effetti inutilmente afflittivi per il contravventore che è privato, in modo del tutto irragionevole (e forse in contrasto con principi costituzionali), di avvalersi di una norma premiale che conduce all’estinzione del reato.
Entrando ora nel merito del problema, ricordiamo che, in termini del tutto generali, si parla di concorso di reati quando una stessa persona commette più illeciti. Il codice penale prevede specifiche regole di disciplina in relazione al trattamento sanzionatorio del concorso di reati, ma questo aspetto qui non interessa perché nell’art. 12 ter il risvolto derivante dalla commissione di più reati è di tipo processuale. In questo particolare ambito, il concorso di reati potrebbe, infatti, dare origine alla connessione tra i medesimi con le ricadute a livello di riunione di processi.
Come ha rilevato anche la Corte, la norma si riferisce in modo del tutto generico al concorso della contravvenzione con un qualsiasi delitto e pertanto «Il criterio è ampio, non avendone il legislatore ulteriormente definito i contorni: non è specificato di quali delitti si tratti, né la tipologia del “concorso” con la contravvenzione».
Può dunque trattarsi di un qualsiasi delitto, del tutto eterogeneo rispetto alla contravvenzione, ma capace, stante la lettera della disposizione, di impedire l’attivazione della procedura di cui trattasi sterilizzando così il meccanismo estintivo della contravvenzione19.
La sentenza, tuttavia, dichiara di non poter accettare una nozione estesa del “concorso” evocato dalla legge anche per la ragione che il blocco del meccanismo estintivo, che, non va dimenticato, integra una causa di non punibilità a favore dell’imputato, verrebbe rimesso all’iniziativa del pubblico ministero (e dell’organo accertatore o della polizia giudiziaria) cui basterebbe esercitare l’azione penale per un qualsiasi delitto concorrente per impedire all’autore della contravvenzione di poterla estinguere.
Su questa premessa, la Suprema Corte propone una lettura “restrittiva” della disposizione nel senso che «il delitto deve emergere sin da subito in sede di accertamento paralizzando proprio la procedura estintiva; il delitto, cioè, deve essere accertato dallo (o comunque deve prenderne notizia lo) stesso organo ispettivo deputato alla formulazione delle prescrizioni il quale, verificata l’esistenza del delitto, si dovrà astenere dal formulare alcuna prescrizione».
In questa ottica, il “delitto concorrente” è quello del quale l’organo accertatore prende notizia immediatamente ed insieme con la contravvenzione.
Pur apprezzando lo sforzo di contribuire per via interpretativa a ridimensionare la forte criticità derivante dalla disposizione analizzata, la tesi della Suprema Corte non convince del tutto.
Tra l’altro, va detto che riferendosi proprio al profilo dell’aggravio per il sistema processuale, che si profilerebbe in caso di concorso tra reati, la Suprema Corte espone (par. 5.6) questo argomento: «Se insieme con la contravvenzione viene accertato un qualsiasi delitto, il procedimento dovrà necessariamente seguire il suo corso, non potendo tollerare l’indagine una inutile sospensione di almeno sei mesi (prorogabile per ulteriori sei)».
Invero, quello che viene presentato come inconveniente, a ben vedere forse non lo è (o perlomeno non lo è fino in fondo) perché la sospensione per sei mesi del procedimento anche per il delitto comporta comunque la sospensione del corso della prescrizione per cui non si dovrebbe registrare alcun pregiudizio sotto il profilo dell’efficacia della risposta repressiva.
Per cercare di dare un senso alla norma, partiamo perciò dalla finalità della riforma che è quella di ottenere la deflazione del carico giudiziario riducendo il numero dei procedimenti che arrivano a giudizio. Se questa è la ratio, la disposizione va intesa nel modo più coerente possibile con la stessa e da questo primo punto di vista sarebbe palesemente irrazionale intendere il concetto di concorso di reati nella sua accezione più ampia e generica perché basterebbe – come la stessa Corte avverte – contestare, unitamente alla contravvenzione alimentare, un qualsiasi delitto del tutto eterogeneo accertato a carico dello stesso soggetto, quale ad es. la detenzione di stupefacenti o il caporalato o la detenzione di banconote false, per ritenere impraticabile la procedura estintiva.
La disposizione, nella sua laconicità, potrebbe far pensare che l’effetto preclusivo sia derivante non tanto dal concorso di reati in sé e per sé, quanto dalla circostanza che, in questo caso, il P.M. debba trattare le due notizie di reato in un solo procedimento, senza quindi poter procedere alla loro separazione. Invero, la relazione illustrativa recita che «l’economia processuale realizzata con l’archiviazione del procedimento non si determina quando il procedimento stesso deve proseguire per concorrenti delitti» e ciò rafforza l’idea che la preclusione all’attivazione della procedura operi sul piano meramente processuale.
È allora ragionevole ipotizzare che il legislatore abbia pensato che, in determinati casi, il legame tra la contravvenzione e il delitto sia talmente stretto da rendere pressoché indispensabile la trattazione unitaria e cumulativa delle due fattispecie criminose. In questa ottica, nell’unico procedimento, che ineluttabilmente proseguirebbe verso il dibattimento20, ha una sua logica l’aver stabilito che non fa risparmiare al sistema risorse il disporre l’archiviazione della contravvenzione dovendo il processo comunque arrivare allo sbocco finale.
Il passo successivo è dunque chiedersi, nel silenzio dell’art. 12 ter , legge n. 283/1962, in quali situazioni il concorso tra reati presenti caratteristiche tali da rendere in concreto applicabile il criterio anzidetto.
Prima, tuttavia, è il caso di mettere in risalto un paradosso: se la contravvenzione concorre con il delitto di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) da cui sia derivata una malattia della durata non superiore a quaranta giorni la competenza per questo reato appartiene inderogabilmente al giudice di pace e perciò il P.M. dovrà necessariamente separare i procedimenti anche se l’organo di vigilanza avesse invece provveduto a trasmettere una sola notizia di reato. Nella situazione prospettata, per la contravvenzione non vi sono ostacoli ad attivare la procedura estintiva, il che rende del tutto evidente la discrasia all’interno del sistema derivante dall’art. 12 ter.
Chiusa questa parentesi, si può dunque ritenere che l’assoluta eterogeneità del bene protetto dalle norme incriminatrici chiamate in causa non giustifichi l’osservanza del criterio che si ricava indirettamente dal testo di legge, vale a dire l’indicazione di tenere riunite le notizie di reato per finalità di economia processuale.
Anche la sentenza n. 16082/2025 osserva che «Nulla impedisce al pubblico ministero di separare il procedimento per la contravvenzione da quello per il delitto procedendo ad una autonoma iscrizione di quest’ultimo, ma tale eventualità non sembra essere stata presa in considerazione dal legislatore».
Nonostante l’accenno, l’argomento non viene sviluppato adeguatamente come dimostra proprio la vicenda oggetto della decisione citata. Infatti, nella specie la contravvenzione alimentare era stata accertata nel corso di indagini preliminari già in corso relative al delitto previsto dagli artt. 56,515 c.p. (contestato per la detenzione di bottiglie di liquore recanti l’indicazione “distillato di vino” ed invece risultate composte da distillato di cereali).
Al riguardo, la sentenza (v. par. 5.8) sostiene che «Anche in questo caso, la contravvenzione accertata nell’ambito di indagini in corso già iscritte per un diverso delitto non è suscettibile di essere estinta ostandovi le ragioni di economia processuale sopra indicate, non potendo l’indagine essere sospesa nemmeno a seguito di autonoma e separata iscrizione della contravvenzione. Astrattamente, nulla avrebbe impedito al pubblico ministero di iscrivere in separato procedimento la contravvenzione, ma ciò non avrebbe comunque consentito l’applicazione del meccanismo previsto dall’art. 12 sexies, legge n. 283 del 1962 per la mancanza di un presupposto fondamentale: la mancata ricezione della notizia di reato da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall’organo accertatore e dalla polizia giudiziaria».
Tale conclusione ci lascia dubbiosi.
In primo luogo, perché nel caso di cui alla sentenza, la contravvenzione è stata sì accertata dallo stesso organo di vigilanza, che stava indagando per il delitto di cui agli artt. 56/515, ma non «immediatamente ed insieme con» il delitto sicché non si comprende bene perché “anche” in questo caso la procedura estintiva risultasse paralizzata.
In secondo luogo, il criterio che «delitto concorrente è solo quello accertato direttamente e immediatamente dalla polizia giudiziaria o dall’organo accertatore insieme con la contravvenzione» finisce per affidare al caso l’applicazione o meno di un istituto premiale. Con evidenti sperequazioni tra imputati della stessa contravvenzione, concorrente con un delitto, a seconda che i reati siano stati accertati dallo stesso organo accertatore e/o contestualmente.
Infine, si osserva che l’art. 12 sexies, legge n. 283/1962 è invocato fuori luogo. Il discorso merita una riflessione articolata.
Come è noto, l’art. 12 sexies stabilisce che «Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa, ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall’organo accertatore e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all’organo accertatore o alla polizia giudiziaria affinché provvedano agli adempimenti di cui agli articoli 12 ter e 12 quater».
La disposizione in esame – come l’art. 12 ter 21 – utilizza l’espressione «organo accertatore» che non trova riscontro nel d.lgs. n. 758/1994. Questa normativa, infatti, specifica nell’art. 19 che «1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo, si intende per:
(…)
b) organo di vigilanza, il personale ispettivo di cui all’art. 21, terzo comma, della l. 23 dicembre 1978, n. 833, fatte salve le diverse competenze previste da altre norme».
Perciò il senso dell’art. 2222, omologo all’art. 12 sexies, legge n. 283/1962, era chiarissimo.
Nell’art. 318 ter, d.lgs. n. 152/2006 si continua a parlare di organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’art. 55 c.p.p. e di polizia giudiziaria. L’espressione “organo accertatore” fa la sua comparsa nella sola rubrica dell’art. 318 quinquies (Notizie di reato non pervenute dall’organo accertatore) e non nel testo che continua a recitare «Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall’organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all’organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318 ter e 318 quater».
La situazione si complica con la normativa del 2022 23 che certamente utilizza l’espressione organo accertatore come sinonimo di organo di vigilanza, ma non essendo quest’ultimo, come nella legge del 1994, individuato in una precisa figura istituzionale avente competenza specifica e esclusiva, si aprono incertezze in materia24.
Esaurita anche questa problematica, possiamo giungere alle prime conclusioni, suscettibili comunque di essere rivisitate stante l’assoluta oscurità della normativa.
Orbene, vi sono sicuramente casi in cui sussiste il concorso di reati rilevante nella logica di precludere la procedura estintiva.
Come è noto, la normativa speciale tutela in vario modo la qualità, l’igiene e la genuinità degli alimenti25, mentre gli artt. 515 o 516 del codice penale, che rappresentano quelli che più di frequente possono concorrere con le fattispecie speciali26, sono posti a presidio della regolarità dei rapporti commerciali, dell’onestà e della correttezza negli scambi commerciali.
La giurisprudenza è invece nel senso che la contravvenzione di cui all’art. 5, con specifico riferimento all’ipotesi della lett. d), in cui è richiesta espressamente la nocività in concreto della sostanza alimentare, sia assorbita nel delitto di cui all’art. 444 c.p. posto a tutela diretta della salute pubblica27.
Vi è infine un possibile concorso tra la contravvenzione speciale e il delitto di cui all’art. 590 c.p. che tutela l’interesse del singolo consumatore che potrebbe riportare lesioni in conseguenza dell’ingestione di un alimento non conforme alle prescrizioni di legge.
Il criterio enunciato si colora maggiormente se le violazioni abbiano lo stesso oggetto materiale o comunque siano necessariamente collegate tra di loro in senso probatorio.
Il campo di applicazione del concetto di concorso di cui all’art. 12 ter si è così molto ristretto: esso dunque comprende non solo il caso del concorso formale di reati in cui la trattazione congiunta è intrinsecamente giustificata, ma anche il caso di concorso materiale in cui sia ravvisabile il collegamento probatorio di cui all’art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p. 28 perché lo stretto legame tra le due o più fattispecie può effettivamente giustificare la scelta del P.M. di procedere nell’ambito di un unico procedimento privando il contravventore della facoltà di accedere al meccanismo estintivo/premiale.
Concludiamo osservando che è un peccato che il d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, con cui il Governo in attuazione della delega di cui all’art. 1, comma 4, legge 134/2021, ha corretto alcune disposizioni del d.lgs. n. 150/2022, non abbia messo mano anche alla norma contenuta nel comma 1 dell’art. 12 ter.
1 In materia, v. Martufi, La definizione anticipata delle contravvenzioni alimentari all’indomani della riforma Cartabia: tra compliance e logiche punitive, in Sist. pen., 14 giugno 2023, 1 ss.; Amarelli, La nuova procedura estintiva delle contravvenzioni in materia di sicurezza alimentare , in Dir. pen. proc., 2023, 70 ss.; Bernasconi, Deflazione processuale mediante istituti di diritto penale sostanziale , in DisCrimen, 16 febbraio 2023, 8 ss.; Diamanti, Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni , in Castronuovo - Donini - Mancuso - Varraso (a cura di), Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale, Padova, 2023, 143 ss.; Rugani, L’estinzione delle contravvenzioni “alimentari” nella fase delle indagini preliminari: commento delle disposizioni introdotte dall’art. 70 d.lgs. 150/2022 («modifiche alla legge 30 aprile 1962 n. 283») , in Leg. pen., 6 febbraio 2023, 1 ss.; Lazzarini, L’estinzione delle contravvenzioni per adempimento delle prescrizioni nella dinamica processuale , in Archivio penale, 2024, 3, 1 ss.; Donelli, Contravvenzioni e prescrizioni: il nuovo istituto in diritto penale alimentare, appunti per una virtuosa sedimentazione normativa e uno sguardo al futuro , in Dir. pen. e proc., 2024, 93 ss.; Helferich, Le modifiche in materia di procedibilità a querela ed estinzione delle contravvenzioni alimentari , ibid., 731 ss.
2 Nel settore relativo alla sicurezza sul lavoro, l’istituto ha dato ottima prova di sé perché, a differenza degli altri comparti normativi in cui il meccanismo è stato esportato senza gli opportuni adattamenti, la quasi totalità dei reati ha carattere omissivo permanente e i comportamenti idonei a regolarizzare l’illecito rientrano nell’esclusiva sfera di controllo del datore di lavoro con la conseguenza che la contro-condotta occorrente per regolarizzare l’illecito non dà luogo a particolari difficoltà. Invece, nei settori della tutela dell’ambiente e della sicurezza alimentare, i reati, il più delle volte, hanno natura commissiva, sono per lo più istantanei e, comunque, gli eventuali effetti derivanti dall’illecito sono difficilmente eliminabili.
3 Cass. 28 aprile 2025, n. 16082, Ni.Ge., in www.osservatorioagromafie.it .
4 In Giur. cos ., 1998, 111.
5 Cass. 18 aprile 2019, n. 36405, Rossello, rv. 276.681.
6 Si ricordi ancora che l’art. 162 bis c.p. prevede anche che il giudice possa negare l’ammissione all’oblazione ritenendo il «caso grave».
7 Il d.lgs. n. 758/1994 testualmente impiega l’espressione «eliminare la contravvenzione», ma è chiaro che si è voluto indicare lo scopo sostanziale cui mira la prescrizione e cioè far cessare l’illecito o rimuoverne gli effetti. In questo senso, v. Martufi, La “diversione” ambientale tra esigenze deflattive e nuove tensioni sistemiche , in Dirittopenalecontemporaneo,Rivista trimestrale,2018, 1, 296-300, secondo il quale «Da un punto di vista ontologico, il meccanismo è quindi caratterizzato da una contro-condotta (tardivamente adempiente) finalizzata a neutralizzare l’offesa al bene giuridico tutelato, la quale ricalca lo schema del “ravvedimento operoso”, sia pure in assenza della volontarietà di quest’ultimo (…) Sembra dunque corretto ritenere che la prescrizione di cui all’art. 318 ter T.U.A. possa essere impartita solo allorché sia possibile eliminare la situazione antigiuridica oppure quando sia possibile rimuovere i suoi eventuali effetti permanenti: risulterebbero perciò sottratte al raggio d’azione del meccanismo estintivo quelle contravvenzioni che hanno natura di reato istantaneo o che si siano già giunte a consumazione. Di converso, beneficiano della non punibilità le contravvenzioni permanenti, o ad effetto permanente, che siano state neutralizzate da una condotta successiva al perfezionamento della fattispecie (…) Per le ragioni da ultimo evocate, infine, la condotta antagonista potrà intervenire solo rispetto a quelle violazioni, anche non meramente formali, che siano eliminabili dal contravventore destinatario del precetto penale. Per questo motivo non rientrano nel raggio di applicazione della procedura né le violazioni materialmente ineliminabili né quelle che risultino giuridicamente ineliminabili».
8 Cass. 18 aprile 2019, n. 36405, cit. In argomento, ci si permette di rinviare a Paone, Dopo tre anni dall’entrata in vigore della l. n. 68/2015, persistono dubbi e criticità in tema di estinzione delle contravvenzioni ambientali , in Riv. trim. dir. pen. amb., 2019, 2, 87-93; Id., Per la Cassazione la procedura di estinzione dei reati prevista dagli artt. 318 bisss. d.lgs. 152/06 si applica a tutti i casi di condotta esaurita, in www.lexambiente ,4 ottobre 2019; Amendola, Contravvenzioni ambientali a condotta esaurita e procedura estintiva della legge 68/2015 , ivi, 16 febbraio 2018.
9 Pensiamo, a titolo di esempio, ai seguenti casi in cui le conseguenze del reato non sono eliminabili: superamento dei limiti per le sostanze immesse in corpi ricettori; abbandono di rifiuti su un terreno, rimossi successivamente da un terzo; immissione di sostanze liquide in un corso d’acqua; conclusione dei lavori in un cantiere edile; cessazione dell’attività per fallimento dell’azienda; distruzione della macchina irregolare; dismissione volontaria della carica di rappresentante legale dell’azienda; licenziamento del dirigente.
10 In Giur. cost ., 1998, 3574.
11 In motivazione, la Corte cost. ha affermato che «(…) le censure di legittimità costituzionale si basano sull’erroneo presupposto che, ove si tratti di reato per cui sia “ontologicamente” impossibile impartire qualsiasi prescrizione per eliminare le conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione accertata, la natura del reato costituisca elemento idoneo ad incidere in termini di irragionevolezza e di ingiustificata disparità di trattamento sulla disciplina del decreto legislativo n. 758 del 1994; che l’obiettiva diversità della struttura dei diversi reati, quale risulta dagli elementi costitutivi della fattispecie, e, conseguentemente, il momento in cui si realizzano la commissione e la consumazione del reato stesso, nonché la natura istantanea o permanente del reato, appartengono a scelte del legislatore, che nella costruzione delle fattispecie incriminatrici traduce le proprie opzioni di politica criminale, ovvero sono imposte dalla stessa natura degli obblighi e dei comportamenti di cui si vuole assicurare l’osservanza mediante il ricorso alla sanzione penale; che pertanto eventuali trattamenti differenziati risultano giustificati dalla diversa struttura delle fattispecie incriminatrici; che questa Corte, prendendo in esame con la sentenza n. 19 del 1998 la situazione del contravventore che aveva regolarizzato la violazione prima che l’organo di vigilanza avesse impartito la prescrizione, ovvero nonostante la prescrizione fosse stata omessa o fosse stata impartita senza osservare le forme prescritte, aveva precisato che esistono soluzioni interpretative tali da consentire egualmente l’applicazione della causa estintiva del reato, idonee a “ricondurre situazioni sostanzialmente omogenee a quelle espressamente previste dalla legge nell’alveo della procedura disciplinata dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo in esame”; che tale conclusione trova il suo fondamento nella ratio del decreto legislativo n. 758 del 1994, che si propone il duplice obiettivo di favorire l’effettiva osservanza delle misure di prevenzione e di protezione in tema di sicurezza e di igiene del lavoro - materia in cui l’interesse alla regolarizzazione delle violazioni e alla conseguente tutela dei lavoratori è prevalente rispetto all’applicazione della sanzione penale - e di attuare una consistente deflazione processuale».
12 Per completezza, si fa presente che la Corte cost. ha ribadito il proprio orientamento con l’ord. 24 maggio 1999, n. 205, in Giur. cost ., 1999, 1901 e 23 maggio 2003 n. 192, ivi, 2003, 3.
13 Diversamente opinando, situazioni ontologicamente differenti sarebbero trattate nello stesso modo in assenza di qualsiasi razionale giustificazione.
14 V. Gargani, La tutela penale della salute tra delitti e contravvenzioni alimentari, in Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell’Ambiente, Fasc. 1/2022, 11.
15 V. Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, n. 2/2023, Relazione sulla novità normativa Riforma Cartabia 2.1.2023, 262, in cui si esprime analogo convincimento: «con particolare riferimento al profilo delle condotte ripristinatorie attivabili dal trasgressore, apparirebbe incerta la praticabilità dell’istituto ai reati de quibus attraverso una contro-azione antagonista del reo (c.d. contrarius actus) in grado di impedire o attenuare l’evento, ovvero mediante condotte contro-offensive riparatrici dell’offesa (che non siano squisitamente risarcitorie), posto che il campo di elezione riguarda, per lo più, reati alimentari di mera condotta, aventi natura istantanea con effetti permanenti, difficilmente regolarizzabili o suscettibili di elisione mediante un contegno post-contravvenzionale, una volta che sia stata compromessa irreversibilmente la sicurezza alimentare. Dalla copiosissima casistica giurisprudenziale dei reati alimentari di cui agli artt. 5 e 6 della legge n. 283 cit. sembra potersi trarre una tendenziale impossibilità ontologica (giuridica e materiale) di statuire prescrizioni per eliminare le conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione accertata». Anche Diamanti, Estinzione delle contravvenzioni ,cit., 158, ha osservato che «In materia agroalimentare - questo va detto - le condotte ripristinatorie attivabili dal trasgressore per impedire, attenuare l’evento o riparare l’offesa (diverse dal risarcimento) non sono moltissime, trattandosi spesso di reati istantanei di mera condotta e con effetti permanenti».
16 L’art. 5, legge n. 283/1962 punisce le violazioni realizzate nel corso delle diverse fasi del «ciclo vitale» degli alimenti: dalla preparazione del prodotto, alle fasi intermedie di commercializzazione (detenzione per la vendita, vendita effettiva) e/o distribuzione diretta al consumatore (somministrazione, distribuzione per il consumo).
17 Martufi, La definizione anticipata delle contravvenzioni alimentari , cit., 29-30, ha osservato che «queste ipotesi - laddove effettivamente verificabili, ad es. consentendo la rimozione dagli scaffali della merce rischiosa esposta alla vendita (previsione la quale, oltre a differenziare le fattispecie contravvenzionali per tipo di “irregolarità”, descrive la condotta tipica alternativa riferendosi a qualsiasi attività di filiera alimentare, inclusa la “detenzione per la vendita”) - non darebbero comunque luogo a condotte che ripristinano in senso stretto lo status preesistente alla violazione del precetto».
18 V., in argomento, da ultimo, Madeo, Le fattispecie penali di cui alla legge n. 283/1962 , in Aa.Vv., Gargani (a cura di), Illeciti punitivi in materia agroalimentare , Trattato teorico-pratico di diritto penale,diretto da Palazzo, Paliero e Pelissero, Torino, 2021, 308-309.
19 Nella motivazione della sentenza n. 16082/2025, la Corte ipotizza che, in sede di ispezione, oltre alla violazione di carattere alimentare, si possano rinvenire armi o cose provenienti da delitto, circostanza che, in base al testo normativo, paralizza comunque il meccanismo estintivo.
20 Se non vengano scelti riti alternativi per entrambi i reati.
21 «Per consentire l’estinzione della contravvenzione ed eliderne le conseguenze dannose o pericolose, l’organo accertatore, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria (…)».
22 «Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall’organo di vigilanza, ne dà immediata comunicazione all’organo di vigilanza per le determinazioni inerenti alla prescrizione che si renda necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione».
23 Nella relazione al decreto si legge «Gli ambiti di materia sono stati individuati tenendo conto dell’esistenza, a livello normativo e di prassi, dell’esistenza di autorità amministrative di vigilanza e di corpi di polizia o dei Carabinieri (come i Nuclei Anti Sofisticazione e Sanità - N.A.S.) specializzati nell’accertamento di reati in quegli ambiti. L’esistenza di organi accertatori specializzati è una premessa indispensabile per il successo della procedura amministrativa che porta a prescrivere condotte ripristinatorie/risarcitorie al fine dell’estinzione del reato».
24 Cfr. Rugani, L’estinzione delle contravvenzioni “alimentari”,cit., 13, per il quale «Nell’incertezza derivante dall’assenza di una espressa definizione legislativa (sulla falsariga dell’art. 19 co. 1 lett. b d.lgs. 758/1994), si pone il problema d’individuare le autorità che rivestono la qualifica di “organo accertatore”».
25 Quanto alla legge n. 283/1962, Gargani, La tutela penale della salute tra delitti, cit., 8-9, ha affermato che «Anche se, prima facie (art. 1), il bene protetto appare la salute pubblica, in realtà, oggetto immediato e diretto di tutela sono ora l’igiene e la genuinità degli alimenti (ossia una forma prodromica e anticipata di protezione della salute collettiva), ora la purezza e la genuinità degli alimenti. La duplice direzione teleologica può essere apprezzata nella prospettiva della tutela anticipata della salute umana (intesa in senso lato) e della protezione della buona fede dei consumatori. La garanzia di sicurezza igienica è, infatti, considerata quale mezzo di anticipazione della tutela della salute e, al contempo, di interessi economici».
26 V. Cass. 22 aprile 1999, n. 8507, Barbaro, rv. 214.223; Cass. 20 settembre 2013, n. 15113, Greco, in Foro it., 2014, II, 485.
27 V. Cass. 7 giugno 2005, n. 36345, Disperso, rv. 232.228; Cass. 2 ottobre 2007, n. 44779, Consiglio, rv. 238.661.
28 Come insegna la giurisprudenza, il collegamento in questione si verifica quando un unico elemento di fatto proietti la sua efficacia probatoria in relazione a una molteplicità di illeciti penali: v. Cass. 26 gennaio 2022, n. 18241, rv. 283.405-02; 14 dicembre 2011, n. 10445, rv. 252.006-01; Sez. Un. 6 dicembre 1991, n. 1048, rv. 189.181-01.