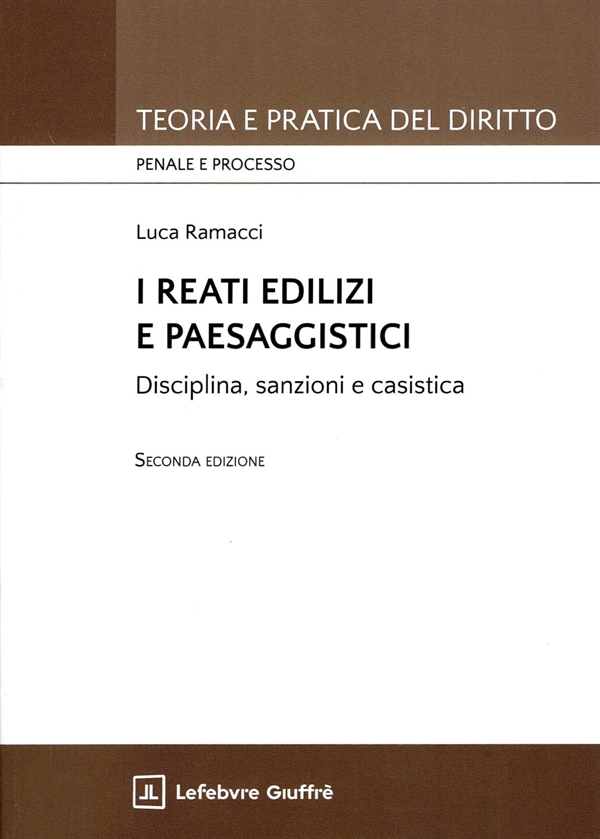Da riforma a dogma anacronistico: il lungo lascito del DM 5 febbraio 1998 e il suo impatto sull’evoluzione culturale del settore dei rifiuti
Da riforma a dogma anacronistico: il lungo lascito del DM 5 febbraio 1998 e il suo impatto sull’evoluzione culturale del settore dei rifiuti
di Oreste PATRONE
Il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 costituisce uno dei capisaldi storici della disciplina italiana in materia di rifiuti. Esso ha introdotto, per la prima volta in modo organico, un regime di procedure semplificate per specifiche attività di recupero, sottraendole al più gravoso procedimento autorizzatorio ordinario, oggi disciplinato dall’art. 208 del D.lgs. 152/2006.
La ratio del decreto era chiara: favorire il riutilizzo delle frazioni recuperabili, consentendo alle imprese di avviare le attività mediante una comunicazione preventiva all’autorità competente [Provincia o Regione a seconda dell’assetto territoriale], con efficacia differita di novanta giorni e iscrizione in apposito registro. Si trattava di un deciso cambio di paradigma, coerente con l’impianto riformatore del decreto Ronchi [D.lgs. 22/1997], che aveva introdotto nell’ordinamento concetti fino ad allora inediti, quali il recupero di materia ed energia come alternativa allo smaltimento.
Il cuore del sistema erano [e sono tuttora, nella trasposizione operata dagli articoli 214 e 216 del D.lgs. 152/2006] i princìpi di tassatività ed esclusività: possono beneficiare della semplificazione solo le attività puntualmente elencate dal regolamento, nei limiti quantitativi e qualitativi da esso previsti. In assenza di tale corrispondenza, l’unica via rimane il procedimento autorizzatorio ordinario.
Un’innovazione divenuta dogma
Se, da un lato, il DM 5 febbraio 1998 rappresentò un’autentica innovazione, dall’altro la sua perdurante centralità nell’operatività quotidiana ha prodotto un fenomeno di “cristallizzazione” normativa. Le autorità competenti, infatti, hanno spesso assunto il decreto come unico parametro di riferimento, anche in fattispecie che esorbitavano dal suo ambito applicativo. In numerosi procedimenti autorizzativi regionali, capitoli e paragrafi del DM sono stati utilizzati come schema per disciplinare attività non strettamente riconducibili al regime semplificato, con il risultato di trasformare uno strumento di flessibilità in un vincolo dogmatico.
Analoga tendenza si è osservata nella prassi consulenziale e operativa: molte imprese hanno cercato di incardinare la descrizione della propria attività entro le categorie del DM, anche laddove l’inquadramento appariva forzato. Persino nelle procedure di riconoscimento caso per caso della cessazione della qualifica di rifiuto [articolo 184-ter del D.lgs. 152/2006], si è frequentemente ricorso al DM 5 febbraio come riferimento bibliografico e parametrico, piegandolo a una funzione per la quale non era stato concepito.
Le conseguenze sistemiche
Questa sovraesposizione ha avuto conseguenze rilevanti.
Il DM 5 febbraio, nato come strumento agevolativo e sperimentale, ha finito per ostacolare l’elaborazione di nuove strategie regolative, limitando la possibilità di immaginare percorsi di recupero più aderenti all’evoluzione tecnologica e industriale. La rigidità delle tabelle e dei parametri ha spesso prevalso sulla necessità di costruire un sistema realmente dinamico e orientato all’economia circolare.
La giurisprudenza amministrativa ha contribuito a questo processo di irrigidimento, anche recentemente, dichiarando legittimo imporre, anche in un’autorizzazione ordinaria per un impianto che restituiva prodotti cessati dalla qualifica di rifiuto, end of waste, il rispetto dei limiti di concentrazione di sostanze inquinanti indicati nell’allegato 3 del DM 5 febbraio 1998, utilizzato quale criterio integrativo in assenza di regolamentazioni ministeriali specifiche: Il DM 5 febbraio 1998 integra, del resto, il paradigma per le autorizzazioni EoW non altrimenti governate da criteri più specifici. Se, infatti, l’art. 184 ter, comma 3 D.Lgs. 152/2006 lo indica come standard per le procedure semplificate, in base alle linee guida SNPA lo stesso può assurgere a riferimento anche nelle procedure ordinarie di autorizzazione “caso per caso” Tale sentenza conferma sia il valore ancora operativo del decreto, sia il suo utilizzo come riferimento regolatorio residuale.
D’altro canto, la Corte di Cassazione penale, con sentenza n. 1987/2015, ha ribadito la portata rigorosamente circoscritta del decreto, limitata alle tipologie di rifiuti espressamente individuate. Non è, quindi, ammissibile estendere la sua applicazione ad altre categorie di rifiuti, nemmeno per analogia, con ciò rafforzando il principio di tassatività che caratterizza l’intero impianto della disciplina.
Ne risulta un quadro in cui il DM 5 febbraio, da strumento di semplificazione, si è trasformato – anche per effetto delle letture restrittive della giurisprudenza – in una cornice normativa rigida, che continua a influenzare la prassi ben oltre la sua funzione originaria.
Prospettive
A quasi trent’anni dalla sua emanazione, il DM 5 febbraio 1998 appare oggi un testo datato. La sua utilità originaria – quella di introdurre, in un contesto normativo ancora acerbo, una via semplificata al recupero – si è trasformata in un freno culturale e operativo. Le recenti evoluzioni normative in tema di end of waste a livello europeo e nazionale hanno aperto spiragli per un superamento di questa impostazione, restituendo centralità al principio di valutazione caso per caso e alla capacità delle autorità di calibrare i criteri sulle specificità tecnologiche.
In tal senso, deve essere considerata positivamente l’introduzione del Nucleo End of Waste [NEW] presso il Ministero dell’Ambiente, stante la funzione di coordinamento e indirizzo che esso è chiamato a svolgere nella definizione di criteri uniformi e aggiornati per la cessazione della qualifica di rifiuto. Si tratta di un passo istituzionale che potrebbe finalmente consentire al sistema di emanciparsi dal ricorso, ormai anacronistico, al DM 5 febbraio 1998, aprendo la strada a un quadro regolatorio più dinamico, aderente all’evoluzione tecnologica e coerente con gli obiettivi europei di economia circolare.