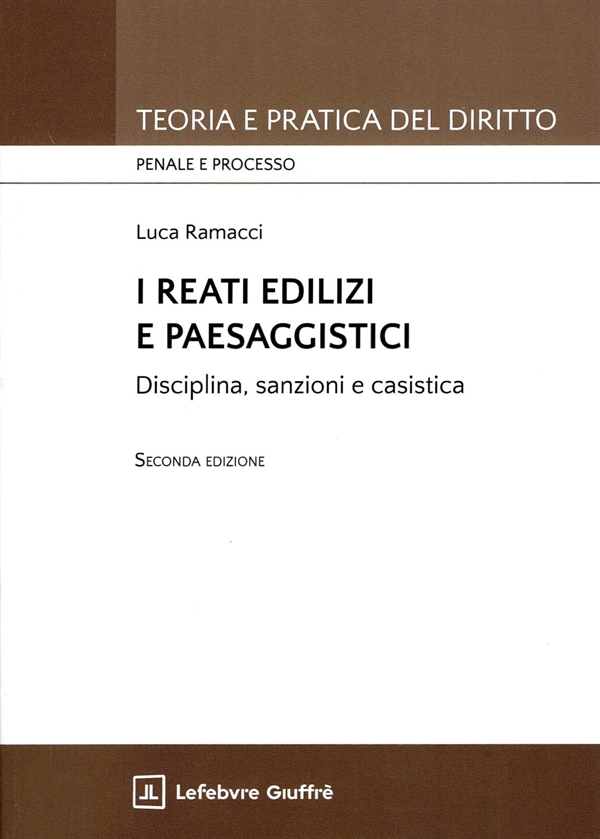La fattispecie del deposito incontrollato di rifiuti: sono opportuni alcuni chiarimenti
La fattispecie del deposito incontrollato di rifiuti: sono opportuni alcuni chiarimenti
di Vincenzo PAONE
pubblicato su osservatorioagromafie.it.Si ringraziano Autore ed Editore
Sanità pubblica - Rifiuti - Deposito incontrollato di rifiuti - Natura.
Il reato di deposito incontrollato di rifiuti di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, diversamente dall’abbandono, reca in sé i segni del persistente dominio finalistico sulle cose ed ha sempre natura permanente; la permanenza cessa con la rimozione definitiva dello stato di antigiuridicità già prodottosi; colui il quale subentra contrattualmente nella gestione dei rifiuti risponde del reato in questione e non del reato di cui all’art. 255, comma 3, se, dopo aver provveduto all’iniziale smaltimento dei rifiuti, ha cessato la condotta lasciando in deposito incontrollato i residui rifiuti.
1. Prendendo spunto da una recente sentenza della Suprema Corte1, nel presente contributo vogliamo approfondire la nozione di deposito incontrollato per delimitarne i confini e per evitare confusione con istituti affini.
Invero, abbiamo la sensazione che la giurisprudenza di legittimità, e prima ancora quella di merito, da un po’ di tempo tenda a ravvisare questa fattispecie criminosa anche in situazioni che potrebbero essere qualificate in altro modo. In particolare, ci riferiamo all’ipotesi dell’abbandono e dello stoccaggio nelle sue forme alternative di deposito preliminare e messa in riserva. Ma di questo profilo parleremo meglio in appresso dopo aver messo in luce i tratti distintivi dell’abbandono e del deposito incontrollato.
Come è noto, la contravvenzione di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/06 punisce i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’art. 192, commi 1 e 2 (dal 10 ottobre 2023 2 lo stesso fatto commesso dal privato, prima soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, è punito con l’ammenda da mille euro a diecimila euro raddoppiata se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi).
La disposizione non definisce in che cosa consistano le condotte tipiche e la stessa carenza si riscontrava anche nelle norme che hanno preceduto l’art. 256, d.lgs. n. 152/06. Infatti, la prima legge sull’inquinamento da rifiuti si limitava a vietare (art. 9 d.p.r. n. 915/1982) «l’abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico» e di «scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private». Il successivo d.lgs. n. 22/1997 (art. 14, comma 1) riproduceva sostanzialmente lo stesso precetto stabilendo che «L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati». Infine, l’art. 192, comma 1, del vigente decreto stabilisce che «L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati».
Per inciso, nelle ultime due disposizioni l’aggettivo «incontrollato» è declinato al plurale, il che potrebbe far pensare che il legislatore intendesse riferirlo sia all’abbandono che al deposito. Siamo invece dell’avviso che si tratti di una semplice imprecisione linguistica perché l’art. 256, comma 2, si esprime in termini più accurati dicendo che «Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti (...)», mettendo così l’accento sul fatto che è la modalità di attuazione («senza controllo») che connota il deposito e tale precisazione, per ragioni logiche, non può essere estesa all’abbandono giacché l’idea che tale atto sia consentito se compiuto in modo «controllato» è inaccettabile.
Per completezza, va detto che neppure la normativa di fonte comunitaria contiene la definizione dei termini che ci interessano. Infatti, le vetuste direttive n. 75/442 e n. 78/319 non parlavano neppure di «deposito incontrollato»; la direttiva n. 156/91, nell’art. 4, stabiliva che «Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per vietare l’abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti»; la stessa formula era prevista nell’art. 4 della direttiva n. 2006/12; infine, l’art. 36 della direttiva n. 2008/98 stabilisce che «Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare l’abbandono, lo scarico e la gestione incontrollata dei rifiuti».
Ciò chiarito, non resta che affidarsi al significato che il lessico riserva ai vocaboli utilizzati dal legislatore.
2. L’abbandono (come l’immissione nelle acque) indica l’atto mediante il quale il rifiuto è definitivamente rilasciato dal suo detentore in ambiente, in qualsiasi modo ciò avvenga. Il fatto si caratterizza per l’episodicità ed occasionalità del gesto perché, se fosse accertata la ripetitività degli atti di abbandono di rifiuti, si potrebbe ipotizzare la realizzazione della discarica abusiva3.
Il deposito (mettendo per il momento da parte la questione dell’aggettivo «incontrollato») rinvia ad un’attività «temporanea» di collocazione di oggetti in un certo luogo sotto il controllo del detentore in attesa del compimento di ulteriori operazioni da svolgersi su di essi.
Anche il deposito incontrollato, come l’abbandono, si caratterizza per essere un evento assolutamente occasionale, riguardante un determinato e circoscritto quantitativo di rifiuti. Infatti, la pluralità degli atti di collocazione dei rifiuti, compiuti in funzione di strutturali esigenze produttive, conduce a qualificare il fatto non come deposito, ma come una fase di gestione dei rifiuti.
In questa ottica, ad esempio, l’adibizione dello stesso sito quale punto di raccolta dei rifiuti, via via prodotti dall’impresa, rappresenta senza dubbio il segmento di un’organizzata attività di gestione di rifiuti. In tal caso, infatti, saremmo di fronte ad una vera e propria attività di «stoccaggio», che, in base all’art. 183, comma 1, lett. aa), d.lgs. n. 152/06, comprende il deposito preliminare, attuato prima di una delle operazioni di smaltimento previste nei punti da D1 a D14 dell’Allegato B alla parte IV del d.lgs. n. 152/06, o la messa in riserva, attuata prima di una delle operazioni di recupero previste nei punti da R1 a R12 dell’Allegato C alla parte IV del cit. dec.
Pena l’inutilità delle relative disposizioni, appare necessario distinguere il deposito incontrollato dallo stoccaggio giacché anche questa figura è connotata dalla temporaneità, essendo attuato in vista di successive operazioni di smaltimento o recupero. Il criterio non può che essere quello del collegamento tra la produzione di rifiuti e l’esigenza di provvedere, con sistematicità, alla gestione dei medesimi.
Inoltre, lo stoccaggio, in quanto fase di gestione dei rifiuti, è soggetto a specifica autorizzazione, mentre il deposito, anche quando è realizzato in modo non «controllato», non richiede alcuna autorizzazione proprio perché non costituisce una fase di gestione dei rifiuti.
Prima di chiudere sull’argomento, osserviamo che una conferma del requisito dell’occasionalità della condotta deriva dall’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/06 in cui sono elencate tre condotte diverse strutturalmente tra loro, ma logicamente accomunate da un profilo per cogliere il quale è preliminare ricordare che il comma 1 dello stesso articolo incrimina lo svolgimento dell’attività di gestione dei rifiuti.
Come è stato chiarito in una fondamentale decisione4, la fattispecie penale ivi prevista, punendo l’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione, concentra il disvalore su un complesso di azioni, che, dunque, non può coincidere con una condotta assolutamente occasionale. Ne deriva che il comma 2 si riferisce a fatti episodici ed isolati che non rientrano nella «gestione dei rifiuti» e che hanno invece la funzione di norme di chiusura, in grado cioè di sanzionare qualsiasi evento pregiudizievole per l’ambiente.
Si tenga ancora conto che la normativa sanziona anche il privato che realizza un deposito incontrollato e perciò non vi può essere alcun dubbio che tale fatto sia del tutto svincolato dallo svolgimento di un’attività continuativa.
Riflettiamo ora su un’altra caratteristica peculiare del deposito, vale a dire la sua «temporaneità». È una situazione che richiama alla mente l’istituto, presente in materia di reati edilizi, del manufatto avente carattere precario: come è noto, per definirsi precario un immobile, tanto da non richiedere il rilascio del titolo abilitativo, è necessaria l’obiettiva ed intrinseca destinazione ad un uso temporaneo per specifiche esigenze, non essendo invece rilevanti le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati e l’agevole rimovibilità.
In questa ricostruzione dell’istituto, il fattore «tempo» crea, però, un problema perché la legge non fornisce nessuna indicazione su quale possa essere la durata massima di un deposito di rifiuti (a prescindere che sia attuato con modalità regolari o meno).
Potrà dunque ricorrere la fattispecie del deposito se, entro «un tempo di attesa ragionevole» dall’iniziale collocazione, il detentore abbia effettivamente proceduto all’asportazione dei rifiuti in esecuzione del «progetto» che prevedeva, per l’appunto, l’ammasso provvisorio. Al di là di una certa vaghezza del concetto, il criterio si concretizza indagando 5 in merito alla specifica finalità in base alla quale è stato disposto l’accumulo dei rifiuti: sarà, infatti, questa esigenza ad «imporre» la durata del deposito.
In chiusura, evidenziamo che l’aggettivo «incontrollato» ha la funzione di selezionare la condotta da sottoporre a sanzione, nel senso che l’illecito sussiste quando la detenzione dei rifiuti avvenga con «modalità irregolari» e cioè senza il rispetto delle fondamentali prescrizioni e cautele da osservarsi per la salvaguardia della salute e dell’ambiente.
3. Giunti a questo punto, abbiamo gli elementi per esaminare il tema del momento consumativo della fattispecie criminosa. Se dal punto di vista sanzionatorio, è indifferente il compimento dell’una o dell’altra condotta descritta nell’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/06, la distinzione tra le medesime è essenziale per stabilire quando si sia consumato l’illecito con l’incidenza in punto prescrizione del reato.
Il quadro che si delinea è il seguente:
- l’abbandono, come l’immissione nelle acque, integra un reato istantaneo con eventuali effetti permanenti;
- l’accumulo di rifiuti che assuma, fin dall’inizio, la conformazione di un rilascio definitivo nell’ambiente non integra il deposito incontrollato, ma coincide con la condotta tipica dell’abbandono: perciò il reato si esaurisce e si consuma al momento della collocazione dei rifiuti ed è istantaneo, con eventuali effetti permanenti;
- la mancata rimozione dei rifiuti, dopo un tempo di attesa ragionevole, esclude la figura del deposito perché dimostra la volontà esclusivamente dismissiva e non gestoria dell’agente: come nell’ipotesi precedente, la situazione coincide con l’abbandono e quindi il reato si consuma al momento della collocazione – e non dell’accertamento del fatto – ed è istantaneo, con eventuali effetti permanenti;
- la detenzione del rifiuto con modalità non conformi a legge e per esigenze realmente temporanee configura la fattispecie del deposito incontrollato: il reato è permanente e la permanenza cessa quando lo stato antigiuridico è venuto meno.
4. La sentenza richiamata in esordio ha affermato alcuni princìpi di diritto: «colui il quale subentra 6 contrattualmente nella gestione dei rifiuti risponde direttamente del reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, e non del reato di cui all’art. 255, comma 3, stesso decreto se, dopo aver provveduto all’iniziale smaltimento dei rifiuti, ha cessato la condotta lasciando in deposito incontrollato i residui rifiuti; la condotta di deposito incontrollato dei rifiuti consiste anche nel lasciare in deposito i rifiuti stessi, non richiedendo necessariamente la norma che l’agente conferisca ulteriori rifiuti rispetto a quelli dei quali abbia assunto la gestione diretta».
Questi i passaggi salienti della vicenda. L’imputato era il legale rappresentante della società denominata «Europambiente S.r.l.», che aveva acquisito nel 2005 il ramo di azienda della società denominata «ex Nuova Esa»; questa società era proprietaria di un impianto di rifiuti sottoposto a sequestro preventivo nel marzo 2004 per illeciti commessi nel corso della sua attività; nel giugno 2004 la Nuova Esa aveva presentato al Pubblico Ministero un piano di smaltimento dei rifiuti con contestuale richiesta di dissequestro dell’impianto; nel dicembre 2004 il Pubblico Ministero aveva dissequestrato le aree a condizione che fosse ultimata la procedura di smaltimento dei rifiuti ancora in sequestro; il 30 dicembre 2005 la Nuova Esa aveva ceduto a Europambiente parte dell’azienda e nel contratto si obbligava a provvedere allo smaltimento dei rifiuti stoccati nello stabilimento, mentre la cessionaria si dichiarava disponibile a portare a compimento tale operazione; a seguito di sopralluogo del 2 luglio 2009, veniva accertato che la Europambiente S.r.l. non aveva più adempiuto all’obbligo di smaltire i rifiuti già appartenenti alla Nuova Esa.
Su questa base fattuale, il legale rappresentante della Europambiente S.r.l. veniva accusato di detenere in deposito incontrollato una notevole quantità di rifiuti prodotti dalla società acquisita; il fatto veniva contestato come commesso fino al 15 febbraio 2012, data di cessazione dell’imputato dalla carica amministrativa.
Nei parr. 3.9 e 3.10, la sentenza spiega che cosa si debba intendere per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti: la prima condotta si esaurisce in un gesto isolato che produce res derelictae; l’altra evoca il persistente dominio sulle cose e ne esclude l’abbandono. Secondo l’italiano corrente, il sostantivo «deposito» indica l’atto con cui si «depone un oggetto in un luogo o lo si affida a una persona, perché venga custodito e riconsegnato a un’eventuale richiesta o allo scadere di un termine prefisso».
La decisione solleva una serie di questioni.
Un primo problema è stabilire se, quando il legale rappresentante di Europambiente S.r.l. ha acquisito la detenzione dei rifiuti, «abbandonati» dalla precedente impresa, ne sia divenuto gestore «attivo». La questione è collegata al fatto che il subentrare nella disponibilità di un’area, sulla quale altri soggetti hanno scaricato rifiuti, non comporta di per sé alcun effetto giuridico, in particolare non fa sorgere in capo al nuovo possessore l’obbligo di smaltire i rifiuti.
La giurisprudenza da tempo ha infatti espresso l’orientamento secondo cui il proprietario di un terreno non risponde del reato di discarica abusiva – e analogamente del deposito incontrollato – soltanto sulla base del proprio comportamento omissivo, consistente nella mancata rimozione dei rifiuti, perché, a norma dell’art. 40, comma 2, c.p., una condotta omissiva può dare luogo a responsabilità solo quando il soggetto abbia l’obbligo giuridico di impedire l’evento, obbligo che nella specie non è previsto da alcuna norma giuridica7.
Tale conclusione è la logica derivazione dei princìpi già affermati in una risalente, ma mai superata, decisione delle Sezioni Unite della Cassazione 8 e cioè che «Il reato di gestione di discarica abusiva (e, in termini analoghi, il reato di stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi) presuppone l’apprestamento di un’area per raccogliervi i rifiuti e consiste nell’attivazione di un’organizzazione, articolata o rudimentale non importa, di persone, cose e/o macchine diretta al funzionamento della discarica; il reato è permanente per tutto il tempo in cui l’organizzazione è presente e attiva; trattasi di reato che può realizzarsi solo in forma commissiva e perciò esso non comprende anche il mero mantenimento di una discarica o di uno stoccaggio da altri realizzati in assenza di qualsiasi partecipazione attiva e in base alla sola consapevolezza della loro esistenza. Chi sia subentrato nella disponibilità di una discarica, da altri soggetti realizzata ed esaurita, non ha l’obbligo di intervenire per la rimozione (o la ricopertura) dei rifiuti medesimi, salvo che ciò non gli venga imposto dal sindaco per motivi di igiene pubblica, nel qual caso è obbligato a provvedere sotto pena di commettere il reato di cui all’art. 650 c.p.».
Significativo, ai nostri fini, è il punto in cui la Corte ha sostenuto che «Il problema si pone in termini analoghi rispetto al reato di smaltimento mediante stoccaggio di rifiuti tossici o nocivi per chi si trovi a disporre del terreno già oggetto dello stoccaggio: se estraneo o responsabile come chi i rifiuti in precedenza abbia ammassato. A tal fine occorre chiedersi se tale reato si estenda fino a comprendere anche il mantenimento e cioè il tenere in stoccaggio i rifiuti stessi risalenti a tempi precedenti, come appunto nel caso in esame in cui sull’area a servizio dello stabilimento della Smov erano stati stoccati i rifiuti dall’impresa stessa prodotti. Come si desume dal combinato disposto degli artt. 16, comma 2, e 26, d.p.r. n. 915/82, il reato di smaltimento mediante stoccaggio dei rifiuti tossici e nocivi consiste nell’accumulare e stipare i rifiuti in un dato luogo (...) Anche qui, il fatto che sia un reato permanente non vuol dire, per ciò solo, che coinvolga pure chi, come lo Zaccarelli, su un terreno entrato nella sua disponibilità si ritrovi e vi mantenga i rifiuti accumulativi da chi lo abbia preceduto. Lo esclude sia la suaccennata nozione di smaltimento intesa come condotta di chi si disfa dei rifiuti e non già li trattiene, sia la terminologia “chiunque effettui le fasi di smaltimento” (art. 26), che postula una condotta commissiva, sia, infine, l’avere il legislatore escluso il mantenimento dalle numerose operazioni di smaltimento pure analiticamente elencate nell’art. 1 del decreto».
Ciò chiarito, va tuttavia rilevato che commette il reato di gestione illecita di rifiuti colui che, rinvenuti rifiuti da altri abusivamente smaltiti o abbandonati, compia a sua volta attività di gestione degli stessi, quali la raccolta, lo stoccaggio, l’abbandono o lo smaltimento in assenza di autorizzazione9.
Ci si chiede dunque se costituisca una forma di gestione, rilevante per far assumere al nuovo proprietario del sito la qualità di potenziale soggetto attivo del reato, l’impegno, assunto contrattualmente con l’impresa che aveva prodotto ed abbandonato i rifiuti, di provvedere al loro smaltimento. In effetti, come ha sostenuto la Cassazione, «Il ricorrente è subentrato in una nuova fase gestoria dei rifiuti diventandone a tutti gli effetti depositario, quand’anche al solo fine del loro definitivo smaltimento».
Pertanto, nonostante una certa forzatura della norma, dovuta al fatto che il subentrante non provvide direttamente all’ammasso dei rifiuti, formando così un deposito, ma si ritrovò giacenti sull’area rifiuti da altri abbandonati, non si può negare che, nella vicenda in esame, il nuovo titolare del sito avesse comunque realizzato un deposito con una condotta attiva 10 avendo deciso di stoccare i rifiuti per il loro smaltimento da portare a termine con i tempi imposti solo dalla complessità tecnica delle operazioni da svolgere.
Così inquadrata la fattispecie, la situazione poteva dunque costituire un deposito. Nulla però viene detto in sentenza circa le modalità di conduzione del medesimo che, in teoria, poteva anche essere controllato e quindi non vietato. In difetto di informazioni, reputiamo che nella specie il deposito dovesse essere «incontrollato» e quindi punibile ex art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/06.
Una criticità si coglie però nel par. 3.16 della decisione in cui la Suprema Corte ha sostenuto che «La cessazione delle operazioni di conferimento e smaltimento dei rifiuti non ha fatto venir meno il deposito, poiché i rifiuti non sono mai usciti dalla diretta signoria del ricorrente, ma ha fatto venir meno la liceità 11 del deposito stesso trasformato, nel settembre dell’anno 2009, da strumento finalizzato alla raccolta, in vista dello smaltimento mediante conferimento, a forma di smaltimento definitivo essa stessa, essendo stati i rifiuti lasciati in stato di abbandono senza che sia mai venuto meno il dominio dell’imputato il quale, secondo lo schema del reato permanente (...) in qualunque momento avrebbe potuto rimuovere lo stato di antigiuridicità già prodottosi, almeno fino a quando aveva conservato la legale rappresentanza dell’ente (15 febbraio 2012)».
Orbene, l’evento descritto, unitamente al fatto che l’imputato dopo aver materialmente cessato le operazioni di smaltimento, aveva realizzato una parziale copertura dei rifiuti, rappresentava univoca manifestazione della volontà dismissiva del rifiuto incompatibile con l’istituto del deposito incontrollato, con la conseguenza che la permanenza del reato era cessata in quel frangente (e cioè nel 2009) e non quando il detentore aveva lasciato la legale rappresentanza della società (2012).
Pertanto, sostenere che, successivamente al momento di cessazione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti e del conseguente loro definitivo abbandono, persistesse il «dominio finalistico dell’autore della condotta», sicché l’imputato, secondo lo schema del reato permanente, avrebbe potuto rimuovere lo stato di antigiuridicità già prodottosi, non solo finisce per dissolvere la vera essenza dell’istituto del deposito incontrollato, ma comporta che nella condotta tipica del reato venga ricompreso anche un comportamento omissivo, consistente nella mancata rimozione dei rifiuti, in contrasto con le statuizioni della giurisprudenza prima ricordata, concernente la posizione di chi subentri nella detenzione di rifiuti scaricati su un fondo da altri soggetti.
Vincenzo Paone
1 Cass. Sez. III Pen. 29 luglio 2024, n. 30929, in epigrafe.
2 Giorno dell’entrata in vigore della l. 9 ottobre 2023, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione, che ha sostituito il comma 1 dell’art. 255, d.lgs. n. 152/06.
3 Non trascuriamo, tuttavia, che anche un unico conferimento di rifiuti, purché in quantità ingente e quindi idoneo a far assumere alla zona interessata l’inequivoca destinazione di ricettacolo di rifiuti, può rientrare nello schema del reato di discarica.
4 Cass. 11 febbraio 2016, n. 5716, P.M. in proc. Isoardi, in Foro it., 2016, II, 433.
5 Le dichiarazioni, non sempre disinteressate, del detentore vanno corroborate con altri elementi, come la natura, le caratteristiche dell’ammasso e la sua evoluzione nel tempo.
6 Per precedenti decisioni sul tema, v. Cass. 5 maggio 2023, n. 18917, B F., in RGA online, giugno 2023; Cass. 28 luglio 2021, n. 29578, C., in Ambiente e sviluppo, 2021, 804.
7 Tra le tante, da ultimo, v. Cass. 8 febbraio 2019, n. 13606, Liguori e Marrone, in Foro it., 2019, II, 609.
8 Cass. Sez. Un. 5 ottobre 1994, n. 12753, Zaccarelli, in Foro it., 1995, II, 345.
9 Cass. 20 marzo 2024, n. 11599, La Fauci, in www.osservatorioagromafie.it e in RGA online, 1° luglio 2024. Nella specie, l’imputato aveva rotto un fronte di rifiuti interrati e abbandonati da altri e deciso, successivamente, di ammassarli in zona limitrofa.
10 Soddisfacendo il requisito che la contravvenzione di cui trattasi descrive una condotta esclusivamente commissiva.
11 Si è già osservato che non si sa nulla sulle modalità di conduzione del deposito e perciò non capiamo in base a quali elementi la sentenza parli di un deposito lecito.