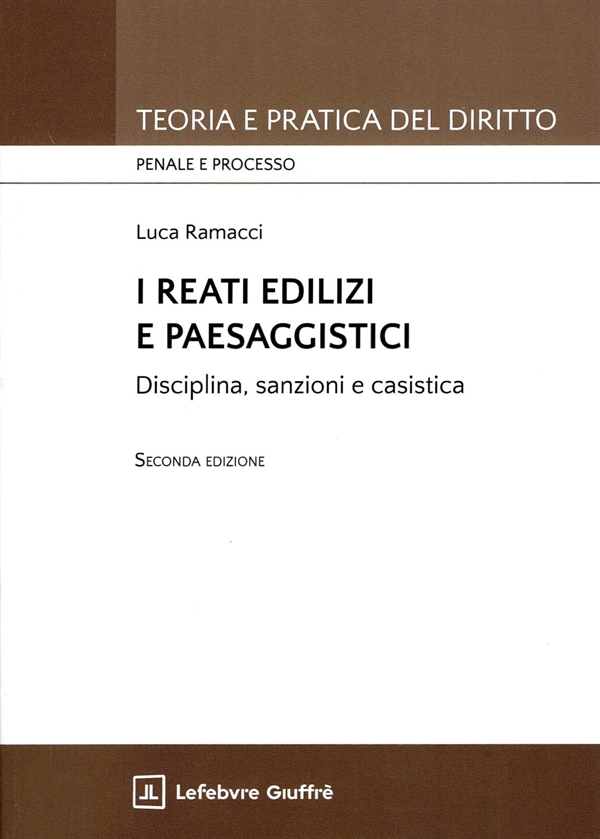Cass. Sez. III n. 42065 del 16 novembre 2011 (Cc 29 set. 2011)
Cass. Sez. III n. 42065 del 16 novembre 2011 (Cc 29 set. 2011)
Pres. Ferrua Est. Marini Ric. Gambino
Urbanistica. Determinazioni amministrative e poteri del giudice
Non è corretto sul piano sistematico affermare che il giudice ordinario deve arrestare il proprio controllo allorché si sia in presenza di determinazioni amministrative, e a maggior ragione di pronunce del Consiglio di Stato, che dopo avere bilanciato gli interessi contrastanti individuino il punto di equilibrio tra gli stessi e acconsentano alla realizzazione di interventi modificativi di un bene soggetto a tutela.
Interventi che incidano sulla conservazione e l'integrità del bene storico sono possibili. e dunque autorizzabili, esclusivamente qualora essi mirino a valorizzare o meglio utilizzare il bene protetto, anche mediante modifiche d'uso che ne salvaguardino, pur in una prospettiva di adeguamento al mutare delle esigenze, la natura e il valore.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 29/09/2011
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - N. 1684
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - est. Consigliere - N. 18229/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GAMBINO Maria Teresa, nata a Genova il 24 Giugno 1949;
Avverso la ordinanza in data 11 Aprile 2011 del Tribunale di Genova, che ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Genova in data 24 Marzo 2011;
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Luigi Marini;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dr. Volpe Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i Difensori, Avv. Scopesi Mario e Avv. Madia Titta, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
RILEVA IN FATTO
Con decreto depositato in data 25 Marzo 2011 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Genova ha disposto il sequestro preventivo "dell'area di Parco pubblico dell'Acquasola interessata dai lavori di realizzazione del parcheggio interrato di cui alla determinazione dirigenziale n. 2008/118.18.062". La richiesta del P.M. concerneva l'esistenza del "fumus" del reato previsto dall'art. 110 c.p. e D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 170, e del reato previsto dall'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) in relazione al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 169 e 170.
Il Giudice ha respinto la richiesta avanzata dal P.M. con riferimento all'ipotesi ex D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 e ha respinto l'ipotesi dallo stesso avanzata con riferimento al reato ex D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 170, limitatamente alla prospettata illegittimità ab origine dell'intera procedura e dei provvedimenti autorizzatori a causa dell'esistenza di un grave illecito penale (concussione) commesso dal funzionario pubblico che gesti la prima fase della procedura e gli accordi transattivi con la società aggiudicataria dei lavori.
Ha, quindi, proceduto (pagg. 5 e 6 del decreto) all'esame dei principali atti della complessa procedura, a partire dai pareri della Soprintendenza per giungere agli esiti della conferenza dei servizi e alla determinazione conclusiva dell'8 agosto 2008. Sulla base di queste premesse il Giudice ha ritenuto (pag. 6 e ss.) fondata la richiesta del P.M. e ravvisato la sussistenza del "fumus" del reato previsto al capo A). Muovendo dalle caratteristiche dei "giardini e parchi storici" e dalle specifiche esigenze di tutela che essi pongono in quanto "beni viventi" e che sono state incluse nelle linee guida adottate nelle c.d. "carte di Firenze", il Giudice ha considerato che l'intervento progettato e autorizzato si pone in contrasto con la conservazione e la tutela del parco, soprattutto dopo che gli accertamenti tecnici hanno consigliato di rinunciare al reimpianto degli alberi di maggior fusto e dopo che si è reso evidente che con cadenza di circa 40 anni la copertura di terra e le piante poggiate sopra le aree prensili dovranno essere rimosse per la necessaria manutenzione dei manufatti. Di conseguenza, sebbene regolarmente autorizzate mediante atti amministrativi che hanno trovato conferma in sede di Consiglio di Stato a seguito di ricorsi giurisdizionali, le opere si pongono in contrasto con gli del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e deve ritenersi sussistente il "fumus" di reato, anche sotto il profilo soggettivo (sul punto si rinvia al penultimo capoverso di pag. 9 della motivazione del decreto). Con la decisione impugnata in questa sede il Tribunale di Genova ha confermato il decreto di sequestro preventivo. Come esposto in particolare alle pagine 6 e seguenti della motivazione, l'ordinanza illustra le ragioni che conducono a respingere le prospettazioni della difesa. Afferma, tra l'altro (pag. 7) che l'intervento conclusivamente autorizzato comporterebbe una demolizione di una parte consistente del parco senza una successiva ricostruzione, ipotesi vietata dall'art. 20 e non effettuabile ai sensi dell'art. 21, citati. Il carattere sostanzialmente demolitorio delle opere non viene meno per l'intervenuta emanazione dei provvedimenti autorizzatori. Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, il Tribunale richiama la sentenza di questa Corte n. 10618 del 2010 per concludere che l'adozione del sequestro preventivo prescinde dall'accertamento dell'elemento soggettivo in capo al titolare del bene.
Avverso tale decisione la Sig.ra Gambino, quale legale rappresentante della Sistema Parcheggi Srl, propone ricorso tramite il Difensore.
Il ricorso, effettuata una sintetica esposizione dell'iter della procedura amministrativa che autorizza la Sistema Parcheggi Srl ad effettuare l'intervento edilizio, propone in sintesi i seguenti motivi.
Con primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per omessa considerazione della evidente assenza dell'elemento soggettivo del reato. Erroneamente il Tribunale ha ritenuto di escludere ogni propria competenza in ordine alla valutazione dell'elemento soggettivo, e ciò ha fatto richiamando in modo impreciso una sentenza di legittimità (Sesta Sezione Penale, sentenza n. 10618 del 2010) e omettendo di considerare che altre decisioni della Corte Suprema hanno espresso un diversa interpretazione sulla scia dell'ordinanza della Corte costituzionale, n. 153 del 2007.
Con secondo motivo lamenta errata applicazione del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 20 e 21. In modo errato e infondato il Tribunale afferma l'esistenza di principi di ordine generale che in tema di beni culturali sottrarrebbero anche al Ministero la possibilità di autorizzare interventi diversi da quelli di conservazione e salvaguardia dei beni protetti; tali principi non sono certo enucleabili dal disposto degli artt. 20 e 21 citati, così che non si ravvisa quale fonte giustifichi l'affermazione della intangibilità dei beni culturali.
Con terzo motivo lamenta l'errata applicazione del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 170. Erroneamente il Tribunale ha ritenuto integrata la violazione per l'esistenza di interventi modificativi del bene, mentre l'art. 170 citato, sanziona esclusivamente la destinazione del bene ad un "uso" incompatibile col carattere storico e artistico oppure pregiudizievole per la conservazione e integrità del bene. E siccome il concetto di "uso" rilevante ai nostri fini non coincide con l'utilizzazione che le persone fanno del bene, ma solo l'utilizzazione che a questo è assegnata nel provvedimento concessorio, è evidente che la costruzione del parcheggio sotterraneo pone un tema di compatibilità che riguarda coloro che hanno autorizzato l'intervento e non chi sulla base di quell'autorizzazione, ha dato corso regolarmente ai lavori. Con quarto motivo lamenta l'assenza di legittimazione del giudice penale a sindacare l'atto amministrativo (in particolare la deliberazione 8 agosto 2008) sotto profili diversi dalla liceità e legittimità; in specie, il giudice penale non ha alcun titolo a valutare la legittimità dell'atto sotto il profilo della sua opportunità; quest'ultimo profilo è stato oggetto di plurime decisioni del giudice amministrativo richiamate in premessa così che, nel rispetto del principio di unicità della giurisdizione, non può formare oggetto della decisione in sede penale.
OSSERVA IN DIRITTO
L'ampio e articolato ricorso e gli altrettanto articolati provvedimenti giudiziali di cui si chiede il controllo descrivono una situazione di fatto di rilevante complessità, che potremmo definire paradigmatica dei rapporti esistenti nel nostro Paese fra beni collettivi, diritti e interessi individuali, azione della pubblica amministrazione o, meglio delle pubbliche amministrazioni, e attribuzioni del giudice ordinario.
11 compito di questo giudice è, peraltro, limitato all'esame dei profili specifici sottoposti al suo controllo e alla individuazione dei soli profili di ordine generale rilevanti per la decisione. Non vi è dubbio, ad esempio che il principio di affidamento del cittadino rispetto alle scelte della pubblica amministrazione costituisca un elemento che deve essere tenuto in considerazione, ma di analoga rilevanza risulta essere il principio di lealtà nei rapporti fra soggetti privati e soggetti pubblici, così come non può essere trascurata la considerazione che in materia di beni di particolare rilevanza per la collettività, che l'ente pubblico ha sottoposto a specifiche garanzie, il bilanciamento tra l'interesse collettivo e quello individuale non è necessariamente esaurito dalle determinazioni delle amministrazioni pubbliche, come sarà in seguito specificato.
Venendo ai singoli profili posti all'attenzione di questa Corte, si osserva quanto segue.
1. Sostiene la ricorrente che l'intero impianto logico che sorregge il provvedimento cautelare presenta un punto di criticità insormontabile: l'assenza dell'elemento soggettivo del reato in capo all'unica indagata, che fa sorgere l'obbligo per il giudice di escludere il "fumus" di reato e la possibilità di conservare il sequestro.
Corrisponde a verità che la giurisprudenza non è più univoca nel considerare irrilevante in sede di riesame la valutazione dell'elemento soggettivo del reato, ivi compresa l'esistenza di profili di colpa. All'impostazione secondo cui nella valutazione circa l'esistenza del "fumus" il controllo giudiziale deve essere limitato alla sola corrispondenza tra l'ipotesi fattuale e la fattispecie legale (per tutte, Seconda Sezione Penale, sentenza n.2808 del 2009, rv 242650) si affianca oggi una interpretazione costituzionalmente orientata sulla scia della ordinanza della Corte costituzionale, n. 153 del 2007, secondo la quale il giudice può estendere il controllo anche alla sussistenza dell'elemento soggettivo, nel senso che il "fumus" può essere escluso quando si ravvisi "Ictu oculi" l'assenza di profili di dolo o di colpa rispetto alla condotta o all'evento posti a base della misura cautelare (si veda l'esame di tale profilo compiuto dalla Quarta Sezione Penale con la sentenza 23944 del 2008, rv 240521).
Ora, non vi è dubbio che nel caso in esame non appare privo di rilievo l'argomento prospettato dalla ricorrente circa l'esistenza di una propria evidente buonafede, che trova fondamento nel complesso iter amministrativo seguito e nella conferma circa la legittimità del progetto derivante dalle decisioni che il Consiglio di Stato ha assunto anteriormente all'avvio dei lavori. Tuttavia, la Corte deve mettere in evidenza che appare non corretto limitare la valutazione della fondatezza e della legittimità del sequestro avendo riguardo esclusivamente alla posizione soggettiva della persona individualmente indagata e trascurare, per contro, le finalità del provvedimento cautelare in relazione alla complessiva vicenda procedimentale. In altri termini, qualora il giudice ravvisi l'esistenza del "fumus" obiettivo di una violazione che offende interessi protetti, è tenuto a valutare la legittimità del sequestro tenendo conto della sua natura di strumento indispensabile ex art. 321 c.p.p., comma 1, al fine di impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze o che il bene protetto subisca comunque ulteriori offese. Non vi è dubbio, allora, che il sequestro può essere legittimamente disposto nei casi in cui sono ignote le persone che possono avere commesso l'illecito, così come nei casi in cui solo una parte dei possibili autori sono stati individuati e iscritti nel registro delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p.. Inoltre, se un problema di buona fede può porsi fin dalla prima fase delle indagini con riferimento alle ipotesi di confisca obbligatoria a seguito di condanna, nel senso che ove difetti manifestamente l'elemento soggettivo occorre considerare la prognosi di futura assoluzione che non consentirebbe la confisca del bene, non altrettanto può dirsi per le ipotesi in cui ai fini della confisca rileva anche il solo l'accertamento della violazione sul piano obiettivo.
Tutto ciò premesso, la Corte rileva che nel caso in esame il reato ipotizzato va considerato come plurisoggettivo e l'iscrizione della notizia di reato è stata effettuata nei confronti della ricorrente in concorso con persone da identificare. Si tratta di impostazione coerente con l'ipotesi avanzata dal Pubblico Ministero, che valuta come non conformi a legge i provvedimenti autorizzativi e non può per questo non valutare la posizione di coloro che quei provvedimenti hanno emanato quanto meno in cooperazione colposa con la legale rappresentante della società appaltatrice dei lavori. Così ricostruita l'ipotesi di reato sottesa al sequestro in esame, la possibile assenza di profili di colpa in capo alla ricorrente assume contorni di complessità maggiori di quelli che possono essere rilevati ad una prima lettura degli atti; permangono, poi, i profili di responsabilità degli amministratori pubblici che spetta al Procuratore della Repubblica individuare e identificare. Sulla base di tali considerazioni la Corte ritiene che non sussista la prospettata manifesta assenza di "fumus" di reato con riferimento alla carenza dell'elemento soggettivo.
2. Quanto alla sussistenza del "fumus" di reato con riferimento alle condotte e alle altre circostanze di fatto ampiamente esposte nei provvedimenti cautelari e nel ricorso, la Corte ritiene di dover concentrare l'attenzione su un profilo che appare decisivo: la compatibilità dell'uso con la natura e le caratteristiche proprie del bene pubblico avente valore storico che risulta interessato dal progetto e dai lavori.
Afferma la ricorrente con ampie argomentazioni che l'attenzione deve avere riguardo essenzialmente a due profili: a) il concetto di "uso" rilevante ai fini del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 170 non ricomprende l'utilizzazione fattuale del bene, bensì l'utilizzazione che viene individuata e disciplinata dai provvedimenti di autorizzazione; b) la compatibilità fra l'utilizzo del bene e la sua natura e destinazione è giudizio rimesso esclusivamente all'ente pubblico, e al giudice amministrativo ove necessario, e non può costituire oggetto di valutazione da parte del giudice ordinario. 3. La Corte ritiene che non sia corretto sul piano sistematico affermare che il giudice ordinario deve arrestare il proprio controllo allorché si sia in presenza di determinazioni amministrative, e a maggior ragione di pronunce del Consiglio di Stato, che dopo avere bilanciato gli interessi contrastanti individuino il punto di equilibrio tra gli stessi e acconsentano alla realizzazione di interventi modificativi di un bene soggetto a tutela.
Questa Sezione ha avuto modo di affrontare più volte il tema del rapporto fra bene protetto e intervento del giudice ordinario in settori ove la pubblica amministrazione esercita poteri discrezionali che le sono attribuiti dalla legge; per ciò che rileva ai fini della presente decisione, la Corte può limitarsi a rinviare alle ampie argomentazioni con le quali il giudice di legittimità ha chiarito l'esistenza di margini di apprezzamento del giudice ordinario; in particolare, può rinviarsi alle osservazioni contenute nelle sentenze della Terza Sezione Penale n.37181 del 2010, PM in proc. Martino (rv 248623) e n.34205 del 2010, Vastarini e altro (rv 248369). La prima decisione afferma che l'annullamento da parte del giudice amministrativo della revoca del nulla osta rilasciato dall'ente preposto alla tutela del vincolo non comporta automaticamente la caduta dei presupposti del sequestro preventivo disposto dal giudice dopo avere valutato la non legittimità del nulla osta stesso. La seconda decisione evidenza come anche successivamente alle modifiche apportate dalla L. n. 308 del 2008 alla disciplina del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, l'accertamento sull'offesa al bene paesaggio è di competenza del giudice penale e il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica può assumere rilievo solo ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo del reato e della gravità dello stesso; principio, questo, affermato dalle Sezioni Unite Penali con riferimento agli estremi della contravvenzione prevista dall'art.724 c.p. (sentenza n.248 del 1992, rv 193416).
4. La lettura della motivazione della sentenza n.34205 del 2010 introduce un ulteriore argomento interpretativo che assume rilevanza nel caso in esame. Osservava, infatti, la Corte che spetta "al giudice penale di verificare, a fronte di una compromissione del paesaggio e dell'ambiente, la corrispondenza delle opere al provvedimento nonché la liceità e legittimità (ma non l'opportunità) dei relativi atti amministrativi, in quanto l'eventuale illegittimità di tali atti potrebbe essa stessa costituire elemento essenziale della fattispecie criminosa (Sez. 4, n.32125 del 29/3/2004, Rv, 229092)".
Si è in presenza di un passaggio motivazionale, integralmente condiviso da questa Corte, che chiarisce come il giudice penale non possa sindacare l'esercizio della discrezionalità tecnica dell'ente e le determinazioni che su tale base sono state assunte, ma abbia il dovere di verificare la liceità e la legittimità dell'atto amministrativo al fine di vagliarne la rilevanza nella determinazione sulla liceità delle condotte tenute dal privato anche in base a quell'atto. In altri termini, un atto illegittimo della pubblica amministrazione, per quanto confermato dal giudice competente, non può rimuovere gli ostacoli o i divieti che la legge ha posto nei confronti delle condotte del privato al fine di tutelare un interesse pubblico qualificato.
Osserva la Corte in via incidentale che le decisioni del T.A.R. e del Consiglio di Stato richiamate dalla ricorrente e acquisite agli atti del procedimento meriteranno una lettura più articolata e approfondita di quella che viene prospettata nel ricorso: il contenuto delle decisioni si collega alla specificità del petitum e degli argomenti presentati da ricorrenti e resistenti, così che sembra di poter concludere che si è in presenza di decisioni che non esauriscono tutti gli aspetti rilevanti per le determinazioni del giudice penale. Si tratta, peraltro, di temi che non risultano essenziali ai fini della presente decisione e che dovranno costituire oggetto dell'esame di merito.
5. Sulla base di tali premesse di ordine generale può essere esaminato adesso il contenuto degli atti autorizzatori e delle condotte poste in essere dalla ricorrente.
La pregevole illustrazione contenuta nel ricorso circa il concetto di "uso" rilevante ai fini della integrazione della violazione ex D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 170 deve essere esaminata alla luce delle previsioni contenute negli artt. 20 e 21 di tale legge e alla luce della giurisprudenza che si è occupata dell'argomento. L'art.20 afferma che i beni culturali, e non vi è dubbio che tale debba essere considerato ai sensi della citata Legge, art. 10 il Parco dell'Acquasola, "non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti a usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione". Il successivo art. 21 disciplina gli interventi e le modifiche che possono essere apportate a tali beni e prevede l'obbligo di preventiva autorizzazione del Ministero nei casi specificamente indicati, fra i quali (comma 1, lett. a) è inclusa anche l'ipotesi di demolizione "anche con successiva ricostituzione". I commi 4 e 5 disciplinano più specificamente l'esecuzioni di lavori, questa volta soggetti ad autorizzazione del Soprintendente e non del Ministero. È importante evidenziare che il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi "è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all'art. 20, comma 1", e cioè per salvaguardare comunque il loro carattere storico o artistico e la loro integrità.
6. L'insieme degli elementi così richiamati consente alla Corte di giungere ad una prima conclusione: interventi che incidano sulla conservazione e l'integrità del bene storico sono possibili, e dunque autorizzabili, esclusivamente qualora essi mirino a valorizzare o meglio utilizzare il bene protetto, anche mediante modifiche d'uso che ne salvaguardino, pur in una prospettiva di adeguamento al mutare delle esigenze, la natura e il valore. Ciò non sembra avvenuto nel caso di specie, dove gli interventi sul bene protetto non sono stati progettati e realizzati con la finalità di salvaguardare e valorizzare la sua natura storica e di attualizzare la destinazione pubblica che gli appartiene, bensì con la finalità di soddisfare beni e interessi diversi che con quella natura e quella destinazione non hanno relazione alcuna e, anzi, si caratterizzano in concreto come interessi contrapposti. Osserva la Corte che l'integrità e la fruibilità da parte della cittadinanza del bene protetto hanno conosciuto una compressione rilevante e destinata a protrarsi nel tempo, tanto da poter essere definita strutturale, al fine favorire interessi alla viabilità e al parcheggio che attengono a sfere della vita sociale del tutto diverse. In altri termini è certo che una parte del parco ha subito una compromissione strutturale che non ha la finalità migliorare l'uso che la collettività può fare del parco stesso, come sarebbe, invece, nelle ipotesi in cui il parcheggio fosse finalizzato a migliorare l'accesso al bene o la sua fruibilità in concreto. 7. Può, dunque, concludersi che allo stato degli atti sussistono ragioni per ritenere immune da vizi logici la motivazione dell'ordinanza impugnata - che deve essere letta anche alla luce delle articolate considerazioni esposte nel decreto di sequestro - nella parte in cui afferma che si è in presenza del "fumus" del reato previsto dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 170, posto che l'uso che viene previsto per la porzione del parco soggetta ai lavori può essere considerato "incompatibile" con il carattere storico del bene e ne pregiudica la conservazione e la integrità. 8. Osserva, in ultimo, la Corte che anche nel caso in esame trova applicazione il principio fissato da questa Sezione, in linea con la più generale interpretazione delle norme in tema di limiti del giudizio di legittimità, secondo il quale la valutazione circa "l'uso incompatibile" del bene culturale consistente in una distorsione del godimento che gli è proprio (studio, ricerca, piacere estetico), ma lo stesso può affermarsi per i beni di riconosciuto valore storico, rappresenta una questione di merito non suscettibile di intervento della Corte di Cassazione se non in presenza di un radicale difetto di motivazione del provvedimento impugnato (sentenza n. 14377 del 2005, PM in proc. Veneroso, rv 231072) cosa che non è nel caso in esame.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011