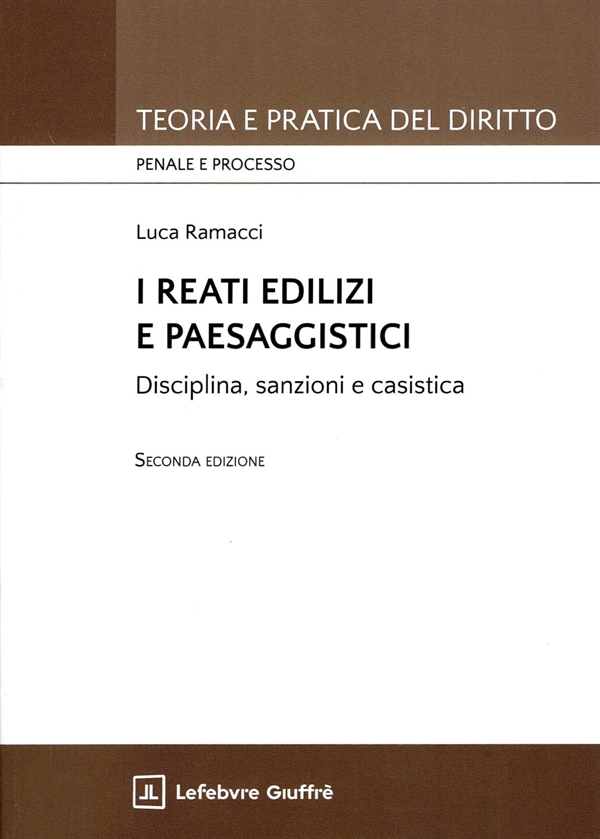Il ruolo della giurisprudenza internazionale, comunitaria, italiana in materia ambientale
Il ruolo della giurisprudenza internazionale, comunitaria, italiana in materia ambientale
di Amedeo POSTIGLIONE
Il ruolo della giurisprudenza
internazionale, comunitaria, italiana
in materia ambientale
Amedeo Postiglione
Magistrato della Corte Suprema di Cassazione
Cofondatore del Forum europeo giudici per l’ambiente
Direttore Fondazione ICEF
Sommario:
Parte I La prima fase :la costruzione di un diritto ambientale
1-Il ruolo della giurisprudenza internazionale. - 2. Il ruolo della giurisprudenza comunitaria
.3. Il ruolo della giurisprudenza italiana. - 3.1. Il ruolo della giurisprudenza costituzionale. - 3.1.1. I due filoni principali. - 3.1.2. Osservazioni. - 3.1.3. Altre sentenze significative. - 3.2. Il ruolo della giurisprudenza ordinaria. - 3.2.1. Le principali linee evolutive. 3.2.2. Singoli settori: considerazioni operative. - 3.2.3. Alcuni casi più interessanti.
Parte II La seconda fase: le garanzie unitarie per l’effettività
1..La Corte penale internazionale-2. La Corte internazionale di giustizia- 3. La tutela penale dell’ambiente nel diritto comunitario 4.Il ruolo delle Corti nazionali nel contenzioso climatico- 5. Il ruolo della Corte dei diritti umani di Strasburgo 6.L’ordine internazionale come diritto-dovere umano
Abstract
L’Autore propone una riflessione, nata dall’esperienza diretta per vari anni, sulla nascita del diritto e della giurisprudenza ambientale e sulle principali linee evolutive, in una visione integrata ai vari livelli .Le difficoltà incontrate e superate gradualmente nella prima fase in Italia sono emblematiche ; in Europa appare indubitabile il ruolo propulsore del diritto comunitario in tema di danno ambientale ed eco reati; a livello internazionale sono note le difficoltà, tuttora persistenti, in tema di risposta ai due principali problemi globali: il mutamento climatico e la difesa della biodiversità dell’intero ecosistema terrestre.
Sono coinvolte nella risposta tutte le componenti umane, ma operano potenti forze contrarie.
Quando la sicurezza e la pace sono messe in pericolo anche la protezione dell’ambiente comune viene ostacolata. Sicurezza, pace e protezione dell’ambiente devono procedere insieme.
I recenti conflitti in Ucraina ed in Palestina ne sono una prova evidente : gli Organi di garanzia, pur esistenti ,non possono operare con effettività.
La riflessione si sposta sull’ordine internazionale concepito come giustiziafondata non sulla forza unilaterale ma sulla reciproca collaborazione e su un ruolo più forte del diritto e della Comunità internazionale. Secondo l’Autore la via maestra per assicurare pace e ambiente anche alle future generazioni passa attraverso la valorizzazione reale e condivisa dei diritti e doveri umani, a cominciare dal fondamento : il diritto-dovere umano di ogni persona ad un ordine internazionale , di cui parlava già la Dichiarazione universale del 1948.
Mutamento climatico e biodiversità ,come fenomeni globali, possono ancora essere affrontati con qualche possibilità di successo, se un posto prioritario viene riconosciuto all’etica della verità, se si creaun clima di verità, solidarietà e reciproca collaborazione tra popoli e Stati : l’ordine internazionale deve nascere dal basso, rinnovando la fiducia nelle regole giuridiche condivise
necessarie a tale scopo.
I-Parte prima: la costruzione di un diritto ambientale
1. Il ruolo della giurisprudenza internazionale
Come è noto la Corte Internazionale di Giustizia, con sede a L’Aja, ha competenza giuridica generale per risolvere i conflitti tra Stati applicando il diritto internazionale.
Questa Corte si è occupata di alcune questioni, anche non direttamente riguardanti la materia ambientale, enunciando principi giuridici utili per la risoluzione di controversie specificamente ambientali. 1
Deve osservarsi che le controversie davanti alla Corte di Giustizia de L’Aja possono essere avviate solo dagli Stati e non anche dalle Organizzazioni internazionali o dalla società civile. Mancano due requisiti: piena accessibilità ed obbligatorietà.
Per questo motivo - cioè la natura solo interstatuale del modello - i casi di danno ambientale sovranazionale non trovano pieno accesso alla Corte e questo spiega il numero limitato dei casi esaminati, nonostante la creazione in una prima fase di una Sezione speciale Ambiente, poi abbandonata. Le difficoltà sono aumentate nel caso di conflitti, come quello in Ucraina ( v. ricorso Ucraina contro Federazione russa del 27 febbraio 2022 dopo l’invasione e l’ordine di sospensione delle operazioni militari del 16 marzo 2022, non eseguito per l’esercizio del diritto di veto da parte della Russia).
Gli Stati, nella Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare, hanno previsto un Tribunale Internazionale ad hoc, che opera in Amburgo dal 1996. 2 Poiché non può immaginarsi un altro tribunale internazionale settoriale per il clima ed un altro per la biodiversità, si è proposta dalla società civile e dal mondo scientifico la creazione di una nuova Istituzione internazionale specializzata ed unitaria, accessibile anche alla società civile, cioè ad una Corte Internazionale per l’Ambiente ,finora senza esito positivo.
2. Il ruolo della giurisprudenza comunitaria
Il diritto comunitario ambientale obbliga i 27 Paesi membri, i quali sono giuridicamente tenuti ad osservarlo.
La Corte di Giustizia della Comunità europea in Lussemburgo ha emanato molte sentenze nella materia ambientale.
Secondo uno studio di Ludwig Krämer (“Rivista giuridica dell’ambiente”, n. 1/2009, pag. 233 ss.), i casi di mancata trasposizione, nel periodo 1976-2007, sono stati 587.
Le questioni relative alla protezione della natura occupano il primo posto: si tratta di ricorsi aventi ad oggetto la “Rete Natura 2000”, cioè gli habitat di flora e fauna di interesse comunitario.
Al secondo posto, per numero, vengono le questioni in tema di rifiuti. Di particolare importanza è la nozione di rifiuto che - ad avviso dello scrivente - sembra tuttora molto rigida e condiziona anche la giurisprudenza nazionale nella soluzione di casi concreti (sottoprodotti; materie prime secondarie).
Molto limitata è la giurisprudenza sul rumore e questo non sembra un buon segnale per questo grave tipo di inquinamento che tocca da vicino la qualità della vita delle persone.
La durata dei procedimenti davanti alla Corte è di circa 20 mesi, ai quali si deve aggiungere la fase precontenziosa davanti alla Commissione.
I ricorsi sono proposti dagli Stati membri e della Commissione. La giurisprudenza non è stata finora favorevole all’accesso di persone ed associazioni di protezione ambientale: in pratica la Commissione europea monopolizza questo settore, ponendosi in contrasto con i principi della Convenzione di Aarhus in tema di accesso, trasparenza ed apertura. Tuttavia, non si possono ignorare i progressi conseguiti dal diritto comunitario nei singoli ordinamenti nazionali (compresa l’Italia) ed il ruolo propulsivo per la stessa giurisprudenza nazionale, considerato anche il potere del giudice nazionale di avanzare richieste di decisioni interpretative in via pregiudiziale.
Nei rapporti con l’ordinamento internazionale la Corte di Giustizia della Comunità europea ha stabilito un principio di grandissima rilevanza: poiché l’Unione Europea, come soggetto autonomo di diritto internazionale, ha sottoscritto più di 40 Convenzioni internazionali in tema di ambiente, queste norme sono divenute a tutti gli effetti diritto comunitario, che obbliga direttamente i 27 Paesi membri, con conseguente rafforzamento della tutela giuridica. Come si vede il principio di integrazione opera anche all’esterno e non solo all’interno (vedi sentenza Haegeman Judgement, CJEC, 30 aprile 1974, app. Haegeman, Rec, 1974 pag. 45).
3. Il ruolo della giurisprudenza italiana
La prima evoluzione
L’attenzione della magistratura italiana per l’ambiente non è episodica o marginale, ma è molto importante e consolidata.
a) Prima della emanazione di specifiche norme nei vari settori (acqua, alimenti, animali, aria, boschi e foreste, caccia, edilizia e urbanistica, energia, flora, paesaggio, beni culturali, parchi, riserve naturali e zone umide, pesca, rifiuti, rumore, salute, sostanze pericolose, suolo) la magistratura ha utilizzato norme poste per altre finalità, pur di soddisfare il nuovo interesse emergente in una visione unitaria. Alcune norme civili e penali già esistenti hanno consentito una prima giurisprudenza.
In materia civile la magistratura ha utilizzato l’art. 844 c.c. del 1942 relativo ai rapporti di vicinato dei proprietari contigui con riferimento alle immissioni di rumori, odori, ecc. oltre la soglia di normale tollerabilità. Con particolare efficacia la norma fondamentale della responsabilità extracontrattuale (l’art. 2043 c.c.) è stata utilizzata per casi di danno ambientale e danno alla salute.
In campo penale sono state valorizzate alcune ipotesi minori (art. 650 c.p. Inosservanza di provvedimenti dell’autorità in materia di sicurezza, giustizia e igiene; art. 659 c.p. Disturbo delle occupazioni e riposo delle persone; art. 674 c.p. Getto pericoloso di cose, tra cui emissioni di gas, vapori e fumo; art. 733 c.p. Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico della nazione; art. 734 c.p. Distruzione o deturpamento di bellezze naturali).
b) Nella tradizione italiana in due settori la giurisprudenza è cominciata in data più lontana , cioè fin dalla fine della Seconda Guerra Mondiale: si tratta delle materie del paesaggio(la prima legge è del 1939, n. 1497) e dei beni culturali (la prima legge è dello stesso anno 1939, n. 1089). Come è noto l’Italia ha sviluppato, per ragioni storiche e geografiche, una particolare sensibilità per i valori del paesaggio e della cultura e la magistratura ha dato un contributo in questi settori delicati e continua a darlo con efficacia.
c) Nella evoluzione storica il problema dell’inquinamento trova una prim a disciplina in tre grandi settori: per l’ atmosfera nel 1965 (legge n. 615), per le acque nel 1976 (legge n. 316), per i rifiuti nel 1982 (legge n. 915/1982). Queste regolamentazioni risentono dell’influsso delle prime direttive della Comunità europea ed hanno dato vita alla prima giurisprudenza.
L’inquinamento da rumoreera disciplinato nei luoghi di lavoro con d.P.R. n. 277/1991 e fuori dai luoghi di lavoro con la legge n. 447/1995 (quest’ultima legge per l’inquinamento da rumore prevede solo sanzioni amministrative e non sanzioni penali, sicché non si è formata una giurisprudenza significativa, salvo alcune decisioni di tipo civile o amministrativo).
d) Un fenomeno sociale merita d’essere segnalato, ossia la spinta delle associazioni di protezione ambientale , nazionali o locali, per l’accesso alla giustizia. ( Italia Nostra; Pro Natura; LIPU; WWF ;Kronos; FAI; Amici della Terra; Legambiente; Green Peace…). Una spinta importante è venuta in sede locale da Comitati di Quartiere e, a livello scientifico ,da autorevoli Università come Pavia ,Padova, Milano , Bolzano, Verona, Venezia, Bologna, Firenze, Urbino, Roma, Napoli, Bari ,Palermo.
Il fenomeno della promozione del nuovo valore ambiente ha ricevuto impulso anche ad opera diretta della giurisprudenza, con un duplice risultato positivo:
- la trasformazione sostanziale dell’ambiente, da interesse diffuso extra-giuridico in interesse collettivo, poi in interesse pubblico , poi ancora in diritto fondamentale della persona;
- l’estensione della legittimazione ad agire davanti ai giudici civili, penali ed amministrativi di un sempre maggiore numero di soggetti sociali, nazionali e locali.
e ) Nel 1986 veniva costituito il Ministero dell’ambiente (oggi divenuto Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare),come avvenuto in altri Paesi, con l’esplicito riconoscimento dell’ambiente come interesse pubblico, del diritto alle informazioni ambientali di ogni persona, del diritto alla partecipazione (in misura limitata ad alcune associazioni nazionali) ed infine con il riconoscimento esplicito del danno ambientale quale danno antigiuridico, da prevenire e riparare a carico del responsabile.
La legge n. 349/1986 relativa al Ministero dell’ambiente avviava anche la prima fase sperimentale attuativa della procedura di valutazione di impatto ambientale, almeno per i progetti più importanti (Allegato 1, direttiva 337/85/CE).
f) Nell’anno precedente (1985) erano state emanate due leggi importanti : la prima negativa (n. 47) che introduceva una forma generalizzata di condono o sanatoria per gli abusi edilizi; la seconda positiva ( legge Galasso n. 431) salvava in Italia, in nome del paesaggio, molte e vaste aree montuose, boschi e foreste, coste e rive dei fiumi, zone destinate a parchi, riserve naturali e zone umide.
g) Nel 1991 veniva varata la prima legge organica sui parchi, le riserve naturali e le zone umide (legge n. 391).
Nell’anno successivo 1992, era emanata la legge sulla caccia (la n. 157), con lo scopo dichiarato della protezione della fauna, anche alla luce delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie nella materia.
h) Per l’inquinamento delle acque si verificava una involuzione nella effettività della tutela: nel 1995 la sanzione penale era conservata solo in parte: per gli scarichi industriali e non per quelli degli allevamenti zootecnici; più recentemente nel 1999 la depenalizzazione era estesa anche all’inquinamento per questi settori (salvo 18 sostanze ritenute più pericolose).
Di conseguenza il numero di processi che arrivavano davanti ai giudici si riduceva drasticamente e ciò per evidenti ragioni politiche ed economiche, essendosi ritenuto troppo oneroso il regime precedente ( ossia l’interpretazione rigorosa , corretta e coerente data dalla Corte Suprema di Cassazione, sezione III penale, per oltre 20 anni ).
i) Nel settore dei rifiuti si verificava un fenomeno inverso, con un eccesso di sanzioni penali (legge n. 22/1997). La omessa bonifica dei siti inquinanti veniva sanzionata penalmente (art. 51-bis).
-A conclusione di questo punto, si può dire che la giurisprudenza ambientale nella prima fase di attuazione delle norme operava con efficacia e con sufficiente autonomia.
Ormai venivano coperti tutti i settori ambientali, non solo quelli tradizionali relativi all’inquinamento delle acque, dell’atmosfera, da rifiuti, da sostanze e produzioni pericolose, ma anche i settori relativi ad alimenti, salute, energia, rumore, inquinamento elettromagnetico, tutela del suolo, assetto del territorio, urbanistica, edilizia, cave, protezione della natura (parchi, riserve, zone umide, Rete Natura 2000, boschi e foreste, montagne, animali, caccia e pesca, biodiversità).
-Alcuni settori hanno visto crescere anche il ruolo del giudice amministrativo : legittimità degli atti e dei procedimenti; localizzazione degli impianti; valutazione di impatto ambientale; valutazione ambientale strategica; autorizzazione unica ambientale; diritto alle informazioni ambientali; diritto alla partecipazione nei procedimenti; diritto di accesso delle persone e delle formazioni sociali, locali e nazionali.
- Sul concetto giuridico di ambiente si richiamano ,tra le altre, alcune sentenze significative della Corte Suprema di Cassazione (Cass. sez. III, 20 ottobre 1983 n. 421, Mazzola e Cass., sez. III, 1° ottobre 1996, n. 1267, Locatelli) nelle quali viene sottolineato il carattere unitario dell’ambiente ed il valore di diritto umano fondamentale di ogni persona . Questi due aspetti saranno poi ripresi e sviluppati autorevolmente dalla giurisprudenza costituzionale ,come si vedrà successivamente ed il sistema finalmente troverà una conferma formale con la riforma introdotta con legge costituzionale del 9-2-2022,che esplicitamente menziona nella Costituzione anche la natura: “la protezione dell’ambiente, degli ecosistemi ,della biodiversità e delle generazioni future”. La visione unitaria dell’ambiente in senso spaziale e temporale è finalmente recepita.
- In materia di acque la giurisprudenza è vastissima. Si segnalano solo alcuni temi più trattati: nozione di scarico; regime del campionamento; regime delle analisi; necessità di autorizzazione espressa e specifica; nozione di insediamento produttivo; nozione di insediamento civile; scarichi assimilabili a quelli civili; scarichi in fognatura; fanghi di depurazione; allevamenti zootecnici; fertirrigazione; scarichi in mare; concetto di responsabilità; possibilità o meno di delega; sanzioni penali e sanzioni amministrative; ruolo dello Stato e delle Regioni; ecc.
- In materia di alimenti i temi più trattati sono stati: cibi scaduti o mal conservati; analisi di revisione; locali di vendita e consumo; sofisticazioni alimentari; ecc.
- In materia di tutela degli animali si ricorda una sentenza importante che considera l’animale come “autonomo essere vivente capace di soffrire” (Cass., sez. III, 27 aprile 1990, n. 691, Fenati).
- In tema di inquinamento atmosferico sono stati trattati soprattutto i seguenti punti: nozione di inquinamento atmosferico; nozione di impianto; emissioni e limiti di accettabilità; autorizzazione preventiva; localizzazione; centrali per la produzione di energia; cementifici; inceneritori; impianti industriali; impianti termici civili; allevamenti; adozione delle migliori tecnologie; competenze comunali, regionali e dello Stato; responsabilità penale e tipi di sanzioni; ecc.
- In tema di protezione della natura si segnalano le decisioni sulla nozione del bosco, sul vincolo per scopi idrogeologici, sul taglio di piante, sugli incendi, sulla caccia con mezzi illegittimi, sulla protezione delle zone umide, sulla protezione dei parchi nazionali e regionali, sulla protezione dei parchi marini, sui poteri e la legittimazione degli enti-parco, sul divieto di sorvolo di veicoli non autorizzati in aree protette, sulla protezione delle aree comprese in Natura 2000, ecc.
- In materia di energia molte decisioni riguardano la localizzazione degli impianti anche da fonti rinnovabili, la produzione di energia elettrica da biomasse, la produzione di energia elettrica da biogas, i parchi eolici comunali, la produzione ed installazione dell’energia eolica, gli impianti fotovoltaici in agricoltura, le grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, gli impianti di cogenerazione, l’utilizzo di coke da petrolio come combustibile, ecc.
- In materia edilizia ed urbanistica la giurisprudenza ordinaria ed amministrativa ha sviluppato un corpo di principi ormai consolidati su una serie di punti qualificanti: concetto di costruzione; concetto di pertinenza; concetto di opere interne; concetto di manutenzione ordinaria; concetto di manutenzione straordinaria; concetto di ristrutturazione; concetto di mutamento di destinazione; concetto di difformità totale e parziale; ruolo del certificato di abitabilità; ruolo degli standard edilizi ed urbanistici; ruolo dei vincoli di varia natura, paesaggistici, storico-artistici, sismici; scavi e spianamenti di terreno; prefabbricati; utilizzo illegittimo del demanio marittimo e delle coste; responsabilità e sanzioni penali e amministrative; demolizione; confisca e sua natura giuridica; proporzionalità della confisca rispetto al sacrificio eccessivo del diritto di proprietà (vedi caso Perotti e decisione Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sez. II, 20 gennaio 2009, Ric. n. 75909/2001, Sud Fondi S.r.l. contro Rep. Italiana); regime delle sanatorie e dei condoni ed impatto sulla giurisprudenza; opere pubbliche; ecc.
Non è possibile in questa sede- dedicata solo alle linee generali- dare conto in dettaglio della giurisprudenza in questa vastissima materia, ma è chiaro che il territorio nel suo insieme gioca un ruolo decisivo nel rapporto casa ,ambiente, qualità della vita.
3.1. Il ruolo della giurisprudenza costituzionale italiana
La giurisprudenza costituzionale italiana si è occupata di ambiente in maniera molto significativa negli ultimi 25 anni (soprattutto dopo l’istituzione del Ministero dell’ambiente nel 1986).
3.1.1. I due filoni principali
In via generale due filoni nella giurisprudenza costituzionale ruotano attorno ai rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali e concezione dell’ambiente.
Nei rapporti Stato-Regioni (considerando non solo l’impianto originario della Costituzione - soprattutto artt. 9 e 32 - ma anche la revisione nel 2001 del Titolo V della Parte II), la Consulta ha cercato di conciliare le esigenze di tutela unitaria dell’ambiente di competenza “esclusiva” dello Stato, con quelle concorrenti o proprie delle Regioni .
La Corte ha cercato di evitare una visione centralistica dell’ambiente, enunciando la dottrina della “materia trasversale”, rispetto alla quale il ruolo delle Regioni sembra meglio garantito (sentenze n. 407/2002; n. 182/2006; n. 62/2008).
In questa logica sono stati emanati i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà ed il riparto delle competenze Stato-Regioni è stato concepito in termini di integrazione e coordinamento più che di rigida competenza per materia e separazione di funzioni.
3.1.2. Osservazioni
-Va certamente salutato con favore lo sforzo compiuto dalla Corte Costituzionale in tema di ambiente, ma a nostro avviso, questo sforzo di chiarificazione va ulteriormente approfondito, introducendo il modello di governante ambientale , che postula come soggetti protagonisti non solo le istituzioni (Stato, Regioni, enti locali), ma anche il mondo economico e la società civile.
Che allo Stato spetti la “conservazione” dell’ambiente, mentre la “fruizione” spetterebbe alle Regioni, non sembra convincente, poiché il vero problema è assicurare lo sviluppo umano integrale sostenibile, con un dovere di gestione responsabile (che è anche conservazione) di tutti i soggetti pubblici, economici e sociali.
In sede internazionale e nell’Unione Europea si cerca di assicurare un alto grado di protezione ambientale, garantendo il livello di governo più funzionale al bilanciamento degli interessi pubblici, secondo il principio di sussidiarietà ed in coerenza con le esigenze anche locali dei cittadini (la vicinanza delle popolazioni interessate).
In Italia l’esperienza della creazione di parchi nazionali e parchi regionali, non in conflitto tra loro, è nata dopo una fase “ideologica” di competenze solo regionali nella materia.
Allo stesso modo sembra saggio procedere nel segno della distinzione e collaborazione per tutti i settori ambientali.
-La giurisprudenza costituzionale sul bene protetto (sentenza n. 151/1986) e sulla legittimità della c.d. legge Galasso n. 431/1985 ) configura il paesaggiocome “valore primario”.
-La concezione unitaria di ambiente
Nella sentenza costituzionale n. 210 del 1987 l’ ambiente è considerato “interesse fondamentale dellacollettività ” e si accoglie la concezione unitaria.
Nello stesso anno, la sentenza n. 641\1987 ribadisce la natura di “bene unitario ” dell’ambiente ed il suo significato di “bene di valore primario e assoluto”.
La concezione unitaria di ambiente è ripresa nelle sentenze costituzionali successive (n. 195/1990; n. 356/1994; n. 407/2002 e più recentemente nella sentenza n. 225/2009).
La Corte chiarisce opportunamente che l’ambiente non è un bene immateriale (cioè non è un concetto astratto), ma un bene “materiale” sul territorio, cioè l’insieme dei beni materiali, l’ecosistema (e la stessa biosfera, sentenze n. 367/2007 e n. 225 /2009).
-Giustamente la Corte osserva che lo Stato non deve assicurare solo il limite minimo di tutela uniforme (logica comprensibile per l’inquinamento), ma il più alto livello di protezione ambientale delle risorse comuni (come impongono le norme comunitarie ed alcuni obblighi internazionali). La difficoltà nasce quando si introduce una concezione ambientale più moderna ed ampia in termini di governance. Economia e società civile diventano decisive, superando la visione tradizionale di “command and control”, tipica del ruolo solo delle istituzioni pubbliche.
Lo sviluppo “sostenibile”, se è serio, coinvolge l’economia nella sua struttura e funzionamento reale e non può prescindere dal ruolo delle persone e delle formazioni sociali.
Dire che “l’interesse ambientale non è protetto come diritto soggettivo, bensì come interesse legittimo” (sentenza. n. 225/2009), significa legare l’interesse protetto dell’individuo all’interesse pubblico (come rappresentato dallo Stato, con competenza esclusiva), sì da farlo coincidere con esso.
-Ma vi è una prospettiva più ampia e non incompatibile con questa: quella dell’ambiente quale diritto umano fondamentale, già presente in qualche decisione della Corte costituzionale (sentenza. n. 151/1986).
La nostra Costituzione all’art. 2 introduce la concezione del “riconoscimento” dei diritti fondamentali dando ad essi una “autonomia” nel sistema.
Il diritto umano all’ambiente nelle sue componenti procedimentali (informazione, partecipazione e accesso) è già riconosciuto ai vari livelli (internazionale, comunitario e nazionale) ed è qualcosa di più di un interesse legittimo. Questo diritto umano va attuato, perchè l’ambiente non vive senza la responsabilità e partecipazione di ogni persona.
-Lo stesso diritto ha certamente un contenuto minimo “sostanziale ” di fruizione dell’ambiente (in termini di salute, cibo, acqua…): questo diritto dell’individuo non impedisce in via di principio di agire anche per la protezione dell’ambiente nell’interesse generale, sia pure con opportuni filtri.
3.1.3. Altre sentenze significative della Corte Costituzionale
a) Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA)
La sentenza n. 234/2009 esclude dalla necessità della VIA le opere destinate alla protezione civile, in nome della competenza esclusiva dello Stato.
b) Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
La sentenza n. 225/2009 ha stabilito che la competenza statale non è limitata alla fissazione di standard minimi di tutela ambientale.
c) Tutela del paesaggio
Le sentenze su questo tema sono numerose e coerenti nell’affermare la competenza primaria dello Stato, anzi della Repubblica (sentenze n. 921 / 1988; n. 118/1990; n. 391/1989; n. 151/1986; n. 94/1985; n. 67/1992; n. 334/1998; n. 388/1992; n. 277/1993).
d) Piani paesistici regionali
La Corte ha ritenuto che la protezione preordinata dalla legge n. 431/1985 non esclude normative regionali di maggiore o pari efficacia, attraverso i piani paesistici regionali aventi una duplice valenza urbanistico-ambientale (sentenze n. 529/1995; n. 378/2000).
e) Tutela delle acque
In materia di tutela delle acque dall’inquinamento lo Stato può intervenire con norme di protezione sostanziale e non solo con norme di principio, ferma rimanendo la potestà regionale di adottare misure più rigorose (sentenza. n. 233/2009).
La materia della pesca è di competenza legislativa residuale delle Regioni (sentenza. n. 81/2007).
L’individuazione delle aree sensibili è di competenza statale, salvo la facoltà delle Regioni di individuarne “altre” in aggiunta (sentenza. n. 251/2009).
La tutela “quantitativa” della risorsa idrica e della sua pianificazione rientra nella competenza esclusiva dello Stato, sia pure con un’adeguata partecipazione della Regione (sentenza n. 251/2009). Le norme del d.lgs. n. 152 del 2006 in tema di acque sono state ritenute di competenza statale (sentenza. n. 254/2009) con relativa infondatezza delle questioni sollevate dalle Regioni.
f) Difesa del suolo
Le Regioni dovranno essere direttamente coinvolte, tramite la conferenza unificata, nella definizione del programma nazionale di intervento per la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo (sentenza. n. 232 /2009). Si applica il principio di leale collaborazione.
g) Bonifica delle aree agricole
La bonifica ed il ripristino ambientale delle aree destinate alla produzione agricola e zootecnica, coinvolgendo anche l’agricoltura, rientra nelle competenze e dello Stato e delle Regioni (sentenza. n. 247/2009).
h) Gestione dei rifiuti
I Consorzi nazionali per i rifiuti e gli imballaggi sono di competenza statale, come pure la classificazione dei rifiuti e le tariffe sui rifiuti (sentenza. n. 247/2009; n. 61 /2009).
La competenza regionale sulla materia non va esclusa, anzi lo Stato non ha potere sostitutivo in caso di inerzia degli enti locali nella gestione dei piani regionali (sent. n. 249/2009) in omaggio al principio di sussidiarietà.
i) Tutela dell’aria
La Corte riconosce sia la competenza dello Stato per l’ambiente, sia la competenza regionale sulla salute, sicché concorrono queste istituzioni con lo strumento dell’intesa (sent. n. 250/2009).
l) Campi elettromagnetici
La competenza regionale è fuori discussione, ma può stabilire solo limiti più severi di quelli fissati dallo Stato (sentenza. n. 382/1999).
m) Protezione della natura
Per latutela della selvatica faunaun nucleo minimo di salvaguardia è stabilito dallo Stato, in ottemperanza agli obblighi internazionali, rimanendo la competenza regionale per le modalità della caccia (sentenze. n. 168/1999; n. 323/1998; n. 536/2002).
Sugli incendi boschivi si richiama la sentenza n. 157/1995 e sui boschi le sentenze n. 14/1996 e n. 391/1989.
n) Protezione dei beni culturali
È fuori dubbio la competenza esclusiva dello Stato in tema di restauro dei beni culturali (sentenza. n. 277/1993) ed è legittimo il divieto eventuale, da parte dei Comuni, dell’attività commerciale nei centri storici (sentenza. n. 388/1992).
o) Salvaguardia di Venezia e della sua laguna
È stato dichiarato “problema di preminente interesse nazionale” (sentenza. n. 357/1998).
p) Danno ambientale
La Corte aveva già dichiarato che la competenza in tema di danno ambientale spetta al giudice ordinario e non alla Corte dei Conti (sentenza citata. n. 151/1986).
Più recentemente con la sentenza n. 235/2009 ha ritenuto legittime le norme sul danno ambientale contenute nel c.d. Codice dell’ambiente.
Questa disciplina, tuttavia, desta qualche perplessità in ordine al ruolo delle Regioni ed a quello del limitato accesso sociale alla giustizia.
3.2. Il ruolo della giurisprudenza ordinaria penale
Iniziamo con un cenno ai nuovi delitti introdotti a seguito della Direttiva europea Eco-crime del 2008 .
-Sul delitto di inquinamento ambientale ( art.452-bis C.P.) la Corte Suprema di Cassazione, terza Sezione penale, è già intervenuta con varie decisioni:
n.46170 del 21-9-2016; n.45865 del 31-1-2017; n.50018 del12-9-2018; n.28732 del 27-4-2019; n.322498 del 5-9-2022; n.17400 del 24-1-2023…
La Corte ha chiarito alcuni punti :
che si tratta di reato di danno e non di pericolo;
che il danno va inteso come compromissione o deterioramento significativo e misurabile delle componenti ambientali “aria, acque, suolo o sottosuolo”; di un “ecosistema”; della” biodiversità (anche agraria: un accenno molto significativo)”,”della flora e della fauna”;
-chela condottanon è indeterminata ,ma è sufficientemente definita, nel senso di un riferimento ad uno squilibrio funzionale o strutturale della natura conseguente alla condotta illecita.
La recente riforma costituzionale in tema di ambiente del 2022 rende più certo il riferimento al danno ambientale ed alle sue componenti, avendo recepito una visione unitaria ed allargata di ambiente, come valore di rilevanza costituzionale.
-Sul delitto di disastro ambientale ( art. 452-quater C.P.) la Corte Suprema di Cassazione penale, Sezione III, con decisione del 3 novembre 2016 n.16170, individuava nella alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema la caratteristica distintiva rispetto al delitto di inquinamento ambientale. La successiva sentenza della Cassazione penale Sezione III, del 31 ottobre 2019, n.44528, precisava che per configurare il delitto non è necessario un macroevento dirompente di portata distruttiva, potendo configurarsi il delitto anche nell’ipotesi di un disastro ambientale per accumulo o mediante immissioni a dinamica progressiva e seriale.
Più recentemente il Tribunale di Pisa (in Lex -ambiente n.4\2022) ravvisava il delitto di disastro ambientale in un incendio boschivo doloso di vaste proporzioni.
-Sul delitto di traffico o abbandono di materiali ad alta radioattività ( art. 452 sexies C.P.) in Italia, a distanza di 10 anni, non risultano decisioni giudiziarie sulla reale applicazione. Risultano soltanto alcuni procedimenti avviati ma ancora senza esito noto. Sono emerse difficoltà interpretative in una materia molto tecnica, come segnalato in una nota dell’Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione fin da 2015. Le difficoltà interpretative possono essere superate se il legislatore italiano tiene conto della sopravvenuta Direttiva n.2024\1203 che nella lista dei delitti inserisce al punto l dell’articolo 3, il seguente testo: “la fabbricazione, la produzione, la lavorazione, la manipolazione, l’impiego , la detenzione, lo stoccaggio, il trasporto, l’importazione, l’esportazione o lo smaltimento di materiale radioattivo o di sostanze radioattive, se tali condotte e tale materiale o tali sostanze, rientrano nell’ambito di applicazione delle direttive 2013\59 Euratom, 2014\87\Euratom o 2013\51 Euratom e se tali condotte provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone e danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna e alla flora”. La Direttiva nuova sostituisce le direttive 2008\99\Ce e 2009\123\CE e cita le radiazioni ionizzanti nelle condotte illecite dei primi delitti della lista (a e b).
-Sul delitto di impedimento del controllo ( art.452-septies C.P.), la Corte di Cassazione si è pronunciata con sentenza del 15 novembre 2023 n.11166, in relazione ad un caso in cui il proprietario di una azienda agricola impediva l’accesso alla zona da sottoporre a controllo, impedendo di fatto le attività istituzionali di verifica in loco.
La Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità penale con riferimento all’art. 452 septies codice penale e quindi il delitto di impedimento del controllo.
In via di principio la Corte ha esaminato la norma sopraindicata distinguendo una prima ed una seconda parte:
nella prima la condotta illecita è riferita a chiunque “ impedisca, intralci, eluda l’attività di vigilanza e controllo ambientale, con una condotta tipizzata consistente nella negazione dell’accesso, in ostacoli, nella immutazione artificiosa dello stato dei luoghi ”;
nella seconda la norma include qualsiasi altra condotta dotata di efficacia causale che comprometta gli esiti dell’attività di vigilanza (una clausola di chiusura aperta).
-Sul delitto di omessa bonificava precisato che esso è stato recepito nel sistema italiano con il reato ex articolo 452 terdecies codice penale. La sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione penale III del 7 agosto 2024, n.32117, ha stabilito che esso costituisce un reato omissivo proprio, nel senso che ne risponde solo il soggetto sul quale ricade l’obbligo di provvedere alla bonifica in forza della legge, di un provvedimento del giudice o di un atto della Pubblica amministrazione. Nel caso in esame, il reato contestato era la contravvenzione ad una ordinanza del Sindaco che imponeva la rimozione dei rifiuti per una condotta non potenzialmente inquinante, mentre era emerso che il sito era inquinato e s’imponeva una vera bonifica. La Corte Suprema di Cassazione ha corretto la motivazione ed ordinato un riesame del caso con applicazione della direttiva comunitaria e del delitto specifico più grave ex art.452 terdecies codice penale.
3.2.1. Le principali linee evolutive della giurisprudenza
a) Una prima linea evolutiva riguarda il concetto di responsabilità per colpa , intesa non solo in modo tradizionale (mancanza di diligenza, imperizia, imprudenza), ma nel senso più moderno e funzionale (mancata adozione di tutte le misure tecniche, strutturali, economiche, organizzative idonee ad evitare l’evento dell’inquinamento).
Sono state, perciò, considerate di regola come non influenti una serie di cause di pretesa non punibilità: stato di necessità; forza maggiore; inesigibilità tecnica; inesigibilità economica; inesigibilità sociale .
In sostanza la giurisprudenza non ha dato importanza a fenomeni del tutto prevedibili (piogge abbondanti; neve e freddo eccessivi; guasti tecnici; eccessività dei costi; proteste sindacali; deleghe di mansioni non documentate all’interno delle strutture produttive).
Si è costruita giustamente una giurisprudenza rigida da conservare : la responsabilità rimane soggettiva, ma il suo contenuto si avvicina ad una responsabilità oggettiva.
b) Una seconda linea evolutiva riguarda il concetto di ambiente in senso oggettivo , riferito ad ogni bene della natura.
Tutto è ambiente in senso giuridico in una visione unitaria di tutti gli ecosistemi e della biodiversità con un ruolo di custodia e doverosità dell’uomo.
c) Una terza linea evolutiva, sempre unitaria, riguarda il concetto di ambiente in senso soggettivo, nel senso del riconoscimento di un diritto-dovere fondamentale di ogni persona all’ informazione ambientale, alla partecipazione ai procedimenti amministrativi ed infine all’accesso alla giustizia(come persone e formazioni sociali). Gli aspetti procedurali o procedimenti del diritto umano all’ambiente sono riconosciuti dalla giurisprudenza. Resta ancora aperto il problema di assicurare, su base universale, un contenuto minimo sostanziale del diritto umano all’ambiente dell’individuo : i cosiddetti Basic Needs ( diritto di respirare ,di bere acqua, diritto al cibo, diritto all’abitazione, diritto alla salute, diritto alla cultura).
d) È prevalsa in conclusione, alla fine di una lunga evoluzione, una nozione unitaria di ambiente, sia nella giurisprudenza costituzionale (sentenze n.151\1986;n. 64/1987; n. 210/1987; n. 195/1990; n. 356/1994; n. 407/2002), sia nella giurisprudenza ordinaria della Corte Suprema di Cassazione (sentenza n. 421/1983; n. 1267/1996) salvo alcuni principi specifici. La Corte Suprema di Cassazione ha svolto un ruolo anticipatore.
Logicamente complementare è risultata la nozione unitaria di danno ambientale (danno pubblico; danno sociale; danno personale).
e) Nei delicati rapporti tra competenze dello Stato e competenze delle Regioni e di altri enti locali (Province e Comuni), la Corte Costituzionale ha affermato il principio della leale collaborazione con varie importanti sentenze come già detto in precedenza.
f) È cresciuta l’influenza del diritto comunitario dell’ambiente in Italia, non solo nel settore dell’inquinamento ma anche per i profili autorizzatori e procedimentali e per la tutela positiva delle risorse. Questa influenza non riguarda solo i principi civilistici della responsabilità per danno ambientale ( Direttiva 2004\35\EC ),ma più recentemente anche quelli penalistici (Direttiva Eco-Crime 99\2008\CE resa esecutiva in Italia con legge n.68\2015, che ha introdotto cinque delitti su cui si è creata una prima giurisprudenza: inquinamento ambientale; disastro ambientale ;traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività; impedimento del controllo; omessa bonifica. Più recentemente è intervenuta la nuova Direttiva n.2024\1203 in corso di attuazione.
3.2.2. Singoli settori: considerazioni operative
Dei singoli settori ambientali non è possibile dare un quadro completo di sintesi ,ma solo indicare alcune linee di evoluzione ,anche operative.
- Una prima osservazione generale: il quadro internazionale di riferimento in tema di clima e di biodiversità ha subito una influenza non positiva a causa dei conflitti in Ucraina e in Palestina.
Non una vera regressione, ma segnali di grave incertezza, come il ritiro degli USA dall’Accordo di Parigi del 2015. La visione universalistica, che è propria del diritto internazionale, sembra si sia attenuata anche a seguito della guerra globale sui dazi.
- Mentre si cerca un equilibrio a livello internazionale tra grandi Paesi come USA, Cina, Russia, l’Europa cerca un proprio ruolo di responsabilità, collaborazione e solidarietà in un mondo di pace rispettoso del diritto e dei valori umani profondi della sua eredità storica.
-Il diritto comunitario in tema di ambiente costituisce un patrimonio certo e positivo da conservare . E, se possibile, sviluppare ulteriormente.
-Sulla situazione italiana, onde assicurare una maggiore effettività del diritto ambientale, si possono richiamare alcune considerazioni pratiche: che riguardano non solo i giudici ,ma anche i collaboratori e gli organi della Pubblica Amministrazione:
• la polizia giudiziaria fornisce agli uffici del Pubblico Ministero le notizie di reato che riguardano l’ambiente. La giurisprudenza ha ritenuto che esiste una competenza generale di tutti i corpi di polizia per quanto riguarda il controllo delle violazioni e le eventuali sanzioni (Corte Suprema di Cassazione, sezione III penale, 1872/91, Dalmazzo). I Carabinieri si trovano in tutti i Comuni ed hanno anche un Nucleo ecologico nazionale (NOE) e Nuclei ecologici regionali. Il Corpo Forestale dello Stato si trova in sede nazionale e nelle Regioni (e poi nelle Province e nei Comuni). Un ruolo più limitato spetta a Polizia di Stato, Polizia dei Comuni, Guardia di Finanza. L’Agenzia Nazionale di Protezione dell’Ambiente (ANPA, ora ISPRA ) ha anche un’organizzazione su base regionale. Per il mare e le spiagge vi è la competenza della Capitaneria di Porto e della Guardia Costiera.
°.nel 1994 il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, tramite il suo Nucleo Ecologico, in collaborazione con il Gruppo di Lavoro “Ecologia e Territorio” della Corte Suprema di Cassazione, realizzava una specifica pubblicazione sulla Giurisprudenza ambientale in due volumi. La Ricerca è molto dettagliata ed interessante, perché raccoglie in modo sistematico le decisioni della Corte Costituzionale, della Corte Suprema di Cassazione, dei Giudici di merito, del Consiglio di Stato, dei TAR, della Corte dei Conti in relazione ai seguenti grandi Settori: Costituzione della Repubblica; Acque ;Animali; Aria ;Associazioni di protezione dell’ambiente; Boschi e foreste; Caccia ;Cave; Diritto all’ambiente ( diritto all’informazione); Diritto all’ambiente ( diritto alla partecipazione); Diritto all’ambiente ( diritto di azione); Danno ambientale; Edilizia e Urbanistica; Energia; Flora; Lavoro ( ambiente di); Ministero dell’ambiente; Paesaggio ;Parchi, riserve naturali, zone umide; Pesca; Rifiuti; Rumore; Valutazione di impatto ambientale; Sostanze e produzioni pericolose; Salute; Suolo ( difesa del ). La pubblicazione è arricchita di note introduttive molto precise. Essa fa onore all’Arma dei Carabinieri ed al suo impegno istituzionale. Potrebbe essere aggiornata, in collaborazione con tutti gli Organi di controllo delle Istituzioni centrali, regionali e locali.
• l’attività di campionamento(in materia di inquinamento delle acque e dei rifiuti ed in materia di inquinamento atmosferico e acustico) è considerata dalla giurisprudenza come attività amministrativa (Corte Suprema di Cassazione, sezione III penale, 1582/91, Sabato).
• le analisi dei campioni sono eseguite da organismi tecnici (laboratori provinciali di igiene e profilassi) e devono essere precedute da un avviso agli interessati, a pena di nullità (Corte Suprema di Cassazione, sezione III penale, 332/91, Brusco).
•ilP.M. è libero nell’esercizio dell’azione penale, ma il concreto esercizio deriva dalla sua sensibilità personale e formazione, dall’organizzazione del suo ufficio e dalla collaborazione delle forze di polizia.
• si sono rivelati molto efficaci lemisure preventive: in sede penale i sequestri probatori ed i sequestri preventivi; in sede civile leazioni inibitorie; in sede amministrativa le sospensioni di atti della P.A.
•più difficile in pratica è stato realizzare la effettività in sede successiva: le demolizioni di costruzioni abusive (Corte Suprema di Cassazione, sezioni unite, n. 15 del 19 giugno 1996, Monterisi); il ripristino della situazione dei luoghi (Corte Suprema di Cassazione, sezione III penale, 862/96, Pezzetta); la valutazione economica del danno ambientale (Tribunale Venezia, 27 novembre 2002, n. 1286).
• le autorità locali si sono organizzate con appositi uffici per il controllo e la gestione dell’ambiente ed è migliorata la collaborazione con la magistratura. I Sindaci dei Comuni trovano ancora “difficile” far demolire tempestivamente gli edifici abusivi , perché ragioni politiche sconsigliano prassi troppo severe . Più efficace risulta invece la protezione del paesaggio, dei parchi, dei beni culturali, perché le norme giuridiche sono più stabili e la sensibilità della magistratura è maggiore.
•la nozione di rifiuto presenta ancora un margine di incertezza. Si ritiene da alcuni che l’orientamento della Corte di Giustizia delle Comunità Europee sia poco realistico, considerando tutto rifiuto, senza una linea chiara e attuabile di recupero e riutilizzo, economicamente praticabile . 3 La conseguenza è che i Sindaci abusano del potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti (Corte di Cassazione, sezione III penale, 13 ottobre 1995, n. 11336, Ranieri); in vaste aree del Sud vige ancora un regime emergenziale che fa capo ai Prefetti ed ai Commissari regionali, di dubbia legittimità rispetto al diritto comunitario; il traffico dei rifiuti va verso le aree meno controllate dalla P.A. e dalla società civile.
• le formazioni sociali e le persone sono state incoraggiate dalla giurisprudenza con molte decisioni favorevoli all’esercizio del diritto di informazione, partecipazione e accesso. Questo è forse il merito maggiore della evoluzione giurisprudenziale. 4
• le azioni di danno ambientale in sede civile sono ancora limitate, ma cresce la sensibilità ed il ruolo dell’Avvocatura Generale dello Stato e delle Avvocature di Regioni, Province e Comuni.
•lavalutazione in concreto del danno ambientale segue di regola criteri equitativi, senza una base scientifica ed economica adeguata per carenza di formazione: ma al riguardo è intervenuta la direttiva comunitaria 2004/35/EC che prevede il ripristino originario dello stato dei luoghi come prima opzione e solo in via residuale il risarcimento monetario dettando specifici criteri di valutazione del danno alle risorse e del danno cagionato ai servizi naturali preesistenti, sicché si può operare con maggiore certezza.
• esistono in Italia circa 10.000 siti inquinati ed è problematico il loro recupero. Per il futuro è stata introdotta una specifica ipotesi di delitto (omessa bonifica).
• i giudici italiani, in base alla Costituzione, possono applicare i principi di diritto internazionalegeneralmente riconosciuti, ma non le Convenzioni non ratificate dal Parlamento. Non risultano casi di applicazione diretta di principi e norme di diritto internazionale dell’ambiente, sicché sarebbe utile una attenzione su questo aspetto.
• i giudici italiani hanno sollevato alcune questioni pregiudiziali in materia di interpretazione del diritto comunitario (es. in tema di rifiuti) davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee. I casi sono ancora molto limitati. Vi sono sentenze di attuazione da parte dei giudici italiani delle direttive ritenute self sufficient, di immediata applicazione.
• per ulteriori aspetti del diritto italiano e della giurisprudenza in tema di ambiente ,( una buona base di informazione è datata al 2002), si rinvia ad un contributo in tema di ambiente presentato su incarico della Corte Suprema di Cassazione italiana, in occasione del primo Simposio delle Corti di Giustizia nazionali dei vari Continenti ,promosso dall’UNEP in Sud Africa . 5 Seguì, dal 9 al 10 maggio 2003, un Seminario internazionale nel Consiglio Superiore della Magistratura in Roma, dal titolo ”The role of the judiciary in the implementation and enforcement of environment law”,presieduto dal Prof. Giovanni Conso, Presidente della Corte Costituzionale e Presidente Onorario ICEF,con la partecipazione di magistrati italiani e di numerosi altri Paesi di vari continenti e l’intervento di autorevoli personalità dell’UNEP, del Consiglio di Europa, di IUCN. Gli Atti sono stati pubblicati, a cura di Amedeo Postiglione e della Fondazione ICEF ,da Bruylant Editore, Bruxelles , nel 2008, con lo stesso titolo sopraindicato del Seminario.
3.2.3. I casi più interessanti
Si segnalano di seguito alcuni casi più interessanti affrontati dalla giurisprudenza ordinaria: in nota è esplicitata in modo essenziale la vicenda di ciascuno di essi.
1. Caso inquinamento atmosferico stabilimento Enichem di Marghera. 6
2. Disastro del Vajont. 7
3. Naufragio della petroliera Haven nell’alto Tirreno. 8
4. Vicenda dei Fanghi rossi di Scarlino, scaricati dalla Società Montedison in mare al largo della Corsica. 9
5. Salvaguardia di Venezia. 10
6. Ossido di etilene ed iniziative della magistratura torinese. 11
7. Formaldeide e iniziativa della magistratura torinese. 12
8. I TLV delle sostanze chimiche. 13
9. Scarichi in mare di rifiuti tossici (biossido di titanio). 14
10. Centri di Raccolta e deposito di veicoli fuori uso. 15
11. Porto Marghera (Venezia). 16
12. Genova. 17
13. Affondamento mercantile greco Klearchos in Sardegna. 18
14. Affondamento della nave Cavtat al largo di Otranto. 19
15. AUGUSTA (Sicilia) 20
16. GELA (Sicilia) 21
17. Scarico di sostanze tossiche nelle isole Tremiti. 22
18. Seveso. 23
Qualche caso di giurisprudenza in materia di VIA
La giurisprudenza ordinaria settoriale è molto vasta ed in continua evoluzione.
A titolo esemplificativo si indicano alcune decisioni ritenute più significative in materia di rifiuti.
a) Impianto di incenerimento nel Comune di Modena (termovalorizzatore). 24
b) Impianto di smaltimento recupero rifiuti. 25
c) Rigassificatore GNL di Brindisi. 26
d) Discarica. 27
e) Impianto di produzione di energia di potenza superiore a 300 MW termici. 28
f) Autorizzazione unica di competenza statale (e non regionale) per centrali di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici ed anche per le opere connesse come immersioni di materiale di scavo in mare. 29
g) Installazione di una stazione radiobase ed inquinamento elettromagnetico. 30
h) Operazione di drenaggio (estrazione di minerali e recupero di terra dal mare). 31
i) Centrale eolica. 32
j) Impianto chimico integrato. 33
Casi di giurisprudenza sul mare
Non si conosce in modo approfondito la giurisprudenza sul “mare”, sia perché ne esiste “poca”, sia perché è “dispersa”, nel senso che le riviste giuridiche e le banche dati della Corte Suprema di Cassazione recepiscono solo alcuni casi.
Non è, dunque, possibile enucleare le linee di tendenza, secondo criteri temporali e contenuti coerenti con pochi principi di base.
La “limitata” giurisprudenza è anche conseguenza di una carenza nei controlli e nella vigilanza: vi è certamente qualcosa che non funziona nei meccanismi di controllo, se la loro efficacia non ha riscontri adeguati nella giurisprudenza.
Nel sistema italiano si è posto un problema di coordinamento fra diritto interno e diritto internazionale, come nel caso della Convenzione MARPOL che è stata resa esecutiva in Italia con legge n. 662/2080, entrata in vigore nel 1983.
E’ prevalso l’orientamento della Corte Suprema di Cassazione (sez. un. penali del 24 febbraio 1998) della prevalenza del regime più mite introdotto dalla Convenzione Marpol rispetto alle sanzioni penali della legge nazionale precedente. Si tratta di una soluzione controversa, che sembra non condivisibile, posto che il diritto internazionale riconosce a ciascun Paese il diritto di introdurre un regime più rigoroso.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 14 luglio 1994, ha riconosciuto agli Stati membri il diritto di vietare lo scarico di sostanze nocive nel mare territoriale da parte delle navi, senza distinzione di bandiera della nave.
Sembra dunque urgente riconsiderare la questione da parte dell’Italia per assicurare un quadro più aggiornato e rigoroso nel rapporto fra diritto interno e diritto comunitario ed internazionale.
II- Parte seconda: le garanzie unitarie per l’effettività
1- La Corte penale internazionale
La base legale di questa Istituzione risale al 1998,anno in cui fu discusso e adottato in Roma lo Statuto. La competenza è limitata per ora ai crimini di guerra, crimini contro l’umanità. aggressione e genocidio . Vi è la possibilità di estendere la competenza anche ai crimini ambientali di rilevanza internazionale con una decisione dei Governi a maggioranza dei due terzi, ma finora questa auspicabile finalità non si è realizzata. Con riferimento all’invasione dell’Ucraina, la Procura presso la Corte de L’Aia il 28 -2-2022 avviava una indagine preliminare per crimini di guerra e crimini contro l’umanità.
Successivamente il 17-3-2023 emetteva un mandato di arresto contro Vladimir Putin e Maria Lvovo-Belova, Commissaria governativa per i bambini, con l’accusa del trasferimento illegittimo in Russia di un gran numero di bambini ed adolescenti .La Federazione russa ha reagito deducendo di essersi ritirata dallo Statuto di Roma, sottoscritto da 123 Stati e nel merito l’infondatezza dell’accusa, perché il trasferimento era avvenuto per una protezione umanitaria a causa del conflitto in corso. Va precisato che la Corte penale internazionale non può procedere in contumacia contro le persone fisiche incriminate ed appare difficile l’arresto dei responsabili o la loro estradizione, salva l’ipotesi di consegna ( è un obbligo giuridico) ad opera di Governi firmatari dello Statuto ove gli indiziati si trovino sul loro territorio come avvenuto per Milosevic, ex Jugoslavia; Omar Bashir ,Sudan e Muammar Gheddafi , Libia.
2-La Corte internazionale di giustizia
Questa istituzione di garanzia opera a L’Aia, quale organo delle Nazioni Unite, universalmente accettato, con competenza generale di risoluzione pacifica dei conflitti tra Stati secondo il diritto internazionale. L’accesso è riservato solo agli Stati. Come già osservato nella prima parte del presente contributo, la Corte si è occupata di vari casi interessanti-direttamente o indirettamente- anche la protezione dell’ambiente ( casi indicati nella nota, con decisioni e pareri di notevole importanza). I recenti conflitti in Ucraina e Palestina ed i nuovi equilibri geopolitici globali hanno evidenziato un punto importante: il legame tra sicurezza-pace e tutela dell’ambiente comune. Si tratta di due valori umani fondamentali interconnessi ( sicurezza - pace e ambiente) , che hanno bisogno di una giurisdizione internazionale di garanzia, indipendente ed obbligatoria. , secondo una visione universalistica del diritto internazionale. Se la sicurezza ambientale globale fosse davvero percepita come interesse prioritario comune, diventerebbe possibile un adeguamento del modello delle Nazioni Unite, con l’eliminazione del diritto di veto e regole condivise nuove per la più grande e necessaria Organizzazione della Comunità internazionale. Anche la giustizia internazionale per l’ambiente potrebbe giovarsi di nuove regole di collaborazione ( accesso; effettività ed obbligatorietà delle decisioni almeno nei casi più gravi). E’ divenuto chiaro che l’ambiente può svolgere un ruolo positivo anche in un quadro geopolitico nuovo. Nel caso della invasione della Federazione russa del 22-2-2022,l’Ucraina proponeva subito ricorso alla Corte internazionale di giustizia con l’accusa di aggressione e genocidio e la Corte intimava la sospensione immediata delle operazioni militari: l’Ordinanza non veniva eseguita per l’esercizio del diritto di veto della Federazione russa nel Consiglio di Sicurezza delle N.U. Si paralizzava in tal modo il giudizio e ora si è alla ricerca di una soluzione “politica” equilibrata comunque auspicabile.( V. “Le vie della pace”,2024, a cura del Forum Donne ICEF).
3-La tutela penale dell’ambiente nel diritto comunitario
Una prima Direttiva, detta Eco-crime, risale al 2008 ( Direttiva 99\ 2008\EU )
.Nel 2015 l’Italia dava completa attuazione all’atto normativo comunitario, introducendo con la legge n.68 , nel codice penale, cinque nuovi delitti: inquinamento ambientale; disastro ambientale; traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ; impedimento del controllo ; omessa bonifica.
Elemento comune delle fattispecie è costituito da una offesa all’ambiente più o meno grave, cagionata per dolo o colpa grave, da singole persone fisiche o anche da persone giuridiche.
Le sanzioni mirano in primo luogo al ripristino ambientale se possibile e comunque devono essere dissuasive.
A riprova dell’interesse della Unione Europea a favore del valore giuridico della natura e dell’ambiente, la tutela penale è stata allargata e rafforzata con la nuova Direttiva 2024\1203,alla quale va data esecuzione entro il 21 maggio 2026.
La nuova Direttiva assume una concezione unitaria ed ampia di ambiente e mira a tutelare con la forza di sanzioni efficaci ,proporzionate e dissuasive, la natura nei suoi habitat ed ecosistemi, stabilendo uno standard minimo per i 27 Paesi dell’Unione, salva la possibilità di una protezione più rigorosa da parte di essi.
4-Il contenzioso climatico
Come è noto nella Conferenza di Rio de Janeiro delle Nazioni Unite del 1992 gli Stati adottarono due nuove Convenzioni : una sul clima ed una sulla biodiversità.
Si tratta di due temi globali nuovi tra loro collegati, divenuti molto difficili da risolvere perché conseguenti alla rivoluzione industriale, alla crescita della popolazione umana, al modello energetico-economico e alle nuove tecnologie.
Il clima è stato giustamente definito come integrazione di atmosfera, geosfera, idrosfera e bi osfera: queste componenti fondamentali della natura continuano a registrare un aumento di temperatura terrestre e marina a causa delle quantità eccessive di CO2 emesse riconducibili con certezza all’attività umana.
L’altra Convenzione è importante perché la biodiversità terrestre e marina assorbe CO2 dall’atmosfera ed aiuta a contenere il fenomeno sopravvenuto del mutamento climatico a livello globale. Conservare e ripristinare gli ecosistemi è non solo la chiave per preservare la biodiversità ,ma anche per ottenere benefici sul fronte delle emissioni. Gli habitat e gli ecosistemi sono i maggiori pozzi di assorbimento del carbonio.
La prossima COP 30, che si terrà a Belem in Brasile dal 10 al 20 novembre 2025, deve non solo riguardare le emissioni ( difficili da contenere entro 1,5 gradi), ma anche i grandi polmoni verdi del Pianeta , le grandi foreste tuttora esistenti nei vari continenti ed ai poli.
Il contenzioso climatico va considerato unitariamente; è cresciuto in molti Paesi e continenti; costituisce una strada sicura in nome dei diritti e doveri umani.
Guardando un poco indietro si ricorda che le Nazioni Unite hanno svolto un ruolo di stimolo ed anticipazione culturale fin dalla Conferenza dei Governi sul clima di Johannesburg in Sud Africa ,18-20 agosto 20O2. Un distinto Simposio internazionale fu organizzato dall’UNEP per le Corti Supreme Nazionali dei vari continenti sul tema della protezione giuridica più efficace dell’ambiente comune. Questo evento-distinto da quello dei Governi- ebbe esito positivo e l’UNEP ritenne opportuno ripetere l’esperienza dopo pochi mesi con finalità anche operative: favorire la costituzione permanente di Forum continentali di giudici per l’ambiente ( Nairobi ( 30-31 gennaio 2003).
-Su iniziativa di IUCN e della Fondazione ICEF in Europa furono promossi due Simposi proprio per questa finalità : a Londra , 10-11 ottobre 2002 ; a Roma , 9-10 maggio 2003.
Un gruppo di giudici ( Advisory Board ), costituito da Guy Canivet, Francia; Robert Carnwath, Gran Bretagna; Luc Lavrysen ,Belgio; Amedeo Postiglione ,Italia ; Ulf Bjallas, Svezia avviò la costituzione operativa del Forum Europeo dei Giudici per l’Ambiente, anche formalmente con Atto notarile in Lussemburgo il 26 aprile 2004.
Il Forum europeo dei giudici per l’ambiente negli ultimi 20 anni ha dato un contributo positivo all’esame comparato della giurisprudenza ambientale e climatica ad opera di Conferenze di studio annuali nei diversi Paesi EU .
In questa sede si fa cenno ad alcuni eventi:
-quello presso il CSM in Roma del 9-19 maggio 2003,presieduto da Giovanni Conso, Presidente della Corte Costituzionale italiana : gli Atti dal titolo “ The role of the Judiciary in the implementation and enforcement of environment law” sono stati pubblicati a cura di Amedeo Postiglione, da Bruylant Editore ,Bruxelles, 2008;
-quello in Ostia Antica dal 26-28 maggio 2005 avente ad oggetto la nuova Direttiva EU sul danno ambientale con la partecipazione dei giudici di molti Paesi e della Commissione europea.
-Una specifica giurisprudenza sul clima segue l’Accordo di Parigi del 2015,perché a livello internazionale vengono precisati i principi e gli obblighi degli Stati per il contenimento delle emissioni ed i meccanismi di controllo.
Un ruolo rilevante di promozione è esercitato significativamente. al più alto livello dalle Corti costituzionali di alcuni Paesi europei come Olanda ,Germania e Francia che condannano i rispettivi Governi nazionali per inadempimento agli obblighi assunti con l’Accordo di Parigi del 2015.
In Italia il Tribunale civile di Roma ,Sezione 2,con sentenza del 26 febbraio 2024, dichiarava invece il difetto di giurisdizione per inammissibilità delle domande di singole persone ed associazioni contro lo Stato italiano in violazione del principio della divisione dei poteri. In attesa degli sviluppi successivi di questo procedimento, si segnalano alcuni contributi :
-il Rapporto italiano su “Diritto e contenzioso climatico in Italia” presentato nella Conferenza del Forum europeo giudici per l’ambiente, a Parigi presso il Consiglio di Stato il 24-25 ottobre 2022;
- una ricerca più recente a cura del BIICL del 2024
Il British of International and Comparative Law, diretto da Ivano Alogna, sta operando per allargare la base delle conoscenze dei casi concreti di giustizia climatica nei vasi Paesi, tra cui l’ Italia. Un evento si è tenuto a Milano in data 11 settembre 2024 a cura di questo Istituto (BIICL) in collaborazione con varie Università italiane (Roma ,Milano, Salento ,Trento).Anche la Fondazione ICEF sostiene l’iniziativa. Per l’Italia sono stati oggetto di esame 11 casi che riguardano soprattutto il tema energetico:
- un primo caso riguarda : Greenpeace ,Re Common contro ENI, iniziato il 9-5-2023 davanti al Tribunale civile di Roma. Viene invocata la responsabilità ENI ai sensi degli articoli.2043,2050,2051 Codice civile e articoli e 2 e 8 della Convenzione europea dei diritti umani;
- un secondo caso (Movimento difesa del cittadino ed al. contro ENI ( ENI Diesel case) riguarda il tema della pubblicità ingannevole per utilizzo olio di palma nel biodiesel. Il ricorso è stato accolto dal TAR e poi dal Consiglio di Stato;
-un terzo caso riguarda una class action ,promossa dall’Associazione “Altroconsumo” contro Volkswagen, Audi, Seat, Skoda (Dieselgate case) : la Corte di Appello di Venezia nel novembre 2023 ha riconosciuto la legittimità della condotta delle società convenute e solo un danno morale, non pecuniario;
-un quarto caso ( Milan Stadium case) riguarda un gruppo di cittadini che impugna davanti al TAR Lombardia una Delibera del Comune di Milano relativa alla costruzione di un nuovo Stadio nella città;
-un quinto caso riguarda una azione inibitoria collettiva dei cittadini di Taranto ,per la riduzione delle emissioni dannose e la protezione della loro salute, esercitata contro Acciaierie d’Italia Holding S pA, Acciaierie d’Italia S p A ed ILVA ( luglio 2021);
- un sesto caso riguarda tre Petizioni proposte da cittadini ed Associazioni (Rete legalità per il clima) contro Gruppo Cremonini S. p. A. e Veronesi Holding S.p.A. ed ancora ENI S.p.A. che riguardano il rispetto delle OECD Guidelines negli anni 2021 e 2022.;
- un settimo caso ( Associazione Re: Common vs Saipem S.p.A. ed ENI S.p.A .) riguarda il diritto alle informazioni che viene esteso a Progetti energetici delle multinazionali interessate anche esterni all’Italia (Mozambico): prima il Tar e poi il Consiglio di Stato ( Decisione n.2635\2023) hanno accolto il ricorso;
-un ottavo caso ( Ikebiri case) riguarda l’ENI ed attività dannose nel Delta del Niger ,riconosciute come illegittime a danno della Comunità locale nigeriana Ikebiri( 2017).Seguono - altri tre casi potranno essere esaminati in” Italy National Report “del British Institute of International and Comparative Law,2024.
5- Il ruolo della Corte dei diritti umani di Strasburgo
La CEDU, organo giurisdizionale del Consiglio di Europa, con una sentenza in data 9 aprile 2024, ha condannato la Svizzera per violazione dei diritti umani in materia di cambiamento climatico.
La sentenza merita un esame specifico perché introduce ufficialmente-per la prima volta- il riferimento giuridico alla categoria generale dei diritti umani quale legittima causa da valutare in materia di mutamento climatico: il nesso tra cambiamento climatico e possibile violazione dei diritti umani diventa così reale e può essere invocato concretamente dalle persone ed associazioni anche contro gli Stati inadempienti con riferimento agli Accordi di Parigi sul clima del 2015, quando ne ricorrono i presupposti.
Si tratta di un precedente importante che impegna il ruolo dei giudici, ai vari livelli, in una frontiera complessa destinata a definirsi gradualmente per una risposta coerente ed efficace della giustizia secondo principi comuni condivisi.
Qualche considerazione:
-
la CEDU è un Organo di Giustizia di 46 Paesi del Consiglio di Europa che ha competenza in materia di diritti umani;
-
le sue sentenze hanno potere vincolante ed obbligano i Paesi del Consiglio di Europa ad adeguarsi;
-
la CEDU ha ritenuto undato di fatto scientificoda accogliereche “ esistono indicazioni sufficientemente attendibili dell’esistenza del cambiamento climatico di origine antropica”, che costituisce “una grave minaccia attuale e futura al godimento dei diritti umani garantiti dalla Convenzione del 1950 e dai numerosi Protocolli attuativi”;
-
la CEDU, esaminando lo status di vittime delle donne ricorrenti (appartenenti ad un Gruppo Senior Women for Climate Protection ), in considerazione della loro età avanzata e della particolare vulnerabilità ad ondate di calore in Svizzera durante il periodo estivo, ha accolto il ricorso ai sensi degli articoli 2 e 8 della Convenzione, che riconoscono il diritto dei singoli ad una efficace protezione da parte delle autorità statali dai gravi effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle loro vite, salute, benessere e qualità della vita;
-
nel caso specifico, l’azione delle Autorità della Svizzera sarebbe risultata inadeguata rispetto agli obblighi assunti con la Convenzione delle Nazioni Unite del 1992 e con l’Accordo di Parigi del 2015.
-
Il nuovo orientamento della Corte dei diritti umani di Strasburgo in tema di diritti umani e ambiente aveva già trovato un precedente presso la Corte interamericana dei diritti umani ( Opinione consultiva n.23\17 del 15 novembre 1917 con riferimento al Progetto di un secondo canale artificiale tra Mar dei Caraibi e Pacifico, Paesi contendenti Colombia e Nicaragua ). V. Tullio Scovazzi “ La Corte interamericana dei diritti umani svolge una trattazione sistematica del diritto umano ad un ambiente sano”, in Rivista Giuridica dell’Ambiente” n.4\2019,pp 713 ss. Viene in particolare sottolineatala natura individuale e collettiva del diritto umano all’ambiente, di carattere universale, con una visione ecocentrica.
1 a) Nel 1949 (Arrêt, C.I.J., Recueil, 1949, p. 22) nell’Affare Detroit di Corfù, la Corte ritenne contrario al diritto internazionale il comportamento dell’Albania, consistente nel porre un campo di mine nelle sue acque territoriali senza avvertire le navi da guerra britanniche che si avvicinavano, nell’esercizio del diritto di navigazione.
La Corte enunciò il principio che lo Stato deve controllare le attività esercitate nei limiti della sua giurisdizione, affinché non causino danni ad altri Stati, principio che sarà ripreso dalla Dichiarazione di Stoccolma il 16 giugno 1972 delle N.U. in tema di ambiente umano (il principio di cui sopra era già presente nella decisione 16 aprile 1938, la Fonderie du Trail, tra USA e Canada, di un Tribunale arbitrale).
b) Nel 1973 la Corte ebbe modo di occuparsi del conflitto tra Australia e Nuova Zelanda da una parte e Francia dall’altra con riferimento agli esperimenti nucleari nel Pacifico ed ai relativi rischi.
Pur non pronunciandosi sul merito della controversia, la Corte diede un Avis Consultatif ed emanò due ordinanze, che imponevano misure conservative, nel senso di un dovere di astensione della Francia a proseguire esperimenti che potevano cagionare ricadute radioattive pericolose nei due Stati interessati (Australia e Nuova Zelanda).
c) Nel 1951 in una questione non direttamente ambientale, la Corte (nell’Avis Consultatif, p. 23, sul regime relativo alla possibilità di riserve alla Convenzione per la prevenzione e repressione del crimine di genocidio), si occupò dei trattati internazionali caratterizzati da “obblighi erga omnes ”, e non solo reciproci, nei quali deve prevalere l’interesse comune umano e civilizzatore dello strumento internazionale. Trattasi di una ratio decidendi che può ispirare i trattati multilaterali ambientali sopravvenuti, per loro natura universali.
d) In un altro caso (Arrêt Barcelona Traction, Light and Power Company, limited) riguardante un comportamento illecito della Spagna, la Corte ebbe modo di distinguere ancora le obbligazioni bilaterali dalle obbligazioni erga omnes : nei casi di atti di aggressione e genocidio e di violazione di diritti umani fondamentali delle persone umane, l’obbligo di osservanza è nei confronti di tutta la comunità internazionale, come tale.
La dottrina giuridica ha giustamente sottolineato l’importanza di questo principio anche in relazione ai trattati multilaterali in tema di ambiente.
e) Nel 1974 in un altro caso (Arrêt CIJ, Regno Unito e Germania c/o Islanda), la Corte invitò gli Stati interessati alla pesca nel mare del Nord a trovare soluzione equa alle loro divergenze, conciliando le esigenze di conservazione con uno sfruttamento sostenibile della risorsa.
f) Nel 1996 sulla minaccia o l’impiego di armi nucleari ed i rischi per l’ambiente, la Corte (in un Avis Consultatif) ebbe modo di notare che, pur mancando un divieto esplicito nel diritto internazionale, gli Stati hanno l’obbligo di rispettare l’ambiente degli altri Stati e quello delle vaste aree fuori giurisdizione, perché l’ambiente “non è una astrazione” ma “lo spazio dove vivono gli esseri umani, da cui dipende la qualità della vita e la salute, compresa quella delle generazioni future”.
g) Nel 1997 in un altro caso più recente molto noto, riguardante il Progetto Gabčìkovo-Nagymaros, ovvero la costruzione di una diga sul Danubio ed il suo impatto ambientale (Arrêt, Ungheria e Slovacchia, C.I.J. Recueil 1996, pagg. 241-242, par. 29), la Corte ebbe modo di precisare che “il concetto di sviluppo sostenibile traduce bene la necessità di conciliare sviluppo economico e protezione dell’ambiente”.
2 Alcuni casi esaminati dal Tribunale internazionale per il diritto del mare:
The M/V “SAIGA” Case (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea), Prompt;
The M/V “SAIGA” (No. 2) Case (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea;
Southern Bluefin Tuna Cases (New Zealand v. Japan; Australia v. Japan), Provisional Measures;
The “Camouco” Case (Panama v. France), Prompt Release;
The “Monte Confurco” Case (Seychelles v. France), Prompt Release;
The “Grand Prince” Case (Belize v. France), Prompt Release;
Case concerning Land Reclamation by Singapore in and around the Straits of Johor (Malaysia v. Singapore), Provisional Measures;
The “Juno Trader” Case (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea - Bissau), Prompt Release;
The “Hoshinmaru” Case (Japan v. Russian Federation), Prompt Release;
The “Tomimaru” Case (Japan v. Russian Federation), Prompt Release;
The “Chaisiri Reefer 2” Case (Panama v. Yemen), Prompt Release;
The MOX Plant Case (Ireland v. United Kingdom), Provisional Measures
Per maggiori informazioni è possibile consultare il seguente indirizzo web:
Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders. http:/ /www.itlos.org/start2_ehtml
3 Vedi per una dettagliata panoramica P. GIAMPIETRO, Nuove contestazioni comunitarie sulla nozione autentica di rifiuto , in “Ambiente”, n. 1/2004.
4 Vedi A. POSTIGLIONE, La partecipazione delle persone offese al procedimento penale in materia di tutela del territorio e dell’ambiente , Corso di studio C.S.M. 11-14 novembre 2002.
5 Mi permetto rinviare alla mia relazione “Sustainable development and the role of law in Italy”, pag. 197, Report UNEP 2002, volume II, Global Judges Symposium of Johannesburg, South Africa, 18-20 agosto 2002.
6 Venezia, verificatosi il 27 dicembre 1998. Il Tribunale di Venezia con sentenza del 27 novembre 2002, n. 1286 (pubblicata in www.giuffré.it/riviste/2ga) ha ritenuto la responsabilità penale dei responsabili della gestione dello stabilimento per aver omesso di adottare le misure necessarie ad evitare la fuoriuscita occasionale di gas tossico (ammoniaca) con danni ai dipendenti ed alle risorse naturali.
La sentenza è importante per i criteri applicati nella quantificazione del danno civile.
Anche se la fuoriuscita del gas è durata solo due ore, il danno risarcibile è stato quantificato in 225.000 euro: di cui euro 25.000 per costo ripristino ambientale ed euro 200.000 corrispondenti al profitto illecito conseguito.
È stata data un’interpretazione rigorosa della norma specifica sul danno ambientale (art. 18 legge n. 349/1986), nel senso di comprendere nel risarcimento esattamente la ricchezza illegittimamente prodotta grazie alla condotta omissiva, causa del danno ambientale (all’atmosfera ed alle acque).
7 Si tratta di un disastro cagionato dalla caduta in un lago artificiale di quantità enormi di rocce dai versanti delle montagne, con conseguente travaso delle acque oltre la diga e distruzione e morte nell’area sottostante.
Dopo 40 anni di vertenze giudiziarie si arrivava ad un accordo transattivo e lo Stato italiano incassava nel 1999 un importo di 100 miliardi di lire.
8 Il giorno 11 aprile 1991 si verificava un incendio della nave petroliera Haven nella rada di Genova - Arenzano.
La petroliera affondava il 14 aprile. Il grave incidente comportava la morte del comandante e di alcuni membri dell’equipaggio ed un grave danno ambientale.
Il Tribunale di Genova, con sentenza del 21 novembre 1997, n. 945, non individuava la causa certa del danno e perciò assolveva gli imputati.
Con legge 16 luglio, n. 239 veniva approvata una transazione per un risarcimento a favore dello Stato di 117,6 miliardi di lire (riconoscendosi in tal modo i danni civili del grave incidente).
9 Il Tribunale di Bastia, in Corsica, con sentenza del 4 luglio 1985, n. 422, condannava la società italiana Montedison a pagare 180.000 franchi ai pescatori di Bastia (per il pregiudizio di aumento dei costi di produzione dovuti all’estensione maggiore del tragitto dei pescherecci per evitare le zone inquinate e per il pregiudizio dovuto alla perdita di merce) e 250.000 franchi a favore dei Dipartimenti dell’Alta Corsica e della Corsica del Sud (pregiudizio all’immagine).
I giudici francesi hanno ritenuto che l’onere della prova incombe su chi assume di aver subito il danno, secondo i principi generali, ma che in materia di ambiente si deve tener conto della particolare difficoltà della prova.
È un caso di danno ambientale transfrontaliero, almeno in parte, risolto con le regole della collaborazione giudiziaria tra Paesi diversi, secondo il diritto internazionale.
10 Merita di essere segnalata la sentenza del Tribunale Amministrativo del Veneto della sezione I, n. 1350/2000, che ha annullato il giudizio negativo espresso dalla Commissione di Valutazione dell’Impatto Ambientale del Ministero dell’ambiente e del territorio, relativa ad un progetto.
Il progetto, denominato “Mosè”, riguarda alcune opere di regolamentazione del regime delle acque in entrata dall’Adriatico nella Laguna Veneta (cosiddetta acqua alta) per evitare che il centro storico sia periodicamente sommerso (le paratie mobili hanno funzionato).
11 Come è noto, l’ossido di etilene è una sostanza molto pericolosa largamente impiegata in campo alimentare (antimuffa per il pane o coadiuvante nella maturazione della frutta), nella disinfezione o disinfestazione di erbe; in campo medico per sterilizzare sonde, cateteri, ecc.
Nel 1981 la Pretura di Torino richiedeva all’Istituto Superiore di Sanità di pronunciarsi sulla pericolosità della sostanza. La risposta era nel senso della pericolosità.
Intanto il Ministero della sanità con tre circolari successive (1 ottobre 1981, 10 marzo 1982, 23 giugno 1983) stabiliva il valore soglia prima in 50 ppm, e poi 3 ppm.
Un valore quest’ultimo ancora alto. È un caso di pressione della magistratura e di collaborazione con la P.A.
12 Anche di questo argomento la Pretura di Torino si occupava chiedendo un parere all’Istituto Superiore di Sanità. Questo istituto rispondeva, confermando il rischio cancerogeno e “raccomandando il più basso livello di esposizione alla formaldeide sia dei lavoratori che della popolazione in generale”.
13 Nel dibattito sul ruolo dei TLV per gli agenti chimici, un punto fermo è rappresentato dagli artt. 20 e 21 d.P.R. 1956 n. 303, nell’interpretazione messa a fuoco dalla Cassazione in un’importante pronuncia del 3 aprile 1981 in causa Ivaldi. Il caso riguarda un’impresa produttrice di manufatti in gomma e amianto destinati specialmente al settore automobilistico. Il responsabile dell’azienda è condannato dal Pretore di Pinerolo per non aver adottato provvedimenti atti a contenere polveri d’amianto e fumi prodotti dalle presse e dai pezzi stampati. La Corte Suprema, nel rintuzzare le doglianze contro il verdetto pretorile, enuncia un primo, basilare principio: “le prescrizioni imposte al datore di lavoro dagli artt. 20 e 21 d.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 non sono limitate ai lavori dai quali si sviluppano gas o vapori irrespirabili o tossici, ma comprendono anche quelli in cui si sviluppano odori o fumi o polveri di qualunque specie. Pertanto, sono irrilevanti sia la mancanza di tossicità sia la generica nocività dei vapori o delle polveri derivanti dalle sostanze usate dai lavoratori”.
Non si potrebbe immaginare insegnamento in più radicale antitesi con la teorizzazione dei TLV: l’obbligo dì prevenzione scatta per l’intera gamma degli agenti chimici (ivi comprese le polveri), a prescindere da una comprovata tossicità e pur quando le concentrazioni atmosferiche non eccedano predeterminanti parametri quantitativi. E un insegnamento che la Corte ribadisce il 13 giugno 1984 in causa Besner.
14 La Corte dei Conti, a sezioni riunite, con decisione del 16 giugno 1984 (in “Il foro italiano”, Roma, 1985, pag. 38) si è occupata ancora dei c.d. fanghi rossi di Scarlino, cioè dei residui della lavorazione industriale di biossido di titanio, scaricati dalla Montedison nel mare Tirreno. La decisione conferma la condanna del comandante della Capitaneria di Porto di Livorno (per aver concesso l’autorizzazione agli scarichi) e del direttore del Laboratorio centrale di idrobiologia del Ministero dell’agricoltura e foreste (per aver dato parere tecnico favorevole), violando gli obblighi di servizio. La decisione è di grande importanza perché:
a) considera tutti i beni ambientali (compreso il mare libero) come “beni giuridici” (in quanto esiste una normativa di protezione), a prescindere dalla “appartenenza”;
b) considera il danno ambientale come un “danno pubblico” che lo Stato deve ripristinare;
c) considera responsabile del danno i funzionari pubblici, che per dolo o colpa, violando i doveri di ufficio, hanno cagionato il danno medesimo. Il c.d. danno ambientale entra, dunque, nell’opera di costruzione di un nuovo concetto più ampio di danno pubblico, ad opera della giurisprudenza (vedi in dottrina: P. MADDALENA, “Danno ambientale, danno pubblico e responsabilità amministrativa”, in “Il Consiglio di Stato”, Roma, 1982, Il, pag. 1423; sui fanghi rossi di Scarlino: K. SIEHER, Protezione dell’ambiente transfrontaliero: esperienze europee di un problema mondiale in “Il foro italiano”, Roma, 1981, V, pag. 314).
15 Il Pretore di Menaggio, con sentenza del 29 giugno 1983, imputato Vezzolo (in “Il foro italiano”, 1985, II, pag. 36) condannava il gestore di un Centro di Raccolta per la demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore fuori uso per avere realizzato una “discarica non autorizzata”.
Il concetto di discarica - a giudizio del Pretore - consiste in una “ attività duratura nel tempo e tale da determinare un’alterazione permanente e spesso irreversibile dell’area interessata. Dell’esistenza di una discarica sono elementi sintomatici la ripetitività degli scarichi, l’ingente quantità dei rifiuti versati e depositati per lungo tempo ed altri segni esteriori che dimostrino il deturpamento o la decomposizione di una fascia di terreno anche di uso privato”. Tale concetto si distingue, perciò, dal deposito occasionale di rifiuti. In Italia vi è ancora un gran numero di depositi di veicoli abbandonati soprattutto alla periferia delle grandi città. Tali depositi spesso non hanno carattere provvisorio e non sono finalizzati al riutilizzo. Sotto tale profilo la decisione del Pretore di Menaggio correttamente non vede una differenza dalle normali discariche. Questo criterio è stato più volte confermato dalla Corte Suprema di Cassazione e per merito della magistratura il fenomeno tende a ridursi.
16 E questo uno dei casi più importanti verificatisi in Italia in materia di smaltimento di rifiuti tossici e pericolosi. La Montedison, attraverso tre stabilimenti (Fertimont, Montefluos e Ausiodet) in Marghera, scarica in mare (con apposite navi cisterne) circa 1 milione di tonnellate di fosfogessi (residui di produzione di acido fosforico e acido fluoridrico) ed altre sostanze nocive (arsenico, cromo, zinco, ferro, radio266, fosfati). Tuttavia, al termine di un’inchiesta durata tre anni, la Procura della Repubblica del Tribunale di Venezia ha chiesto, il 28 luglio del 1980, l’assoluzione di 11 dirigenti della Montedison e di un’altra Società (Alumental), giudicando non pericolosi gli scarichi industriali.
La Regione Emilia-Romagna, successivamente, preoccupata per l’eutrofizzazione del mare Adriatico (eccessiva proliferazione di alghe) e del pericolo di vedere compromessi flussi turistici lungo la costa, chiedeva al T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo Regionale) la sospensione dell’autorizzazione allo scarico in mare dei fanghi della Montedison, rilasciata dal Ministro della marina mercantile.
Il 29 marzo 1985 il T.A.R. Lazio rigetta in via provvisoria la richiesta di sospensione.
Il 12 dicembre 1984 le tre più importanti associazioni ambientalistiche italiane (Italia Nostra, Lega Ambiente, WWF) presentavano una denuncia alla Procura della Repubblica del Tribunale di Roma contro il Ministro della marina mercantile per avere egli prorogato fino al luglio 1985 le autorizzazioni allo scarico di 3500 tonnellate al giorno di rifiuti industriali pericolosi. Qualche modesto risultato è stato conseguito.
17 La società Stoppani di Cogoleto (25 km da Genova) produce bicromato per le concerie e scarica in mare i relativi fanghi (70 mila tonnellate di cromite all’anno). A seguito dei danni lamentati da pescatori, alla balneazione ed alla flora, fauna marina, il Pretore di Sestri Ponente iniziava un’indagine.
Un’altra indagine era promossa davanti al Pretore di Genova, con una denuncia del 3 luglio 1985 presentata da un gruppo di cittadini e da Associazioni ecologiche (Lega per l’Ambiente). In tale denuncia si sosteneva che lo scarico in mare di rifiuti tossici e nocivi è assolutamente vietato, perché illegittimo e di conseguenza non trovano alcuna giustificazione le autorizzazioni date dal Ministro della marina mercantile alla Società Stoppani il 17 giugno 1983, con proroghe successive il 19 luglio 1984 ed il 31 dicembre 1985 e fino al luglio 1986. Successivamente interveniva il divieto del Ministro dell’ambiente, con un’apposita ordinanza.
18 Il 20 luglio 1979 il mercantile greco Klearchos affondava tra le isole Molara e Tavolara in Sardegna con un carico di sostanze tossiche. Interveniva il Pretore di Olbia il 10 agosto 1979, affidando ad un perito il compito di ispezionare le stive del relitto. L’assessore all’ambiente della Regione Sardegna disponeva il recupero dei fusti caduti in mare, completato nel giugno 1981. I fusti contenenti le sostanze tossiche sono stati recuperati ed inviati in due industrie francesi ed in una italiana (Anicfibre di Ottana, Nuoro, Sardegna, con reazioni negative dei lavoratori dello stabilimento).
19 Il mercantile trasportava 909 bidoni contenenti piombo tetraetile, sostanza molto velenosa, ed affondò il 4 luglio 1974 al largo di Otranto. Con grande impegno il Pretore di Otranto riuscì a far recuperare 863 fusti. La condanna del comandante della nave è stata pronunciata il 29 maggio 1985 dal Tribunale di Lecce.
20 Il Pretore di Augusta il 29 settembre 1979 sequestrava tre grandi stabilimenti industriali (Esso, Montedison e Liquichimica) per gli scarichi industriali pericolosi nell’aria nel suolo e nelle acque (baia di Augusta).
Le associazioni sindacali avevano in precedenza (16 settembre) proclamato uno sciopero per sollecitare la tutela ecologica della rada inquinata dagli stabilimenti petrolchimici.
Il procedimento penale si concludeva il 21 gennaio 1981 con la condanna del direttore della Raffineria ESSO a mesi 2 e gg. 10 di reclusione.
21 Il Pretore di Gela il 15 novembre 1979 sequestrava lo stabilimento petrolchimico dell’Anic di Gela.
Il procedimento si concludeva il 21 febbraio 1981 con la condanna del direttore dello stabilimento a gg. 20 di pena detentiva.
22 Nel corso di 20 viaggi tra Manfredonia (Puglia) e le antistanti, bellissime isole Tremiti, la motonave “Irene” ha scaricato senza autorizzazione sostanze tossiche (9mila tonnellate). Le isole Tremiti sono state adoperate come luogo di scarico di rifiuti.
Interviene il Pretore di Manfredonia.
Vengono arrestati il 3 aprile 1981 il comandante e la proprietaria della nave. La situazione è cambiata.
23 Il caso è noto a livello internazionale.
Il 10 luglio 1976 una nube tossica contenente diossina fuoriusciva dallo stabilimento ICMESA in Seveso presso Milano, cagionando gravissimi danni a persone e cose in un vasto territorio.
Il Tribunale di Monza, con sentenza del 24 settembre 1983, ha condannato il responsabile tecnico dello stabilimento ICMESA (anni 5 di reclusione); il direttore tecnico del Gruppo Givaudan, cui fa capo l’ICMESA (anni 5 di reclusione); il responsabile della progettazione e impiantistica dell’ICMESA all’epoca della costruzione del reattore (anni 4 di reclusione); il presidente del consiglio di amministrazione dell’ICMESA (anni 4 di reclusione); il responsabile del settore ingegneristico e dei sistemi di sicurezza (anni due e sei mesi di reclusione).
Ha, inoltre, condannato gli imputati e l’ICMESA al risarcimento dei danni a favore delle parti civili (Sindaco e n. 17 gruppi di persone).
La sentenza è molto elaborata e contiene, in 210 pagine dattiloscritte, la descrizione del fatto, gli elementi di prova raccolti e la spiegazione dei motivi posti a base della decisione di condanna.
Il disastroè così descritto:
“Dalle risultanze processuali emerge in tutta evidenza la drammaticità delle conseguenze determinate dalla fuoriuscita dal reattore installato nel capannone “B” dell’ICMESA, alle ore 12,30 del sabato 10 luglio 1976, di una nube densa e di notevole altezza, sviluppatasi nell’atmosfera per circa 15/20 minuti.
Tale nube, contenente sostanze altamente tossiche, tra le quali la TCDD (2, 3, 7, 8, tetraclorodibenzoparadiossina), si era estesa rapidamente inquinando un vasto territorio.
La consistenza della massa sprigionatasi dal reattore non è stata mai esaminata in tutte le sue componenti e ciò, del resto, è risultato materialmente impossibile.
Non si è, pertanto, potuto pervenire ad una stima sicura della quantità di diossina formatasi, ed in particolare di quella fuoriuscita, anche a causa della pioggia precipitata nei giorni immediatamente successivi.
L’allarme subito destato nella popolazione abitante nei Comuni limitrofi allo stabilimento ICMESA fu notevole, per l’immediata constatazione delle conseguenze nocive sulle persone (sintomi di cloracne su numerosi bambini, di volta in volta ricoverati nei vicini ospedali), moria di animali, specialmente domestici, e danni alle colture ed alla coltivazione.
Tale allarme fu aggravato in misura rilevante dalle numerose difficoltà consistenti anche nella sconoscenza dell’esatta definizione dell’accaduto, e quindi nell’adozione di misure non tempestive atte a fronteggiare efficacemente e con immediatezza (v. ordinanze di evacuazione emesse a distanza di diversi giorni ed allegate mappature delimitanti le zone inquinate, varianti nei giorni), il che certamente ebbe ad accrescere l’esposizione a rischio degli abitanti della zona.
La gravità dell’accaduto emerge ictu oculi, solo che si consideri l’elevata tossicità delle sostanze diffusesi nell’atmosfera, e soprattutto la presenza tra esse di diossina, ritenuta concordemente dagli esperti come la più tossica tra le dibenzoparadiossine clorurate, e considerata, secondo fonti scientifiche americane, dieci volte più tossica del gas nervino e da centomila ad un milione di volte più potente della talidomide.
Si legge altresì nella perizia di ufficio concernente le cause della morte di Turchetto Senno Genoveffa che la TCDD risulta essere la più tossica e la più nociva tra le sostanze chimiche di sintesi note a basso peso molecolare.
In particolare, per quanto concerne i danni alle persone, il Collegio peritale rileva che “la messe di dati ottenuti dalla sperimentazione su animali autorizza e fa richiedere la massima attenzione nel valutare l’azione e gli effetti di dosi anche minime di TCDD sull’uomo”.
Infatti, secondo i periti, il polimorfismo e la molteplicità degli effetti tossici, la non possibilità di avanzare previsioni ragionevoli sugli effetti a lungo termine (cancerogenicità, genolesività e teratogenicità) non consentono di fissare un livello di sicurezza, nel senso che non è possibile definire una soglia di dose in relazione alla quale la previsione di danno alla salute umana sia minima.
Di conseguenza, concludono i periti nel senso che, almeno allo stato attuale delle conoscenze, il livello di pericolosità della TCDD nei confronti della salute umana sia da considerare il più elevato possibile”.
E comunque indiscusso che nel caso in specie danni alle persone vi furono, come dimostrato dalle affezioni cutanee (cloracne), che dopo l’evento colpirono con forme spesso gravi il 19.6% dei bambini abitanti nelle zone più contaminate (zona “A”) e lo 0.5 - 0.7% di quelli delle altre zone, “B” ed “R” (v. comunicazione Regione Lombardia del 16 luglio 1979), e che, sotto il profilo eziologico, i periti collegano alla produzione di diossina, dagli stessi giudicata capace di propagazione per via transcutanea, gastroenterale ed inalatoria, e ciò in base alla constatazione della comparsa del suddetto fenomeno patologico non solo in seguito ad esposizione diretta in atmosfera inquinata e ad ingestione di alimenti contaminati, ma anche in seguito a semplice contatto o maneggio di strutture contaminate.
Inoltre alla documentazione in atti ed in particolare dal progetto di programma operativo predisposto dalla Regione Lombardia nel febbraio del 1997 si evince l’entità della catastrofe.
Invero l’incidente ICMESA ha cagionato un inquinamento diffuso in una vasta zona, suddivisa in tre parti:
1) zona A e cioè quella più contaminata, compresa per una piccola parte nel Comune di Meda e per il resto nei Comuni di Seveso, Cesano Maderno e Desio, per un totale di 108 ettari, e che determinò l’evacuazione degli abitanti (730);
2) zona E, meno contaminata, per un totale di 269,4 ettari ed interessante una popolazione di 4.800 persone;
3) zona R, fascia involgente le suddette due zone, compresa nel territorio dei quattro Comuni indicati, nonché nei Comuni di Barlassina e Bovisio Masciago, per un’estensione di 1430 ettari ed interessante una popolazione di 22.000 abitanti.
Inoltre dalla Relazione svolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta si ricava che l’inquinamento determinò il blocco di tutte le attività agricole e zootecniche della zona (cessazione di ogni attività da parte di 61 aziende e cessazione di ogni coltura in 4.000 orti e giardini familiari). Nella zona A dovettero sospendere l’attività tre stabilimenti industriali, che impiegavano complessivamente 119 unità lavorative, e nella zona B 11 stabilimenti, con 284 unità lavorative, subirono periodi variabili di chiusura in relazione al tempo necessario ad accertare lo stato di inquinamento della zona.
Infine 37 aziende artigianali ubicate nella zona A e 118 nella zona B, per un totale di 458 addetti, furono temporaneamente bloccate; alcune aziende commerciali site in zona A furono evacuate e tre di esse non ripresero più l’attività. E’ evidente, in base a quanto sinora esposto, che nell’incidente descritto ricorrono tutte le condizioni richieste per farlo assurgere a dignità di disastro, coinvolgente una vasta zona ad elevata densità abitativa, atteso lo sconvolgimento del tessuto sociale interessato e la pubblica commozione generata dalle incertezze circa eventuali effetti acuti, non ancora compiutamente spiegati dalla scienza e dalla tecnica, nonché dal timore panico, cagionati dalla fuoriuscita della nube tossica.
Il Tribunale di Monza ha precisato che l’ICMESA era una società figlia della Givaudan svizzera, che conservava il potere di coordinamento generale nella produzione della pericolosa sostanza tossica.
Secondo i giudici di Monza il tipo di produzione adottato dalla ICMESA era da considerare obiettivamente pericoloso (utilizzatore di metanolo o di glicol etilenico come solvente a temperature elevate), come dimostrato da precedenti incidenti verificatisi in USA (1949-1960), in Germania F. (BASE 1953), in Olanda (Philips Duphar 1963) ed in Inghilterra (Coalite Chemicol-Balsover, 1968). In particolare l’idrolisi alcalina del TGB era un’operazione altamente pericolosa, potendo dar luogo a reazioni chimiche anomale, anche a temperature inferiori a 180°.
Il Tribunale ha posto in rilievo i gravi comportamenti omissivi degli imputati per le carenze riscontrate nella strumentazione, nei sistemi di allarme, nei dispositivi di sicurezza (mancavano ad esempio meccanismi automatici di allarme) e la loro consapevolezza della potenziale pericolosità del tipo e modo di produzione.
Sussisteva, dunque, il reato di omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437, comma 2, c.p.). I danni civili non sono stati liquidati ma affidati ad un giudizio a parte in sede civile.
È chiaro che molti danni, per la natura del disastro, rimarranno a carico della collettività locale e nazionale, in quanto il meccanismo risarcitorio civile tradizionale non offre da solo una copertura adeguata.
Per il caso Seveso, oltre alla magistratura, si sono mobilitati gli enti locali interessati (Comuni, Provincia, Regione Lombardia) ed il Parlamento nazionale, che ha istituito una commissione di inchiesta di 15 deputati e 15 senatori per indagare e riferire sulle cause e responsabilità del disastro. Tanta mobilitazione di energie è stata purtroppo successiva, a disastro avvenuto.
In sede comunitaria il caso Seveso ha mosso l’iniziativa per l’approvazione della direttiva 82/501 /CEE sui rischi da incidenti, connessi con determinate attività industriali. Nonostante la triste esperienza fatta, l’Italia ha ritardato a recepire la direttiva in modo adeguato sul piano formale meritandosi una condanna della Corte di Giustizia di Lussemburgo (1° marzo 1983 causa Commissione contro Repubblica Italiana).
24 In origine è costituito da tre linee, con capacità superiore a 3 tonnellate all’ora, con autorizzazione a smaltire 140.000 tonnellate per anno.
Successivamente la società privata di gestione presenta un progetto di adeguamento funzionale dell’impianto (ristrutturazione delle tre linee e costruzione di una nuova linea).
L’autorità competente per la VIA (Provincia di Modena) approva il progetto per una capacità di trattamento di 240.000 tonnellate di rifiuti all’anno (delibera n. 429 del 26 ottobre 2004). Nessuno propone ricorso.
In epoca ancora successiva (il 30 maggio 2006) la società di gestione chiede il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale, concessa con atto n. 74 del 2 febbraio 2007.
Questa autorizzazione contiene specifiche prescrizioni ed anche un programma graduale di realizzazione (cronoprogramma) nel senso del funzionamento graduale a regime dal 30 novembre 2009.
Contro l’autorizzazione unica ambientale (n. 74 del 2 febbraio 2007) viene proposto ricorso al Tribunale Amministrativo di Bologna da parte di tre associazioni (due nazionali, WWF e Italia Nostra) ed una locale (Comitato Modena Salute ed Ambiente), nonché di alcuni cittadini residenti nella zona.
Resistono sia la società privata di gestione, sia i due enti locali interessati (Comune di Mantova e Provincia di Modena). Con sentenza del 26 novembre 2007, n. 3365, il Tribunale Amministrativo Emilia-Romagna di Bologna riconosce la legittimazione ad agire delle due associazioni di protezione dell’ambiente a carattere nazionale perché comprese tra quelle riconosciute con decreto del Ministero dell’ambiente; riconosce la legittimazione del Comitato Modena Salute ed Ambiente perché radicato sul territorio e non nato per il solo scopo di contrastare il progetto di potenziamento dell’impianto; riconosce la legittimazione solo dei cittadini che avevano addotto la prova di un interesse differenziato, in quanto proprietari di beni suscettibili di subire una diminuzione di valore.
Nel merito la sentenza ritiene irrilevante la circostanza della positiva conclusione della procedura di VIA sul progetto di adeguamento funzionale dell’impianto e considera l’autorizzazione integrata ambientale come atto autonomo impugnabile a prescindere dalla impugnazione della VIA.
Secondo i giudici, nel caso di specie, l’autorizzazione integrata ambientale era illegittima perché comprendeva un impianto connesso ma non localizzato nello stesso sito e perché comprendeva un impianto di depurazione biologica non dello stesso gestore (anche se facente parte della società madre che gestisce l’inceneritore).
La sentenza è interessante ma desta qualche perplessità la mancata considerazione dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all’epoca vigente, che stabilisce: “il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale fa luogo dell’autorizzazione integrata ambientale;” l’art. 26, punto 4, della stessa legge prevede: “Il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale sostituisce e coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nella osta e assensi comunque denominati necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o intervento, inclusa, nel caso di impianti che recidono nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59, l’autorizzazione integrata ambientale”.
25 La sentenza n. 136 del 26 febbraio 2007 del T.A.R. Friuli-Venezia Giulia riguarda il caso di una autorizzazione per un impianto di smaltimento di rifiuti, adottato senza la partecipazione della Regione Veneto alla Conferenza dei Servizi.
La questione è ormai superata perché il decreto legislativo n. 4 del 2008 prevede il carattere discrezionale e non più obbligatorio della Conferenza dei Servizi nella procedura per l’autorizzazione ambientale integrata.
26 Il T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 17 aprile 2007, n. 1628 ha annullato l’autorizzazione ministeriale di un progetto preliminare di un rigassificatore, perché privo di valutazione dell’impatto ambientale e senza alcuna consultazione della popolazione.
27 Discarica esistente nella quale successivamente viene sversato materiale cementizio contenente amianto.
Il Consiglio di Stato, sez. V, 20 marzo 2007, sentenza n. 1329, ha stabilito la necessità di una procedura di VIA.
28 Non è necessaria una nuova procedura di VIA per alcune modifiche non sostanziali, purché siano state adottate soluzioni tecnologiche migliorative secondo il concetto di Best Available Technology (T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 12 gennaio 2007, n. 12).
29 (T.A.R., Lazio, Roma, sez. I, 16 giugno 2006, n. 4731).
30 Necessità della VIA (Consiglio di Stato, sez. VI, 24 settembre 2004, n. 6255).
31 È richiesta la procedura di screening (T.A.R. Liguria, Genova, sez. I, 18 marzo 2004, n. 267).
32 Necessità della VIA solo a seguito di procedura di screening ad opera della Regione competente (T.A.R. Basilicata, Potenza, sentenza 30 luglio 2001, n. 658).
33 Necessità della VIA (Consiglio di Stato, sez. IV, 19 luglio 1993, n. 741).