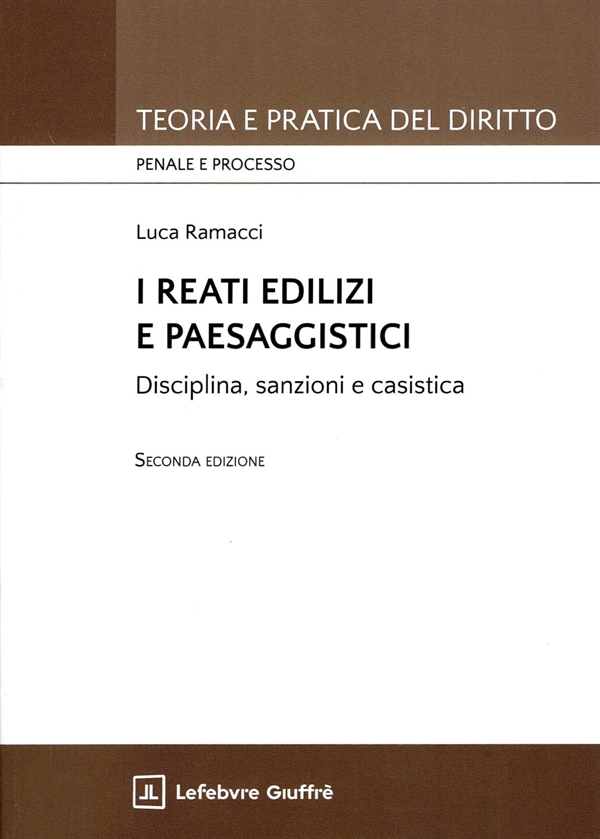I “patrimoni culturali urbanistici” nella Costituzione
I “patrimoni culturali urbanistici” nella Costituzione
di Nicola PIGNATELLI
Pubblicazione dell'Ufficio Studi della Giustizia amministrativa
I “patrimoni culturali urbanistici” nella Costituzione
(Relazione - AIDU, Firenze, 8.11.2024[1])
Nicola Pignatelli
Sommario: 1. Sulla nozione di “patrimonio culturale urbanistico” tra bisogno di emersione e delimitazione dei confini. - 2. Il fondamento costituzionale del “patrimonio culturale urbanistico”. - 2.1. L’irrilevanza dell’art. 9, 2° comma, Cost. - 2.2. L’art. 9, 1° comma, Cost. quale clausola apertadella Costituzione culturale: i “patrimoni culturali urbanistici”. - 2.3. I “patrimoni culturali urbanistici” come beni a vocazione minoritaria. - 2.4. La mobilità dei “patrimoni culturali urbanistici” verso la Nazione. - 3. Il riparto di competenze legislative: il “governo culturale del territorio”. - 3.1. I titoli competenziali inconferenti. - 3.2. Il “governo del territorio” in attuazione dell’art. 9, 1° comma, Cost. - 3.3. I principi fondamentali statali e la normativa regionale di dettaglio. - 3.4. Il principio di leale collaborazione a tutela dei patrimoni: il coordinamento degli “strati”. - 3.5. La resistenza del “governo culturale del territorio” alla presunzione statale di culturalità. - 4. La potestà di pianificazione urbanistica in attuazione diretta della Costituzione culturale. - 5. La variabile del regionalismo differenziato. - 6. Una notazione conclusiva.
1. Sulla nozione di “patrimonio culturale urbanistico” tra bisogno di emersione e delimitazione dei confini
La nozione di “patrimonio culturale urbanistico” sconta molteplici difficoltà:
i) una difficoltà costituzionale, essendo necessario rintracciarne il fondamento in una o più disposizioni della Costituzione, quale condizione di legittimità e di stabilità, nelle dinamiche del pluralismo (istituzionale e valoriale), delle norme attributive dei poteri amministrativi incidenti su tale “patrimonio” (o quale fonte diretta di attribuzione di tali poteri);
ii) una difficoltà legislativa, posto che tale nozione è sottoposta all’inevitabile condizionamento e ingombro generato dalla positivizzazione codicistica della nozione limitrofa di “patrimonio culturale” [2] (“costituito dai beni culturali e paesaggistici”, come previsto dall’art. 2, 1° comma, dlgs. n. 42/2004); una vicinanza che impone distinzione tra i patrimoni [3] ;
iii) una difficoltà semantica, essendo utilizzati due aggettivi (accanto ad un sostantivo), potenzialmente antinomici, perché afferenti a due ambiti materiali (quello culturale e quello urbanistico) espressione di interessi diversi, insistenti sul medesimo palco (il territorio) ma tradizionalmente confliggenti (perché apparentemente riconducibili al “non fare” e al “fare”, alla conservazione e allo sviluppo, al passato e al futuro). Peraltro la nozione di “patrimonio culturale urbanistico” si confronta con una certa fluidità linguistica. Tale nozione, infatti, è spesso assorbita o diluita in quelle (potenzialmente più generali e comunque non coincidenti) di “altri beni”[4], “beni di rilevanza culturale”[5], “beni culturali in senso ampio”, “beni minori”[6], “beni d’altro genere” [7] o più semplicemente in quella di “beni extra-codice”[8]; anche quest’ultima espressione, pur perimetrando l’oggetto dell’indagine con maggiore immediatezza, rischia di non essere appagante, risolvendo la ricostruzione del “patrimonio culturale urbanistico” in un mero accertamento negativo rispetto ad una fonte normativa primaria, ossia in un oggetto extra-vagante rispetto al Codice.
Più in generale le suddette problematiche ( sub i, ii, iii) si legano ad una difficoltà sistemica di emersione della dimensione giuridica; una dimensione (nella sua accezione inizialmente neutra rispetto a quelle impegnative di “materia”, “complesso di beni” o “politica pubblica”) alla ricerca di stabilizzazione nell’ordinamento giuridico, per quanto da tempo si parli di una nozione “aperta” [9] di bene culturale.
La dottrina amministrativistica ha posto in essere, e continua a farlo, un intenso e pregevole sforzo di ricomposizione del contenuto essenziale della nozione di “patrimonio culturale urbanistico”; un tentativo di autonomizzazione della nozione (soprattutto rispetto al genus degli “altri beni culturali”), che non guarda solo all’esterno, rispetto a categorie più generali o non coincidenti, ma anche all’interno, essendo necessario non appiattire il tutto su una parte, ossia sui centri storici, caratterizzati da un’intensa specificità[10].
È stato affermato, in sintesi, che il “patrimonio culturale urbanistico” [11] è costituito dal complesso di beni immobili (artificiali, naturali o misti) [12] oggetto di un giudizio di meritevolezza (nel quadro competenziale vigente) ai fini della loro salvaguardia, fondato sulla vocazione immateriale di tali beni, al di là della consistenza edilizia ed urbanistica, testimonianza di civiltà territoriale o espressione della storia e della identità culturale di una comunità regionale o locale; una meritevolezza che si pone, almeno in un momento storico dato, al di sotto della soglia (rectius, dello standard statale) della disciplina codicistica, essendo caratterizzata non da una logica di eccellenza ed eccezionalità nazionale ma da una logica di affectioterritoriale[13].
In altre parole può dirsi che “il patrimonio culturale urbanistico” è composto non soltanto da “beni culturali urbanistici” [14] (per i quali rileva, pur non necessariamente in via esclusiva, la testimonianza di civiltà[15]) ma anche da “beni paesaggistici residuali” [16] (per i quali rileva, pur non necessariamente in via esclusiva, l’espressione identitaria), intersecando così uno degli strati più ampi del “paesaggio”[17].
Ancora più puntualmente può ritenersi che i beni costitutivi di tale “patrimonio”, al di fuori della tipicità della normativa codicistica, abbiano spesso una dimensione sostanziale doppia o complessa, essendo contestualmente sia testimonianza di civiltà che espressione di identità culturale[18]; appare quindi coerente, in questo ambito ulteriore, superare la distinzione codicistica di regime giuridico tra beni culturali e beni paesaggistici -per i quali la nozione di “patrimonio culturale” (in senso stretto) rimane una mera sintesi verbale- per arrivare ad un altro “patrimonio culturale” (quello urbanistico), da intendersi come una sintesi di contenuti e di anime, da sottoporre ad un unico regime giuridico[19], per quanto, come si dirà, diffuso e diversificatosui territori.
In questa prospettiva -ricostruita in sede scientifica alla luce delle indicazioni rapsodiche provenienti dai legislatori (statali e regionali), dalle Amministrazioni locali in sede di pianificazione e dalla giurisprudenza (costituzionale e amministrativa[20])- tale patrimonio deve ritenersi sottratto agli strumenti speciali e tipici del Codice (dlgs. n. 42/2004) pretendendo cura e salvaguardia altrove, principalmente negli strumenti della urbanistica e del governo del territorio.
Tuttavia si ritiene necessario, al fine della maggiore stabilizzazione della suddetta nozione, indagarne il fondamento costituzionale, ossia una problematica rimasta in ombra o data per scontata, e con esso una nozione costituzionalmente conforme.
2. Il fondamento costituzionale del “patrimonio culturale urbanistico”
2.1. L’irrilevanza dell’art. 9, 2° comma, Cost.
In primo luogo è necessario chiedersi se il “patrimonio culturale urbanistico” possa trovare fondamento nella medesima disposizione costituzionale, che fornisce copertura al “patrimonio culturale” in senso stretto; in altre parole è necessario verificare se sia ammissibile un’interpretazione estensiva dell’art. 9, 2° comma, Cost., secondo cui la Repubblica “tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione” [21]. In questa prospettiva un patrimonio culturale (quello urbanistico) sarebbe attratto nell’altro (divenendone un elemento costitutivo, una sorta di terza categoria, ulteriore a quella dei beni paesaggistici e dei beni culturali).
La risposta è negativa. Il “patrimonio culturale urbanistico” non trova fondamento nell’art. 9, 2° comma, Cost[22].
La ragione ostativa però non risiede nella teoria dell’interposizione[23], alla luce della quale la Corte costituzionale, in alcuni casi, sembra presupporre, per irrigidimento, una sorta di corrispondenza tra l’alveo dell’art. 9, 2° comma, Cost. e il Codice dei beni culturali e del Paesaggio, derivandone quindi una portata escludente verso altri patrimoni. L’evocazione della tecnica parametrica della norma interposta, che peraltro appare impropria rispetto alla categoria classica come condizione di validità[24], rischia di assecondare un’alterazione del sistema delle fonti, attraverso la creazione di un blocco costituzionale statico, che si risolve in una sopravvalutazione (a modo di legge organica) del Codice rispetto agli altri atti legislativi statali. In realtà è necessario ritenere che esista uno spazio di non coincidenza tra l’art. 9, 2° comma, Cost. e il Codice[25], uno spazio fecondo di una portata evolutiva, sotto il profilo ermeneutico. Tuttavia non è questo lo spazio in cui si inserisce il “patrimonio culturale urbanistico”.
L’effettiva ragione che preclude una dilatazione dell’art. 9, 2° comma, Cost. e quindi la riconducibilità del “patrimonio culturale urbanistico” in tale alveo va rintracciata nella stessa matrice costituzionale unitaria del “paesaggio” e del “patrimonio storio e artistico”della“Nazione”[26]; tale matrice, che spiega l’“endiadi”[27], è essa escludente per il “patrimonio culturale urbanistico”, essendo “testimonianza materiale della civiltà e della cultura del Paese”[28], e quindi espressiva (non di una memoria particolare ma) della “memoria dell’intera comunità nazionale”[29], quale elemento costitutivo della forma di Stato; un patrimonio “italiano” formato quindi sia dal “paesaggio della Nazione”[30], ossia dall’ “intero territorio nazionale alla luce del valore estetico-culturale”[31], sia “da opere nate nel corso di oltre venticinque secoli nel territorio italiano e che nelle vicende del nostro Paese sono espressione e testimonianza”[32].
Nell’art. 9, 2° comma, Cost, per quanto rileva ai nostri fini, è la “Nazione” che perimetra e fonda il giudizio di meritevolezza sul “patrimonio culturale”, sia in relazione al paesaggio (e quindi ai beni identitari) che ai beni culturali (testimonianza di civiltà); il pluralismo istituzionale della “Repubblica” (art. 114 Cost.), che sotto il profilo soggettivo impone un governo multilivello del patrimonio culturale[33], presuppone l’ oggetto della tutela, espressivo della “Nazione” quale Stato-comunità[34], fondato su un contratto sociale-culturale, la cui causa è anche la sintesi della complessità dei beni, dei segni, dei valori paesaggistici-identitari e di quelli di testimonianza di civiltà; la Nazione esprime quindi, in termini identitari, il legame tra il “paesaggio” e il “patrimonio storico-artistico” con la cultura, la storia e le tradizioni del popolo italiano[35], configurando tali elementi come “fattori unificanti” da “preservare” e “animare”[36].
Tale giudizio di meritevolezza sui beni (materiali e immateriali) espressivi della comunità nazionale, quanto ai presupposti normativi e alla disciplina dei procedimenti amministrativi di apposizione dei vincoli, appartiene all’indirizzo politico, a cui spetta interpretare la Nazione[37], postulando “l’oggettiva storicità del patrimonio culturale, la sua sedimentazione nella coscienza collettiva e l’avvenuta oggettivazione del giudizio”[38].
Sono quindi riconducibili nell’alveo dell’art. 9, 2° comma, Cost. e quindi nel patrimonio culturale della Nazione [39] in senso stretto solo alcuni beni immobili[40].
In questa prospettiva “il collegamento con il territorio e la sua memoria non è orientato alla frammentazione localistica”[41].
Non può negarsi, infatti, come la Nazione “esprime, nei testi costituzionali contemporanei, soprattutto l’esigenza di riduzione ad unità della complessità sociale che si riflette nelle istituzioni; riduzione ad unità di cui, come detto, il diritto costituzionale ed il diritto amministrativo hanno talvolta necessità al fine di omogeneità della disciplina giuridica o per offrire un’adeguata rappresentazione giuridica dell’interesse generale o dell’indirizzo politico”[42]. In altre parole la Nazione è la stessa capacità culturale di cui è capace un popolo organizzato in sovranità nazionale[43].
In questi termini la tutela del patrimonio culturale è espressione di una decisione politica sottratta alle autonomie e al governo del territorio.
2.2. L’art. 9, 1° comma, Cost. quale clausola aperta della Costituzione culturale: i “patrimoni culturali urbanistici”
Per le suddette ragioni il fondamento costituzionale del “patrimonio culturale urbanistico” va trovato altrove e specificatamente nell’art. 9, 1° comma, Cost. in combinato con altre disposizioni costituzionali contenute tra i “Principi fondamentali”.
Più specificatamente l’art. 9, 1° comma, Cost., secondo cui la Repubblica “promuove lo sviluppo della cultura”[44], legittima, ai fini del progresso spirituale e materiale dei consociati, la promozione e la salvaguardia (al di là dell’asse tipico tutela-valorizzazione) di quei beni e quindi di quei patrimoni ulteriori (anche nella loro vocazione immateriale), espressivi di un diverso giudizio di meritevolezza, ancorato, in una prospettiva di pluralismo culturale, ad una dimensione territoriale (regionale o locale)[45]; un giudizio sociale di meritevolezza, proveniente dal basso, in una logica di sussidiarietà e di prossimità culturale, recepibile e positivizzabile, come diremo, da parte dei legislatori regionali (art. 117 Cost.) e dei Comuni in sede amministrativa e regolamentare (art. 118 Cost., 117, 6° comma, Cost.), e avente ad oggetto valori testimoniali di civiltà e segni identitari subnazionali , appartenenti alla storia e alla identità delle comunità regionali e locali, ossia alle autonomie (art. 5 Cost.) o a frazioni di esse (art. 2 Cost.).
In sintesi l’art. 9, 1° comma, Cost. promuovendo la cultura, legittima la salvaguardia di un patrimonio ulteriore, da selezionare[46], espressivo di una “memoria particolare”[47], oggetto di uno specifico riconoscimento, aderente a una dimensione diversa da quella nazionale[48]; la salvaguardia di tale patrimonio, attraverso la garanzia della fruizione da parte dei singoli, è strumentale contestualmente al rafforzamento della appartenenza ad una certa comunità e alla formazione dei singoli, in nome del pluralismo culturale-territoriale, posto che la cultura deve essere intesa come “ciò che la il bene culturale trasmette ai suoi fruitori”[49].
Il modello sotteso dall’art. 9, 2° comma, Cost., in cui la Nazione (la dimensione oggettiva, in una logica valoriale) funzionalizza la Repubblica (la dimensione soggettiva), alla ricerca deontica di una sintesi e di un equilibrio, lascia il campo al modello dell’art. 9, 1° comma, Cost., in cui, ai nostri fini, le comunità territoriali e le formazioni sociali (una diversa dimensione oggettiva, in una logica valoriale) esprimono un’esigenza di autonomia culturale e quindi di pluralismo culturale[50], quale elemento costitutivo della Repubblica, non necessariamente bisognoso di sintesi, rectius, al di là (o, se si vuole, al di sotto) di quella sintesi presupposta dall’art. 9, 2° comma, Cost. (ferma comunque l’unità ordinamentale affermata dallo stesso art. 5 Cost., entro il quale i suddetti patrimoni ulteriori trovano riconoscimento).
In questa prospettiva l’art. 9, 1° comma, Cost. assume la funzione di paradigma culturale dell’art. 5 Cost., mettendo in intima connessione il pluralismo culturale con il pluralismo istituzionale[51]; tuttavia imprimendo sul pluralismo istituzionale una traiettoria diversa rispetto a quella che tale pluralismo percorre verso l’attuazione dell’art. 9, 2° comma, Cost.; un pluralismo (non per il patrimonio nazionale ma) per i patrimoni territoriali[52]. Più in generale può dirsi quindi non soltanto che l’art. 9, 1° comma, Cost. è il fine di uno strumento tipizzato dalla Costituzione (art. 9, 2° comma, Cost.) - secondo una prospettiva di strumentalità e circolarità da tempo evidenziata in dottrina [53] - ma anche la fonte costituzionale legittimante la costituzione di ulteriori strumenti (di “governo del territorio”) a salvaguardia di ulteriori patrimoni, operando così come una clausola aperta della Costituzione culturale[54].
La Costituzione culturale, attraverso tale clausola aperta, legittima così le Regioni e gli Enti locali, nei limiti delle proprie competenze (nel governo del territorio), all’esercizio dei propri poteri funzionali, espressione di un autonomo indirizzo politico relativo alle esigenze espresse dalla collettività di riferimento, a salvaguardare il “patrimonio culturale urbanistico” e a garantirne il diritto alla fruizione[55], quale diritto costitutivo della stessa Costituzione culturale, enucleabile alla luce degli artt. 2, 3 e 9, 1° comma, Cost. e funzionale allo sviluppo della personalità[56], intesa come identità [57] e appartenenza ad una comunità “minore”.
Pertanto come dalla tutela del patrimonio storico artistico della Nazione, in quanto essenziale per la protezione del cittadino, si fa derivare una sfera soggettiva a tutela della personalità che “sia inclusiva della sua identità individuale e collettiva”[58], così, analogamente, dal riconoscimento del “patrimonio culturale urbanistico” può farsi derivare una sfera soggettiva a tutela delle identità minori.
Più in generale il riconoscimento dei patrimoni culturali urbanistici e la salvaguardia del diritto alla fruizione di essi si risolvono così nell’attuazione del più generale diritto alla diversità culturale[59].
In questa logica è la cultura che conforma, orienta [60] e funzionalizza l’urbanistica, pretendendo da essa che operi davvero come governo del territorio, quale ambito materiale idoneo a disciplinare un patrimonio culturale complementare rispetto a quello nazionale.
Questo quadro trova conferma nella stessa giurisprudenza costituzionale, che da tempo ha messo in evidenza, andando al di là della dimensione nazionale (art. 9, 2° comma, Cost.), la connessione tra cultura, promozione della cultura, salvaguardia dei beni espressivi della identità (anche) locale: “anche per quanto si desume da altri precetti costituzionali, lo Stato deve curare la formazione culturale dei consociati alla quale concorre ogni valore idoneo a sollecitare e ad arricchire la loro sensibilità come persone, nonchè il perfezionamento della loro personalità ed il progresso anche spirituale oltre che materiale. In particolare, lo Stato, nel porsi gli obiettivi della promozione e dello sviluppo della cultura, deve provvedere alla tutela dei beni che sono testimonianza materiale di essa ed assumono rilievo strumentale per il raggiungimento dei suddetti obiettivi sia per il loro valore culturale intrinseco sia per il riferimento alla storia della civiltà e del costume anche locale; deve, inoltre, assicurare alla collettività il godimento dei valori culturali espressi da essa”[61].
In conclusione può dirsi quindi che la “cultura” (art. 9, 1° comma, Cost.), e più specificatamente il principio del pluralismo culturale, modella il “governo del territorio”, imponendo che in tale ambito i legislatori regionali (art. 117, 3° comma, Cost.) e i Comuni (art. 118 e 117, 6° comma, Cost.) costruiscano poteri amministrativi a salvaguardia del “patrimonio culturale urbanistico”, innanzi al quale i suddetti diritti culturali (art. 2, 3, 9, 1° comma, Cost.) assumono prevalentemente la forma di interessi legittimi costituzionali o fondamentali [62] (art. 2, 24 Cost.). In senso speculare tali poteri devono dare attuazione alla Costituzione culturale (“non v’è dubbio che tra i valori che gli strumenti urbanistici devono tutelare abbiano rilevanza non secondaria quelli artistici, storici, documentari e comunque attinenti alla cultura nella polivalenza di sensi del termine ”[63]); ossia, come è stato efficacemente detto, al “valore culturale della prossimità” [64] e quindi al valore dell’“essere di quel luogo”[65].
Questo modello, espressivo del pluralismo, può far parlare di “patrimoni culturali urbanistici” (ulteriori rispetto ad un unico “patrimonio culturale” nazionale).
Una nozione che certamente trova un’eco nell’anima localistica, identitaria e sociale, rispettivamente sotto il profilo paesaggistico (“quotidiano”) e dell’eredità culturale, nella Convenzione europea del paesaggio [66] e nella Convenzione di Faro[67], pur nei limiti della natura giuridica di tali atti.
Peraltro i “patrimoni culturali urbanistici” potrebbero trovare un ausilio costituzionale nelle stesse potenzialità ermeneutiche contenute nell’art. 9, 3° comma, Cost.[68], nella parte in cui richiama, pur limitatamente alla dimensione ambientale, l’“interesse delle future generazioni”. Tale riferimento intergenerazionale potrà risultare fecondo in senso trasversale sia per l’art. 9, 2° comma, Cost. sia, per quanto rileva, per l’art. 9, 1° comma, Cost., legittimando la salvaguardia dei “patrimoni culturali urbanistici” [69] anche per le generazioni territoriali future[70]. Tale prospettiva peraltro sembra già valorizzata e anticipata dalla giurisprudenza costituzionale, in materia di rigenerazione urbana, che ha affermato (prima della stessa riforma costituzionale) una nuova concezione culturale di territorio: “ considerato non più solo come uno spazio topografico suscettibile di occupazione edificatoria ma rivalutato come una risorsa complessa che incarna molteplici vocazioni (ambientali, culturali, produttive, storiche) e, dall’altro, è avvertita sul fatto che il consumo di suolo rappresenta una delle variabili più gravi del problema della pressione antropica sulle risorse naturali.
La legge regionale quindi, nelle sue finalità generali, dimostra di inserirsi in un processo evolutivo diretto a riconoscere una nuova relazione tra la comunità territoriale e l’ambiente che la circonda, all’interno della quale si è consolidata la consapevolezza del suolo quale risorsa naturale eco-sistemica non rinnovabile, essenziale ai fini dell’equilibrio ambientale, capace di esprimere una funzione sociale e di incorporare una pluralità di interessi e utilità collettive, anche di natura intergenerazionale ”[71].
Alla luce della suddetta trama costituzionale può ritenersi necessario (i) riconoscere i “patrimoni culturali urbanistici” delle comunità territoriali, (ii) disciplinarne gli strumenti di salvaguardia, (iii) garantire alle comunità di riferimento la effettiva fruizione .
In altre parole un modello di tutela, diverso da quello tipico-codicistico, perché “diffuso” e “a tappeto”[72].
2.3. I “patrimoni culturali urbanistici” come beni a vocazione minoritaria
Dalla valorizzazione del principio pluralista e dalla distinzione rispetto al “patrimonio culturale” discende la qualificazione dei beni dei “patrimoni culturali urbanistici” come beni “minori” o a vocazione “minoritaria”[73], in una prospettiva aderente alla comunità espressiva del giudizio di meritevolezza: beni quindi con una vocazione minoritaria aderente non soltanto alla dimensione territoriale, nella sua prospettiva storica e identitaria (art. 5, 9, 1° comma, Cost.) ma anche, in ipotesi, alla dimensione religiosa [74] (art. 2, 19 Cost.), linguistica [75] (art. 2, 6 Cost.) o socio-economica (art. 2, 41 Cost.).
Non può negarsi però come nella giurisprudenza costituzionale, che ha riconosciuto, pur con un percorso non sempre coerente, la categoria degli “altri beni” culturali (necessaria ai fini della ricostruzione di quella dei “patrimoni culturali urbanistici”) sia maggiormente valorizzata, in senso onnicomprensivo, la dimensione territoriale, quale espressione della identità culturale, ossia il “contesto locale”[76].
La Corte costituzionale, dopo l’importante affermazione del 1990, già richiamata (nella quale vi è un riferimento espresso al “valore culturale intrinseco sia per il riferimento alla storia della civiltà e del costume anche locale”[77] ), ha ribadito, nelle difficili trame del regionalismo, l’autonomia della categoria degli “ altri beni cui, a fini di valorizzazione, possa essere riconosciuto particolare valore storico o culturale da parte della comunità regionale o locale , senza che ciò comporti la loro qualificazione come beni culturali ai sensi del d. lgs. n. 490 del 1999 e la conseguente speciale conformazione del loro regime giuridico” [78]; beni che si trovano “a far parte di un territorio avente una propria conformazione e una propria storia”[79]; “la circostanza, infatti, che una specifica cosa non venga “classificata” dallo Stato come di «interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico», e dunque non venga considerata come «bene culturale», non equivale ad escludere che essa possa, invece, presentare, sia pure residualmente, un qualche interesse “culturale” per una determinata comunità territoriale: restando questo interesse ancorato, in ipotesi, a un patrimonio identitario inalienabile, di idealità e di esperienze e perfino di simboli, di quella singola e specifica comunità” [80]; beni che sono “altre espressioni di una memoria “particolare”, coltivata in quelle terre da parte di quelle persone, con le proprie peculiarità e le proprie storie”[81].
2.4. La mobilità dei “patrimoni culturali urbanistici” verso la Nazione
Il discrimine tra dimensione nazionale e territoriale (o se si vuole tra memoria nazionale e territoriale), ai fini del riconoscimento dei “patrimoni culturali urbanistici” necessita di una precisazione.
In realtà l’assunto, desumibile anche dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui taluni beni sono espressione della storia e dell’identità culturale della comunità territoriale, non fornisce un parametro qualificante certo o comunque non costituisce una condizione sufficiente ai fini della riconducibilità nell’alveo dei “patrimoni culturali urbanistici”.
Nella prospettiva del costituzionalismo moderno, infatti, il multiculturalismo è un elemento costitutivo della Nazione. Anche il “patrimonio culturale” nazionale può dirsi costituito da beni espressivi della storia e delle identità minori, pur divenuti e ritenuti coessenziali per la costruzione identitaria nazionale. In questi termini è stato affermato che “in ragione della storia nazionale, il territorio italiano, è infatti, per ideali cerchi concentrici e per pluralità di tradizioni e di scuole storiche-artistiche, o architettoniche la sommatoria di quelli locali , che concorrono in modo nazionalizzante alla definizione di un patrimonio unitario, che la riassume”[82]; in senso analogo può dirsi che anche il riferimento codicistico (art. 1, 2° comma, dlgs. n. 42/2004) alla “memoria della comunità nazionale” evidenzia il risultato di “sintesi, che, sul piano dell’identità nazionale, contribuiscono a formare i variegati apporti culturali delle diverse componenti della collettività repubblicana”[83].
Tale prospettiva può certamente dirsi assecondata, quanto alla dimensione paesaggistica, anche dalla Convenzione europea del paesaggio[84].
Pertanto la qualificazione in termini di “patrimoni culturali urbanistici” assume una portata residuale, rispetto alla suddetta sintesi nazionale, per quanto, come si vedrà, non subordinabile a un accertamento negativo espresso da parte dello Stato[85]; in questa prospettiva quindi parallelae ulteriore.
In altre parole perché taluni beni, espressione della storia e dell’identità culturale della comunità territoriale, siano qualificabili come “patrimoni culturali urbanistici” è necessario che essi non siano stati attratti nella dimensione nazionale del patrimonio culturale in senso stretto.
Tuttavia la stessa esclusione dal “patrimonio culturale” nazionale non può dirsi pietrificata[86].
La Nazione, intesa come comunità identitaria, nel quadro delle democrazie pluraliste, in cui la cultura è fattore di integrazione e di inclusione socio-economica, assume, infatti, un valore dinamico, nella storia.
In tale traiettoria potenzialmente inclusiva può dirsi che gli altri patrimoni, diversi da quello culturale nazionale (così come ricomponibile in un momento storico), non sono estromessi in via definitiva dalla copertura dell’art. 9, 2° comma, Cost.
L’emersione costituzionale dei “patrimoni culturali urbanistici”, attraverso la clausola aperta dell’art. 9, 1° comma, Cost., può rappresentare diacronicamente una tappa eventuale di riconoscimento e di attrazione nella dimensione nazionale, attraverso una previsione legislativa espressa o, per alcuni beni immobili (art. 10, 4° comma, lett. f), g) - art. 136, 1° comma, lett. a-d, dlgs. n. 42/2004), attraverso un procedimento amministrativo; un percorso di elevazione che segue le sorti evolutive dell’identità nazionale, come ricomposta dalle scelte espressione dell’indirizzo politico.
Tale mobilità rappresenta il punto di equilibrio della forma di stato culturale, tra unità e pluralismo[87].
3. Il riparto di competenze legislative: il “governo culturale del territorio”
3.1. I titoli competenziali inconferenti
Fermo il suddetto quadro costituzionale, non può negarsi come la ricostruzione in concreto del contenuto dei “patrimoni culturali urbanistici” dipenda dalla delimitazione dei rapporti di competenza tra Stato e Regioni[88].
Per quanto la Corte costituzionale abbia sistematicamente ribadito che lo sviluppo della cultura corrisponde a “finalità di interesse generale il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni”[89], “al di là del riparto di competenze per materia tra Stato e Regioni”[90], anche in questo ambito, senza eccezione alcuna rispetto alle vicende attuative del Titolo V, la giurisprudenza costituzionale si è sviluppata intorno alla delimitazione dell’intervento legislativo regionale “al fine di delineare se e a quali condizioni le Regioni possano integrare la normativa in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio con misure diverse e aggiuntive rispetto a quelle previste a livello statale”[91].
Al di là dell’analisi delle singole pronunce, che in realtà hanno avuto ad oggetto soprattutto la categoria più generale degli altri beni culturali, appare necessario ricomporre il quadro delle competenze intorno ai “patrimoni culturali urbanistici”.
In primo luogo deve escludersi che tali patrimoni possano essere attratti in modo bulimico nell’alveo della competenza legislativa statale ex art. 117, 2° comma, let. s (“tuteladell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”)[92], posto che esiste una intima connessione[93], pur problematicamente coordinata[94], tra la dimensione nazionale di cui all’art. 9, 2° comma, Cost, come sopra ricostruito, e tale ambito materiale legislativo (al di là dell’ulteriore anima teleologica e finalistica[95], quindi trasversale[96], della materia stessa); in sintesi, come noto, i titoli competenziali (art. 117, 2° comma, let. s) “tutela dell’ambiente” (da leggersi, per continenza, secondo la giurisprudenza costituzionale, anche come “tutela del paesaggio”[97]) e “tutela dei beni culturali” coprono le due anime del patrimonio culturale nazionale (art. 9, 2° comma, Cost.), quindi sia la dimensione del “paesaggio” nazionale sia quella del “patrimonio storico artistico” nazionale, ovvero, con le parole del Codice, sia i “beni paesaggistici” che i “beni culturali” (art. 2, 1° comma, Dlgs. n. 42/2004).
I beni a vocazione minoritaria, espressione delle dimensioni culturali territoriali, si pongono, invece, al di fuori di tale ambito, come sopra ricostruito.
Analogamente non pare che possa venire in rilevo in via diretta neppure l’art. 117, 2° comma, let. m), pur suggestivamente valorizzato dalla dottrina in relazione al decoro architettonico, al recupero della identità dei luoghi, alla dignità abitativa e alla qualità della vita nelle città[98], posto che la configurazione dei livelli essenziali in termini quantitativi, nella giurisprudenza costituzionale, mal si attaglia alla tutela dei “patrimoni culturali urbanistici”.
In realtà non potrebbe ritenersi invocabile, a stretto rigore, neppure la competenza legislativa concorrente “ valorizzazione dei beni culturali e ambientali” (art. 117, 3° comma, Cost.), che pure sembra essere stata desunta dalle parole della Corte costituzionale in materia di locali storici[99].
Anche tale titolo competenziale deve ritenersi ancorato all’art. 9, 2° comma, Cost. e con esso al patrimonio culturale nazionale[100].
La stessa Corte costituzionale nella pronuncia citata, che ha rigettato un ricorso statale avverso una legge regionale in materia di “tutela e valorizzazione dei locali storici” (per violazione dell’art. 117, 2° comma, let. s), non ha espressamente legittimato l’intervento regionale sulla base dell’art. 117, 3° comma, Cost., risolvendo la vicenda attraverso una prospettiva focalizzata sul bene-oggetto dell’intervento legislativo (diverso dai “beni culturali” in senso stretto); in tale occasione la Corte, pur parlando fugacemente di valorizzazione, quale fine della normativa regionale, ha riconosciuto la configurabilità della categoria degli “altri” beni culturali, senza espressamente individuare un titolo competenziale, tanto che è stato finanche sostenuto che si tratti di una materia innominata di competenza residuale [101] (art. 117, 4° comma, Cost.), al di là dell’asse tutela-valorizzazione [102] (art. 117, 2° comma, let. s – art. 117, 3° comma, Cost.).
Peraltro, ai nostri limitati fini, in una già richiamata prospettiva di distinzione tra altri beni e patrimoni culturali urbanistici, l’evocazione del titolo “ valorizzazione dei beni culturali e ambientali” (art. 117, 3° comma, Cost.) si risolverebbe in uno svuotamento del contenuto e della specificità costituzionale del “governo del territorio” (art. 117, 3° comma, Cost.), di cui si dirà a breve, quale dimensione costituzionale propria.
In questa prospettiva non pare quindi neppure utile insistere nella direzione della competenza residuale [103] (art. 117, 4° comma, Cost.), posto che si rischierebbe di assistere a una smaterializzazione [104] analoga a quella emersa nella giurisprudenza costituzionale, anche in una logica di limitazione degli spazi dell’autonomia regionale[105], in relazione ad ambiti come quello dell’“edilizia residenziale pubblica”, dei “lavori pubblici” o delle “espropriazioni”[106].
3.2. Il “governo del territorio” in attuazione dell’art. 9, 1° comma, Cost.
Pertanto i “patrimoni culturali urbanistici” devono essere ricondotti nell’alveo del “governo del territorio” (art. 117, 3° comma, Cost.), pretendendo che tale materia si riappropri della vocazione espansiva , così come costituzionalizzata in sede di revisione costituzionale (l. cost. n. 3/2001), a seguito di una lunga e complessa traiettoria di emersione, prima di essere compressa e relegata, nelle dinamiche del regionalismo, a dimensione recessiva[107].
Non può negarsi come nella stessa giurisprudenza costituzionale siano rinvenibili tracce di tale legittimazione competenziale, pur mitigate e relativizzate in pronunce successive.
La Corte costituzionale[108], infatti, ha rigettato un ricorso statale proposto, per asserita violazione dell’art. 117, 2° comma let. s), contro una normativa regionale, avente ad oggetto “Norme per il governo del territorio”, recante una disciplina del Piano di assetto del territorio, secondo la quale un tale piano, previa analisi di manufatti e spazi liberi esistenti nei centri storici, possa determinare le categorie in cui gli stessi devono essere raggruppati per caratteristiche tipologiche, attribuendo così specifici valori di tutela e quindi individuando per ogni categoria gli interventi e le destinazioni d’uso ammissibili. In tale occasione è stato affermato che il legislatore statale non ha stabilito nuovi criteri di identificazione di beni culturali ma ha previsto che “nella disciplina del governo del territorio– e quindi per quanto concerne le peculiarità di questa –si tenga conto non soltanto dei beni culturali identificati secondo la normativa statale, ma eventualmente anche di altri, purché però essi si trovino a far parte di un territorio avente una propria conformazione e una propria storia”[109].
In questa logica la disciplina regionale, nei limiti dell’art. 117, 3° comma, Cost., “è in funzione di una tutela non sostitutiva di quella statale, bensì diversa ed aggiuntiva, da assicurare nella predisposizione della normativa di governo del territorio, nella quale necessariamente sono coinvolti i detti beni”[110]. Tale assunto è stato espressamente ribadito in una successiva pronuncia: “sul punto, appare opportuno premettere che questa Corte ha già avuto modo di affermare che la tutela dei beni culturali costituisce un ambito materiale di competenza legislativa statale, con possibilità per le Regioni di integrare la relativa normativa con misure diverse ed aggiuntive rispetto a quelle previste a livello statale (vedi, tra le altre, la sentenza numero 232 del 2005)”[111].
Da questa giurisprudenza emerge così il riconoscimento della competenza legislativa regionale a disciplinare, nell’ambito del “governo del territorio” anche beni non “identificati” dalla normativa statale (in realtà non soltanto codicistica), da intendersi come beni non identificati dalla legge o sulla base della legge con provvedimento amministrativo.
Una prospettiva ulteriore, di ampliamento delle tutele [112] e più specificatamente di una tutela ulteriore [113] (non quindi di mera valorizzazione) al di là dello standard statale.
Tuttavia deve essere precisato il rapporto tra tutela regionale (nell’ambito del governo del territorio) e tutela statale; in particolar modo è necessario chiarire cosa debba intendersi per tutela “aggiuntiva”.
Nella pronuncia citata [114] la Corte costituzionale, attraverso un parallelismo sulla natura delle materie-attività (tutela dell’ambiente/tutela dei beni culturali – art. 117, 2° comma, Cost.)[115], riconosce, in intesi, ribadendo un assunto generale (mutuato dalla dimensione ambientale[116]), che le Regioni sono legittimate, nell’ambito del “governo del territorio”[117], a derogare in meliuso comunque a innalzare il livello di protezione rispetto allo standard statale [118] (fissato a tutela del patrimonio culturale), prevedendo quindi una tutela ulteriore (nel caso di specie per quei beni che definiamo “patrimoni culturali urbanistici”); in altre parole la configurazione di una logica incrementale [119] delle tutele che opera sempre per “addizione e, mai, per sottrazione”[120].
In questa logica la Corte sembra affermare che l’art. 117, 2° comma, let. s), in relazione al caso deciso, non fonda una legittimazione regionale “diretta” (quale competenza di implementazione e integrazione degli standardstatali ex art. 117, 2° comma, let. s), idonea a sviluppare “ulteriori esigenze” di tutela per il patrimonio nazionale ma fonda una legittimazione “indiretta” (quale competenza implicitamente desumibile dalle competenze regionali ex art. 117, 3° e 4° comma, Cost.), idonea a tutelare in sede di disciplina degli “interessi funzionalmente collegati” [121] (e quindi gli altri patrimoni).
Si tratterebbe in questa prospettiva di una tutela “aggiuntiva” (aderente alle competenze legislative limitrofe), nella prospettiva della Corte costituzionale.
In realtà in questo ambito il richiamo all’art. 117, 2° comma, Cost. let. s) e al modello degli standard sembra non del tutto applicabile[122].
A nostro avviso non soltanto non viene in rilievo una legittimazione “diretta” (di implementazione degli standard di tutela del patrimonio nazionale) ma neppure una legittimazione “indiretta” (in aggiunta allo standard statale). Tale prospettiva, infatti, presuppone che l’oggetto della tutela sia il medesimo (l’ambiente o il patrimonio culturale nazionale ex art. 117, 2° comma, let. s) Cost.), rispetto al quale misurare una tutela ulteriore regionale[123]. Nel nostro caso, invece, l’oggetto della tutela è diverso, posto che i “patrimoni culturali urbanistici” non sono riconducibili nell’alveo dell’art. 9, 2° comma, Cost. e dell’art. 117, 2° comma, let. s), come sopra ricostruito.
La tutela apprestata dal “governo del territorio” quindi può dirsi certamente “diversa” ma non “aggiuntiva”, se mai parallela . Il “governo del territorio”, in questo ambito, in relazione a beni diversi da quelli di cui all’art. 9, 2° comma, Cost., non dialoga (in via incrementale) con l’art. 117, 2° comma, let. s) ma attua direttamente , quale fine proprio e interno, l’art. 9, 1° comma, Cost.[124], facendosi “governo culturale del territorio”.
Questa prospettiva di autonomizzazione appare utile peraltro a sottrarre la tutela dei “patrimoni culturali urbanistici” a quella giurisprudenza costituzionale che, relativizzando la logica incrementale, dichiara la illegittimità costituzionale di normative regionali derogatorie in melius sul presupposto che la normativa statale esprima un “punto [fermo/non derogabile] di equilibrio tra molteplici interessi”[125], pur nella consapevolezza del rispetto, per presupposizione, della tutela del patrimonio culturale[126].
La configurazione di un “governo culturale del territorio” è un corollario della Costituzione culturale.
Nella stessa giurisprudenza costituzionale, al di là delle contraddizioni che hanno relegato la materia nella sua debolezza, alla luce di contro-limiti ermeneutici costruiti dalla giurisprudenza costituzionale[127], si afferma che la disciplina del potere di pianificazione urbanistica “non è funzionale solo all’interesse all’ordinato sviluppo edilizio del territorio (…), ma è rivolto anche alla realizzazione contemperata di una pluralità di differenti interessi pubblici, che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti ”[128].
In questa prospettiva i “patrimoni culturali urbanistici” diventano il punto di sintesi di quella funzionalizzazione dell’urbanistica, che si fa governo del territorio, ossia “un terreno diverso da quello tradizionale che vede opposto il diritto urbanistico a quello dei beni culturali, consentendo, invece, un’osmositra i due ambiti disciplinari”[129]; una traiettoria culturale che necessita di fiducia nelle autonomie, al di là delle paure (autorevolmente espresse in relazione al patrimonio nazionale) di dissolvimento per incapacità tecnica e politica[130], tenuto conto che la conservazione e la valorizzazione di tali patrimoni costituisce una “opportunità” per “migliorare la qualità della vita, per qualificare maggiormente i processi educativi, per sviluppare la mobilità e il turismo, per definire compiutamente l’identità di una comunità locale ”[131], ossia uno strumento, come già detto, di attuazione dei diritti culturali (art. 2 Cost.). In altre parole, o con le parole della giurisprudenza ammnistrativa, che ha valorizzato al meglio l’anima costituzionale del “governo del territorio”, una programmazione dello sviluppo complessivo e armonico del territorio che tenga conto “sia delle potenzialità edificatorie dei suoli (…) sia di valori ambientali e paesaggistici, sia in definitiva del modello di sviluppo che si intende imprimere ai luoghi stessi in considerazione della loro storia, tradizione, ubicazione e di una riflessione de futuro sulla propria stessa essenza ” [132] con la partecipazione delle comunità di riferimento; una attività pianificatoria quindi funzionalmente rivolta “alla realizzazione contemperata di una pluralità di interessi pubblici , che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti ”[133].
Spetta quindi al “governo del territorio” assecondare il “processo evolutivo diretto a riconoscere una nuova relazione tra la comunità territoriale e l’ambiente che la circonda, all’interno della quale si è consolidata la consapevolezza del suolo quale risorsa naturale eco-sistemica non rinnovabile, essenziale ai fini dell’equilibrio ambientale, capace di esprimere una funzione sociale e di incorporare una pluralità di interessi e utilità collettive, anche di natura intergenerazionale ”[134].
A questi fini, per evitare che “il governo del territorio” rimanga un guscio “vuoto” [135] (o meglio che si appiattisca sull’urbanistica e sull’edilizia, ossia sul proprio nucleo essenziale, come mera disciplina fisica) e per garantire che in esso siano valorizzate tutte le dimensione ulteriori, funzionali alla salvaguardia dei “patrimoni culturali urbanistici”, appare necessario non ragionare per politiche pubbliche ma per materie; l’autonomia del “governo del territorio”, e con essa la vocazione a farsi “governo culturale del territorio” per i patrimoni culturali urbanistici, passa anche attraverso il superamento, almeno nelle trame della conflittualità costituzionale Stato-Regioni, della categoria delle politiche pubbliche. Le politiche pubbliche “sono rivolte ad obiettivi, si volgono per programmi, mentre le materie “sono etichette che contrassegnano settori, ambiti, argomenti, destinati ad essere oggetto di una disciplina”[136]. Probabilmente l’uso della categorie delle politiche pubbliche non farebbe altro che accentuare la indeterminatezza del contenuto del “governo del territorio”, che sino ad ora ha assecondato, nella giurisprudenza costituzionale, la stessa recessività materiale (gerarchica, per specialità e funzionale) e la propria residualità rispetto a tutti gli ambiti competenziali limitrofi (art. 117, 2°, 3° e 4° comma, Cost.) [137] , tanto da potersi sostenere che esiste una scissione tra la nozione legislativa e la nozione amministrativa di “governo del territorio”[138].
Tale prospettiva complessiva evita così di risolvere la tutela dell’ordinamento in favore “solamente di alcuni pezzi di paese altamente simbolici, con l’inaccettabile risultato di lasciare per contro in ombra” [139] la complessità degli altri patrimoni.
3.3. I principi fondamentali statali e la normativa regionale di dettaglio
La dottrina ha anche individuato degli specifici principi fondamentali del “governo del territorio” relativi alla disciplina dei “patrimoni culturali urbanistici”, quindi principi fondamentali in materia di “governo culturale del territorio”.
Si pensi al contenuto dell’art. 7 l. n. 1150/192, come modificato dall’art. 1, 5° comma, l. n. 1187/1968, secondo cui “ Il piano regolatore generale deve considerare la totalità del territorio comunale.
Esso deve indicare essenzialmente: (…)
2) la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;
(…)
5) i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico ”.
In modo conforme il D.M. 2.4.1968 n. 1444, sugli standard urbanistici, ha definito come zone territoriali omogenee A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o particolare pregio ambientale o da porzioni di esse[140].
Questa normativa è stata interpretata dalla giurisprudenza amministrativa nel senso che la pianificazione urbanistica comunale deve recare una specifica considerazione di “altri” beni di interesse storico, artistico, archeologico o paesaggistico, indipendentemente dalla loro soggezione alla tutela tipica dei beni culturali e del paesaggio, non potendo quindi avere una natura meramente “ricognitiva” [141] di vincoli provenienti da altre amministrazioni.
Tali principi, in assenza di (nuovi) principi fondamentali contenuti nella legislazione successiva alla riforma del Titolo V, devono ritenersi ancora vigenti, quale quadro di riferimento per l’autonomia regionale.
La stessa giurisprudenza costituzionale, appena successiva alla riforma costituzionale del Titolo V, ha affermato in modo chiaro che“specie nella fase della transizione dal vecchio al nuovo sistema di riparto delle competenze, la legislazione regionale concorrente dovrà svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali comunque risultanti dalla legislazione statale già in vigore”[142]; in termini è stato ribadito, proprio in relazione agli altri beni culturali, che “quanto all'altro rilievo di costituzionalità, relativo alla mancanza di una normativa statale di determinazione dei principi fondamentali della materia ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost., questa Corte ha già chiarito nella sentenza n. 282 del 2002 che le Regioni, per poter esercitare le proprie potestà legislative di tipo concorrente, non devono attendere l'eventuale determinazione dei principi fondamentali da parte dello Stato”[143].
In questo quadro si è mossa la legislazione regionale di dettaglio, per quanto spesso arrestandosi ad affermazioni scarsamente precettive [144] (e non citando in premessa, in modo espresso, l’art. 9,1 ° comma, Cost.), quindi non sfruttando a pieno le potenzialità della materia nell’interesse delle proprie comunità di riferimento[145].
Deve peraltro essere segnalato, solo per completezza, come la normativa regionale in materia debba comunque rispettare anche gli altri principi fondamentali del governo del territorio, non potendo, in nome della vocazione culturale, scardinare la logica concorrente (art. 117, 3° comma, Cost.); si rammenta come la Corte costituzionale di recente abbia dichiarato illegittima una disposizione regionale (art. 40 bis “Disposizioni relative a immobili costitutivi della memoria e dell’identità storico-culturale del territorio” della L.R.V. n. 11/2004) nella parte in cui inseriva tale articolo, limitatamente alla previsione dell’esonero del contributo di costruzione (art. 16 DPR n. 380/2001), nelle ipotesi di cambio di destinazione d’uso con aumento di valore degli immobili costitutivi della memoria e dell’identità storico-culturale del territorio[146].
3.4. Il principio di leale collaborazione a tutela dei patrimoni: il coordinamento degli “strati”
Il principio di leale collaborazione, tra Stato e Regioni, può trovare un proprio spazio applicativo anche nell’ambito ulteriore dei “patrimoni culturali urbanistici”.
In altre parole non può escludersi un’utilità di coordinamento, non solo sotto il profilo delle funzioni amministrative, tra la tutela statale del patrimonio culturale e la tutela dei “patrimoni culturali urbanistici”.
L’autonomizzazione della materia “governo culturale del territorio” e quindi la emersione degli altripatrimoni, rispetto a quello statale, non possono legittimare, infatti, uno scollamento o una contrapposizione[147], essendo necessario, in una ottica costituzionalmente complessa, pensare ad un patrimonio culturale (anch’esso a) a strati, costituito da uno strato nazionale (art. 9, 2° comma, Cost.) e una pluralità di strati territoriali (art. 9, 1° comma, Cost.), connessi e coordinati.
Non vi è dubbio che l’art. 118, 3° comma, Cost., secondo cui “la legge statale (…) disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali”, affermi un principio di leale collaborazione aderente, nelle dinamiche del pluralismo istituzionale, alla tutela del patrimonio culturale nazionale (art. 9, 2° comma, Cost.), facendo peraltro emergere una dinamica di irrigidimento (verso l’alto) rispetto a quella ascensionale di cui all’art. 118, 1° comma, Cost[148].
Tuttavia da esso, per analogia, e dalla stessa connessione tra le due anime dell’art. 9 Cost., per coerenza sistematica, deve desumersi un principio generale di leale collaborazione a tutela dei patrimoni.
Devono peraltro ritenersi applicabili, non essendovi ragioni ostative, gli assunti sviluppati dalla giurisprudenza costituzionale in relazione al rapporto tra “tutela” (art. 117, 2° comma, let. s) e “valorizzazione” del patrimonio culturale nazionale (art. 117, 3° comma, Cost.) anche al rapporto tra “tutela” del patrimonio culturale nazionale (art. 117, 2° comma, let. s, Cost.) e “governo del territorio” (art. 117, 3° comma, Cost.)[149].
Più specificatamente la giurisprudenza costituzionale nelle ipotesi in cui sussista un intreccio di competenze legislative tra loro correlate, come per le materie “tutela/valorizzazione”, caratterizzate da una “ideale contiguità” [150] una volta effettuato in senso negativo il test di prevalenza, ha affermato l’applicabilità del principio di leale collaborazione, arrivando a dichiarare illegittime norme statali non recanti meccanismi di raccordo, quale è l’intesa, con il livello regionale[151].
Tale modello potrebbe essere quindi utile anche per la contiguità, in alcuni casi inevitabile [152] (soprattutto per i beni paesaggistici residuali), con il “governo del territorio”, al fine di quel coordinamento tra le tutele dei patrimoni, visto peraltro che la stessa Corte costituzionale, pur con riferimento al patrimonio culturale in senso stretto, ha affermato la necessità di valorizzare “le peculiarità locali delle Regioni”[153].
La stessa giurisprudenza amministrativa ha affermato in modo chiaro che il potere di pianificazione “deve essere rettamente inteso in relazione ad un concetto di urbanistica che non sia limitato solo alla disciplina coordinata della edificazione dei suoli (e al massimo ai tipi di edilizia distinti per finalità), ma anche, per mezzo della disciplina dell’utilizzo delle aree, realizzi anche finalità economico-sociali della comunità locale, non in contrasto ma anzi in armonico rapporto con analoghi interessi di altre comunità territoriali, regionali e dello Stato , nel quadro del rispetto e dell’attuazione dei valori costituzionali”[154].
Non vi è dubbio che analoga esigenza si pone, a monte, per il livello legislativo, con tutte le difficoltà note in un assetto privo di una Camera di rappresentanza delle autonomie.
3.5. La resistenza del “governo culturale del territorio” alla presunzione statale di culturalità
Il quadro sopra ricostruito non può essere minato da un’isolata pronuncia della Corte costituzionale[155], che pare aver contraddetto la giurisprudenza precedente, dalla quale emerge, come visto, il riconoscimento di un maggior spazio per l’autonomia regionale ai fini della salvaguardia degli altri beni culturali e dei patrimoni culturali urbanistici.
Con la suddetta sentenza la Corte ha accolto per violazione dell’art. 117, 2° comma, let. s) un ricorso statale avverso una normativa regionale, avente ad oggetto “Valorizzazione dei reperti mobili e dei cimeli appartenenti a periodi storici diversi dalla prima guerra mondiale”, sul presupposto che ove “la legge regionale in discorso avesse effettivamente inteso evitare di sovrapporsi alla disciplina dello Stato, avrebbe dovuto prevederlo in maniera inequivoca: non già solo, cioè, genericamente escludendo di riferirsi – con una formula destinata a risultare quasi di stile – ai beni di cui all’art. 10 del codice dei beni culturali, ma piuttosto direttamente prevedendo di rivolgersi soltanto a quelle cose che, in quanto non riconosciute o non dichiarate di “interesse culturale”, all’esito dei previsti procedimenti, risultassero, perciò, escluse , come previsto, dall’applicazione delle disposizioni del codice (art. 12, comma 4, e artt. 13 e seguenti del codice dei beni culturali), in quanto non ricomprensibili nel novero dei beni culturali di cui al predetto art. 10”.
La sentenza, pur non negando in astratto la configurabilità degli altri beni culturali e la competenza regionale in materia, anzi precisandone i contorni identitari e sostanziali[156], subordina la competenza legislativa regionale ad un accertamento negativo espresso in seno ad un procedimento statale di natura amministrativa, elevando così il principio di “presunzione di culturalità” [157] , ossia un principio non pacifico neppure nell’ordinamento di settore in relazione ai beni pubblici[158], a criterio sul riparto della funzione legislativa.
Da tale prospettazione dovrebbe desumersi che i legislatori regionali siano legittimati ad esercitare la propria potestà legislativa (anche) in materia di “governo del territorio”, in relazione ai “patrimoni culturali urbanistici”, soltanto a valle dell’esercizio di un potere amministrativo statale.
Tale modello si risolve in una neutralizzazione dell’autonomia regionale.
In primo luogo appare assai critico che il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni possa essere alterato, attraverso la subordinazione dell’autonomia regionale a un procedimento amministrativo, al di fuori dello stesso modello di attrazione in sussidiarietà (come ricostruito da Corte cost. n. 303/2003).
In ogni caso il riparto di competenze legislative sarebbe condizionato da una disciplina di rango legislativo primario (ossia quella codicistica)[159].
Inoltre tale modello legittimerebbe una possibile sospensione a tempo indeterminato della competenza legislativa regionale[160], posto che un accertamento espresso su un certo bene potrebbe non arrivare mai; in ogni caso, nella logica evolutiva sopra richiamata (sub 2.4), nulla esclude che il giudizio di meritevolezza statale sopravvenga alla disciplina regionale[161], senza alcun concreto pregiudizio per i beni in oggetto.
A questo si aggiunga che tale logica, con pretesa sistemica, costruita dalla Corte in relazione ai singoli beni culturali (prevalentemente di proprietà pubblica[162]), puntualmente individuabili, non sarebbe comunque replicabile in relazione ai “patrimoni culturali urbanistici”, per i quali, come si dirà, vengono in gioco zone, complessi di benie anche beni di proprietà privata.
In conclusione deve ribadirsi che la competenza legislativa regionale, nell’ambito del “governo del territorio”, possa avere ad oggetto non soltanto beni non disciplinati dalla normativa statale, quindi radicalmente diversi o ulteriori (rispetto a quelli codicistici), ma anche beni disciplinati dalla normativa statale (quali beni culturali o paesaggistici[163]) non sottoposti a vincolo.
Quanto a questa ultima tipologia di beni costituenti i “patrimoni culturali urbanistici”, che sia ancora più forte la esigenza di coordinamento con lo strato del patrimonio nazionale, di cui si è già detto, indagando il principio di leale collaborazione.
4. La potestà di pianificazione urbanistica in attuazione diretta della Costituzione culturale
Non vi è dubbio che i “patrimoni culturali urbanistici” abbiano bisogno dei legislatori regionali. Una normazione più intensa e mirata (rispetto a quella di cui si è detto) in materia di “governo del territorio” porrebbe le basi solide, anche sotto il profilo procedimentale, per l’esercizio di poteri amministrativi comunali.
Tuttavia vi è da chiedersi, al fine di verificare la tenuta del principio di legalità, se i Comuni, in assenza di normative espresse di dettaglio, possano esercitare comunque i propri poteri pianificatori strumentali al riconoscimento, alla tutela e alla fruizione dei “patrimoni culturali urbanistici”, fermi comunque i frammenti di principi fondamentali statali già richiamati; in altre parole se “la possibilità di conformare non solo la res ma anche le sue componenti immateriali, rientri nel generale potere di conformazione riconosciuto agli strumenti urbanistici, o, se invece, occorrano specifiche previsioni che legittimino la conformazione dell’immateriale”[164].
La risposta fornita dalla dottrina e dalla giurisprudenza (costituzionale e amministrativa) è positiva.
È stato puntualmente scritto che “la limitazione urbanistica quando si occupa del patrimonio urbanistico va oltre il costruito, occupandosi della sua anima, o del suo decoro od ancora del genius loci”, posto che i valori in gioco non sono solo quelli della conservazione materiale ma anche la tutela “delle sue componenti immateriali, quali l’ambiente dell’anima, (…) l’identità sedimentata e storicizzata, la memoria storica, la grande bellezza”; siamo, infatti, “di fronte ad una proprietà conformata in maniera diversa da quella edilizia”[165], trattandosi di una “proprietà culturale”[166].
In questa prospettiva il potere conformativo, attraverso zonizzazione o micro-zonizzazione, prescrive comportamenti o impone obblighi funzionalizzati (vincoli negativi o vincoli positivi)[167], qualitativamente diversi dai vincoli relativi al patrimonio culturale in senso stretto[168]; in altre parole una “conformazione per connessione” in quanto la conformazione non riguarda solo il bene, ma “anche l’uso, che nel caso della proprietà culturale è intimamente connessa, stante il rapporto biunivoco tra componente materiale e immateriale”[169].
La stessa giurisprudenza costituzionale ha affermato in modo chiaro che “attraverso i piani urbanistici il Comune può, nella sua autonomia, in relazione ad esigenze particolari e locali, imporre limiti e vincoli più rigorosi o aggiuntivi anche con riguardo a beni vincolati a tutela di interessi culturali ed ambientali”[170], quindi non soltanto una tutela incrementale, rispetto al patrimonio culturale nazionale[171], secondo una prospettiva di “mutualità integrativa”[172], ma anche una tutela parallela per gli altri patrimoni; altri patrimoni e altre tutele, attraverso la costruzione del potere di pianificazione come strumentale alla tutela di ulteriori valori costituzionali[173], quindi funzionale a un “modello di sviluppo che si intende imprimere ai luoghi stessi in considerazione della loro storia, tradizione, ubicazione e di una riflessione de futuro sulla propria stessa essenza” [174] con la partecipazione delle comunità di riferimento[175].
Un modello certamente compatibile con il principio di sussidiarietà amministrativa (art. 118 Cost.) [176] e quindi aderente al dimensionamento degli interessi territoriali.
Si tratta quindi di una attuazione diretta della Costituzione culturale da parte della Pubblica amministrazione e specificatamente da parte dei Comuni[177].
Questa impostazione si è consolidata nella stessa giurisprudenza amministrativa[178], che ha superato le più risalenti resistenze[179], relativizzando in alcuni casi lo schema tutela puntuale/tutela generale.
In modo paradigmatico è stato affermato che merita condivisione l’insegnamento giurisprudenziale alla stregua del quale l’art. 1 l. 19 novembre 1968 n. 1187, che ha esteso il contenuto del piano regolatore generale anche all’indicazione dei “vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico” (art. 7 l. n. 1550/1942, già richiamato) “legittima l'autorità titolare del potere di pianificazione urbanistica a valutare autonomamente tali interessi e, nel rispetto dei vincoli già esistenti posti dalle amministrazioni competenti, ad imporre nuove e ulteriori limitazioni”.Da tale premessa deriva che “il piano regolatore generale, nell'indicare i limiti da osservare per l'edificazione nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico, può disporre che determinate aree siano sottoposte a vincoli conservativi, indipendentemente da quelli disposti dalle commissioni competenti nel perseguimento della salvaguardia delle cose di interesse storico, artistico o ambientale (Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 1990, n. 78)”. In questa prospettiva deve ritenersi che “la distinzione tra le forme di tutela previste dalla legislazione di settore e le scelte pianificatorie volte alla valorizzazione di complessi edilizi di interesse culturale, storico ed ambientale non risiede nel dato quantitativo relativo all’ambito, puntuale o meno, degli oggetti interessati dalle determinazioni limitative quanto nel dato teleologico relativo alla diversa finalità che permea le rispettive statuizioni amministrative”. Non può quindi ritenersi condivisibile la tesi “secondo cui le scelte pianificatorie dovrebbero riguardare necessariamente un ambito territoriale non definibile a priori ma comunque non riducibile a specifici fabbricati. Si deve al contrario ritenere, alla luce del tenore del dato positivo e della ratio che lo informa, che il piano regolatore generale possa recare previsioni vincolistiche incidenti su singoli edifici, configurati in sé quali “zone”, quante volte la scelta, pur se puntuale sotto il profilo della portata, sia rivolta non alla tutela autonoma dell’immobile ex se considerato ma al soddisfacimento di esigenze urbanistiche evidenziate dal carattere qualificante che il singolo immobile assume nel contesto dell’assetto territoriale. In tale caso, infatti, non si realizza alcuna duplicazione rispetto alla sfera di azione della legislazione statale di settore in quanto il pregio del bene, pur se non sufficiente al fine di giustificare l’adozione di un provvedimento impositivo di vincolo culturale o paesaggistico in base alla considerazione atomistica delle caratteristiche del bene, viene valutato come elemento particolare valore urbanistico e può quindi, costituire oggetto di salvaguardia in sede di scelta pianificatoria. E tanto in coerenza con una nozione ampia della materia urbanistica, che valorizza la funzione di governo del territorio attraverso la disciplina, nella loro globalità, di tutti i possibili insediamenti e delle altre utilizzazioni del territorio ”[180].
Questa filone giurisprudenziale, in conformità al quadro sopra ricostruito, valorizza quindi la natura degli altri patrimoni, oggetto del potere di pianificazione, sul presupposto che è “ben possibile che un bene, pur privo in sé di valenza culturale, rivesta una oggettiva centralità identitaria per una città e sia traguardato dagli abitanti (e dagli appositi organi elettivi comunali) come elemento idoneo a rappresentarne il passato ed a veicolarne fisicamente i trascorsi”[181].
5. La variabile del regionalismo differenziato
In astratto è ragionevole ritenere che il riconoscimento e la salvaguardia dei “patrimoni culturali urbanistici” non abbiano bisogno del regionalismo differenziato ex art. 116, 3° comma, Cost., posto che nel quadro costituzionale, come sopra ricostruito, vi sono tutti gli strumenti necessari alla emersione di tale dimensione.
Probabilmente l’eventuale affermazione di “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”, all’esito della tortuosa vicenda istituzionale in atto, riguardanti le “materie” del “governo del territorio” (art. 117, 3° comma, Cost.) e della “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” (art. 117, 2° comma, let. s)[182], potrebbe essere considerata soltanto l’occasioneper un rafforzamento della legittimazione istituzionale e della sensibilità regionale a disciplinare questa dimensione.
Non può negarsi, però, come la recessività della materia “governo del territorio”, determinata in concreto dalla giurisprudenza costituzionale, come già detto sopra, possa far sostenere, a modo di reazione, il bisogno di una maggiore autonomia o comunque l’esigenza di un maggior spazio di intervento delle Regioni [183] per dare concretezza “al governo dei processi, della convivenza, delle evoluzioni territoriali”, quindi per costruire “fini lontani, mete a lunga a scadenza”[184]; un’autonomia non solo legislativa ma anche amministrativa, che, attraverso il riconoscimento di una riserva di amministrazione, recuperi flessibilità organizzativa e funzionale [185] in ambiti ulteriori o complessi, come quelli del decoro urbano, della disciplina dei centri storici, della rigenerazione urbana [186] e quindi anche dei “patrimoni culturali urbanistici”.
In questa prospettiva di ulteriore autonomia la tutela dei “patrimoni culturali urbanistici” sarebbe certamente sottratta alle torsioni centraliste della giurisprudenza costituzionale, pur ferma la necessità di evitare di sostituire al centralismo statale un neo-centralismo regionale[187], non potendo essere compressa, soprattutto ai fini della salvaguardia degli altri patrimoni, l’autonomia comunale[188].
Tuttavia, essendo una prospettiva del tutto ipotetica, dovrà verificarsi in corso se potrà davvero parlarsi di una “stagione nuova” [189] del “governo del territorio.
6. Una notazione conclusiva
Alla luce del quadro sopra ricostruito può affermarsi che il tasso di emersione e stabilizzazione costituzionale dei “patrimoni culturali urbanistici” potrà misurarsi non semplicemente alla luce della constatazione che è legittima una normativa regionale o uno strumento di pianificazione comunale che riconoscono e disciplinano tali beni ma dalla sostenibilità di un ulteriore assunto, secondo cui dovrebbero ritenersi illegittimi una normativa regionale o uno strumento di pianificazione territoriale che omettano di prendere in considerazioni tali patrimoni ulteriori.
Non vi è dubbio come questo ultimo assunto debba problematicamente confrontarsi con lo spazio ampio della discrezionalitàlegislativa e amministrativa (soprattutto in considerazione della logica di atipicità delle misure di salvaguardia) e con i connessi limiti della sindacabilità giurisdizionale (costituzionale e amministrativa). Tuttavia non può escludersi in radice, innanzi ad una omissione, un intervento (anche additivo di principio) della Corte costituzionale [190] o una sentenza (anche manipolativa[191]) del giudice amministrativo.
Rimane comunque innegabile la centralità del legislatore regionale, nell’ambito funzionalizzato del “governo culturale del territorio”, ai fini della espressa tutela dei “patrimoni culturali urbanistici”, posto che la logica della atipicità, che caratterizza questa dimensione, se condotta “alle sue estreme conseguenze”, rischia di rendere la discrezionalità amministrativa “arbitra assoluta dell’applicabilità del regime conformativo”[192]; in altre parole, per quanto debba ritenersi che il potere amministrativo di pianificazione comunale trovi autonomo fondamento nella Costituzione culturale e sia compatibile con il principio di legalità, pur in assenza di una normativa regionale specifica, come sopra detto, la stabilità e il contenuto di tale potere, anche innanzi alla giurisdizione, hanno certamente bisogno di una normativa regionale utile, che disciplini strumenti di settore, oltre a funzionalizzare istituti generali.
In questa prospettiva il tema non è soltanto al crocevia dei rapporti tra Stato e Regioni ma anche potenzialmente delle interazioni tra regionalismo e municipalismo[193].
Dalle dinamiche “multilivello”, che attraversano il patrimonio culturale nazionale, nell’ambito di quelle “tensioni irrisolte” [194] tra attrazioni verso l’alto e coinvolgimento degli altri livelli di governo e delle comunità territoriali, deve essere separata quindi l’autonoma dimensione costituzionale dei “patrimoni culturali urbanistici”, caratterizzata da ulteriori tensioni del pluralismo istituzionale e culturale.
Pertanto l’affermazione della Corte costituzionale, relativa al patrimonio culturale nazionale, secondo cui l’art. 9, 2° comma, Cost., “non postula una riserva statale, ma è intesa a promuovere il concorso o la collaborazione, nella sfera di rispettiva competenza, delle strutture centrali e locali per il migliore perseguimento di un grande obbiettivo di civiltà” [195] non dice tutto sul pluralismo.
Questa traiettoria di emersione merita quindi di essere seguita.
Nel mentre appare rilevante in via sintomatica come di recente l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato[196], per legittimare una dilatazione di un istituto a tutela del patrimonio culturale nazionale (i poteri vincolistici della Soprintendenza estesi all’utilizzazione di un bene immobile, in quanto testimonianza identitaria collettiva), richiami proprio la giurisprudenza sviluppatasi sugli altri beni culturali[197]; la tutela tipica del patrimonio culturale nazionale che sembrerebbe aver bisogno, per paradosso, della tutela atipica degli altri patrimoni.
Tuttavia in questo richiamo, pur significativo ai nostri fini quale riconoscimento di una categoria costituzionale, si annida tutto il rischio di una sovrapposizione tra i patrimoni, che necessitano, invece, di distinzione costituzionale.
[1] Il testo costituisce la relazione tenuta al Convegno nazionale dell’Associazione italiana di diritto urbanistico (AIDU), organizzato a Firenze il 8.11.2024 sul tema “Il patrimonio culturale urbanistico: problemi e prospettive”; la relazione è pubblicata su www.federalismi.it , n. 1 del 1.1.2025, pag. 75 ss.
[2] Una nozione già di per sé criticata per la irriducibilità di istituti e concetti propri di due distinti campi. Cfr. in tal senso P. Stella Richter, La nozione di patrimonio culturale, in Foro amm. – Cons. St ., 2004, 4 ss. Più in generale cfr. S. Amorosino, Diritto dei beni culturali e del paesaggio , Milano, 2024, 3 ss.; A. Crosetti, D. Vaiano, Beni culturali e paesaggistici , Torino, 2023 8 ss.
[3] A. Bartolini, Patrimoni culturali e limitazioni urbanistiche , in Dir. amm., 2021, 995 ss.
[4] M.S. Giannini, I beni culturali, in Riv. trim. dir. pubbl., 1976, 8. L’espressione è ripesa da Corte cost. n. 94/2003. Cfr. anche P. Marzaro, Gli ‘altri beni culturali’ e i beni culturali urbanistici: note di sistema , in Riv. giur. urb., 2023, 425 ss.
[5] S. Foà, La legge regionale sulla tutela dei locali storici è legittima perché non riguarda i “beni culturali” ma “beni a rilevanza culturale”. La Corte costituzionale “sorvola” sulla distinzione tra tutela e valorizzazione , in Le Regioni, 2003, 1232 ss.
[6] A. Bartolini, Beni culturali (diritto amministrativo), in Enc. dir. Annali , Milano, 2013 106 ss., che mette puntualmente in evidenza come nella categoria dei beni culturali minori siano annoverabili sia beni disciplinati dal Codice sia beni extracodicistici; G. Garzia, Enti locali, Associazioni e i c.d. beni culturali “minori” , in Riv. giur. ed., 2018, 379 ss.
[7] G. Clemente di San Luca, L’attività di trasformazione dei beni culturali, in M.A. Sandulli, M. Spasiano, P. Stella Richter (a cura di), Il diritto urbanistico in 50 anni di giurisprudenza della Corte costituzionale , Napoli, 2006, 197.
[8] G. Severini, sub. Artt. 1-2,I beni culturali minori o extracodicistici, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dei beni culturali e del paesaggio, Milano, 2012, 29 ss.
[9] M. Cammelli, L’ordinamento dei beni culturali tra continuità e innovazione , in Aedon, 2017, 3, secondo cui “se dai principi si allarga lo sguardo al resto non è difficile constatare che già oggi esistono altre forme di riconoscimento del valore culturale di un bene anche senza farne un bene culturale in senso codicistico, che a questi beni sono riservate forme di tutela (basta pensare ai beni c.d. ‘minori nella normativa regionale e locale, a partire dai locali storici) al di fuori del Codice, che la nozione di bene culturale è sempre più una nozione aperta e che dunque se esaminiamo della vicenda non il singolo fotogramma ma la sequenza più che di secco contrasto tra Codice e Convenzioni sarebbe più proprio vedere nel primo il punto di partenza e nelle seconde il probabile punto di arrivo di dinamiche ormai in atto”. G. Severini, La nozione di bene culturale e le tipologie di beni culturali , in G. Caia (a cura di), Il testo unico sui beni culturali e ambientali , Milano, 2000, 2 parlava, al momento di entrata in vigore del dlgs. n. 490/1999, di una concezione (non accolta dal legislatore) “unitaria” dei beni culturali, secondo la quale sono beni culturali tutte le “testimonianze materiali aventi valore di civiltà” nella prospettiva della Commissione Franceschini istituita con la l. n. 310/1964). Cfr. anche P. Carpentieri, Tutela e valorizzazione dei beni culturali , in Urb. App., 2003, 9, che riflette intorno alla alternativa tra una nozione “metagiuridica” (e “aperta”) e una nozione “tipizzata dal diritto” di bene culturale; A. Poggi, Verso una definizione aperta di bene culturale? (a proposito della sentenza n. 94/2003 della Corte costituzionale) , in Aedon, 2003, n. 1.
[10] L’indicazione metodologica è di P. Marzaro, Gli ‘altri beni culturali’, cit., 426.
[11] Per una suggestiva definizione di “patrimonio culturale urbanistico” si veda F. Salvia, Spunti di riflessione per una teoria sui beni culturali urbanistici , in Riv. giur. ed., 2018, 129 . Cfr. anche F. Salvia, La tutela trasversale dei beni culturali. I beni culturali urbanistici , in Dir. soc., 2003, 367 ss.; F. Salvia, Le testimonianze culturali e urbanistiche del passato: le ragioni di una maggiore tutela. Vecchi e nuovi dilemmi su centri storici e periferie urbane , in Dir. soc., 2006, 327 ss.; A. Bartolini, Patrimonio culturale e urbanistica , in P. Stella Richter (a cura di), Governo del territorio e patrimonio culturale , Milano, 2017, 12 ss.
[12] Su tale classificazione cfr. sempre F. Salvia, Spunti di riflessione per una teoria sui beni culturali urbanistici , cit., 130. Sono beni “artificiali” quelli architettonici, come ad esempio, i centri storici, i borghi, i trulli, le case coloniche, le ville storiche, i cimiteri, i monumenti della storia locale, gli immobili dell’archeologia industriale; sono beni “naturali” le località di rilevanza paesistica identificate dalle persone del luogo; sono beni “misti”, ad esempio, i paesaggi rurali o ai paesaggi marini caratterizzate dalla presenza di tonnare, saline, mulini.
[13] Cosi G. Salvia, Spunti di riflessione per una teoria sui beni culturali urbanistici , cit., 132.
[14] L’espressione “beni culturali urbanistici” non può quindi ritenersi un sinonimo di “patrimonio culturale urbanistico”, lasciando anche nominalisticamente nell’ombra gli altri beni urbanistici, di carattere naturale-paesaggistico, a forte valenza culturale e identitaria. L’espressione è stata definita “enfatica” da S. Fantini, Il centro storico come bene paesaggistico a valenza culturale , in Aedon, 2015, 3.
[15] M.S. Giannini, I beni culturali, in Riv. trim. dir. pubbl., 1976, 14, che parla di un criterio storicistico in cui “l’evidenza va posta sull’essere testimonianza cioè entità rappresentativa di momenti di un civiltà nel suo essere storia”.
[16] Così C. Marzuoli, Il paesaggio nel nuovo Codice dei beni culturali , in Aedon, 2008. Anche per tale dimensione può parlarsi di “realtà etico-culturale”. Cfr. C. Barbati, Il paesaggio come realtà etico-culturale , in Aedon, 2007, 1127 ss. L’espressione, invece, di “beni ambientali urbanistici” è utilizzata dalla giurisprudenza amministrativa per far riferimento soprattutto ai centri storici. Cfr. ex plurimis Cons. St., sez. IV, n. 3255/2013; Cons. St., sez. IV, n. 519/2016; Tar Lazio, n. 17967/2023; Tar Veneto n. 1072/2019. Cfr. T. Alibrandi, P. Ferri, I beni culturali e ambientali , Milano, 1995, 70.
[17] In particolare il c.d. secondo strato del paesaggio (evocato dall’art. 131, 6° comma, dlgs. n. 42/2004), quello dei c.d. “paesaggi della vita quotidiana”, espressione per le comunità locali di valori identitari, secondo la suggestiva ricostruzione di E. Boscolo, La nozione giuridica di paesaggio identitario e il paesaggio ‘a strati’ , in Riv. giur. urb., 2009, 57 ss. Cfr. anche A. Sau, Il rapporto tra funzione urbanistica e tutela paesaggistica oltre il “mito” della primarietà. Qualche considerazione a margine di Consiglio di Stato 31 marzo 2022 n. 2371 , in Aedon, 2022, 3 ss.; R. Giani, Il paesaggio e la sua dimensione giuridica in rapporto con l’ambiente ed il governo del territorio, tra Costituzione, convenzione europea e codice , in www.giustizia-amministrativa.it , 2024, 1 ss.
[18] Così puntualmente A. Bartolini, Patrimoni culturali e limitazioni urbanistiche , cit., 1000.
[19] Nell’ambito della normativa codicistica rimane necessario, invece, un giudizio di prevalenza al fine di ricondurre un bene ad uno dei due regimi. Si pensi alla problematica dei “paesaggi culturali”. G. Severini, Culturalità del paesaggio e paesaggi culturali, in www.federalismi.it , 2020, 326 ss. afferma che “nei paesaggi culturali la dimensione culturale è preminente al punto da comporre la stessa forma del luogo, da farne un particolare bene culturale e da giustificare il corrispondente regime di tutela, in pratica quello dei beni culturali immobili”.
[20] In realtà nella giurisprudenza costituzionale e amministrativa non è mai stata utilizzata, in modo letterale, l’espressione “patrimonio culturale urbanistico”. L’unica pronuncia che utilizza l’espressione “beni culturali urbanistici”, da intendersi, come detto, contenuta nella prima, è Cons. giust. amm. sic., 22.3.2006 n. 107; tuttavia appare significativo che il Relatore di tale sentenza fosse proprio il Prof. F. Salvia.
[21] Sulla norma costituzionale cfr. M. Cecchetti, sub art. 9 Cost., in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione , Milano, 2006, 217 ss.; F. Rimoli, Profili costituzionali della tutela del patrimonio culturale , in AA. VV., Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela , Roma, 2017, 91 ss.; B. Caravita, Diritto dell’ambiente, Bologna, 2001; M. Cecchetti, Principi costituzionali per la tutela dell’ambiente , Milano, 2000; M. Ainis, Cultura e politica. Il modello costituzionale , Padova, 1991; G. Cartei, La disciplina del paesaggio tra conservazione e fruizione programmatica , Torino, 1995; F. Merusi, sub art. 9 Cost, in Commentario alla Costituzione , in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione , Bologna-Roma, 1975, 434 ss.; G. Morbidelli, Il regime amministrativo speciale dell’ambiente , in Studi in onore di Alberto Predieri, Milano, 1996, 1122; G. Morbidelli, La disciplina del territorio tra Stato e Regioni , Milano, 1974; A. Predieri, Paesaggio, in Enc. dir ., Milano, 1981; E. Spagna Musso, Lo Stato di cultura nella Costituzione italiana , Napoli, 1961.
[22] In termini maggiormente possibilisti sull’inclusione nell’alveo dell’art. 9, 2° comma, Cost. anche degli “altri beni” si esprime M. Cecchetti, sub art. 9 Cost., 228 ss.; cfr. anche, sulla prospettiva di un “allargamento” dell’art. 9, 2° comma, Cost., G. Garzia, Enti locali, Associazioni e i c.d. beni culturali “minori” , cit., 388.
[23] La Corte costituzionale ha affermato che “non appare superfluo sottolineare la circostanza che il codice dei beni culturali e del paesaggio si “autoqualifichi” (art. 1, comma 1) come normativa di «attuazione dell’articolo 9 della Costituzione», assumendo le connotazioni tipiche del “parametro interposto”, alla stregua del quale misurare la compatibilità costituzionale delle disposizioni con esso eventualmente in contrasto” (194/2013; cfr. anche 262/2021), assimilando la categoria dell’attuazione della Costituzione con quella della interposizione.
[24] C. Lavagna, Problemi di giustizia costituzionale sotto il profilo della “manifesta infondatezza” , Milano 1957, 28 ss.; V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale , Padova 1984, vol. II, 360; M. Siclari, Le norme interposte nel giudizio di costituzionalità , 1992.
[25] Sulle teorie relative allo specifico rapporto tra oggetti dell’art. 9 Cost. e “beni culturali”, in termini di coincidenza o non coincidenza, cfr. M. Cecchetti, sub art. 9 Cost., 228 ss.
[26] G. Severini, Culturalità del paesaggio e paesaggi culturali, in www.federalismi.it , 2020, 313 ss., che afferma in modo chiaro come “nella norma costituzionale, la non causale espressione ‘della Nazione’ figura come specificazione speculare, connotativa sia riguardo al ‘patrimonio storico artistico’ (ciò che oggi chiamiamo beni culturali) sia riguardo al ‘paesaggio’: sono della ‘Nazione’, la Nazione è composta anche da quelli”. Per una ampia riflessione sulla dimensione nazionale ex art. 9, 2° comma, Cost., cfr. F.S. Marini, Lo statuto costituzionale dei beni culturali, cit., 2002, 183 ss.
[27] Corte cost. n. 478/2002.
[28] Corte cost. n. 118/1990.
[29] Corte cost. n. 194/2013. In senso meramente ricognitivo del testo costituzionale l’art. 1, 2° comma, dlgs. n. 42/2004 afferma che “le tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura”; l’art. 131, 2° comma, dlgs. n. 42/2004 afferma che “il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell’ identità nazionale , in quanto espressione di valori culturali”. Sulla primarietà del valore estetico-culturale (Corte cost. n. 151/1986) quale elemento essenziale del processo di formazione della memoria storica della Nazione e quale componente identitaria cfr. G. Severini, I principi del Codice dei beni culturali e del paesaggio , in Giorn. dir. amm., 2004, 469 ss.; S. Settis, Battaglie senza eroi. I beni culturali tra istituzioni e profitto , Milano, 2005; S. Settis, Italia S.p.a., Torino, 2002, 11 ss. Sulla nozione unitaria di “patrimonio culturale della Nazione”, ricavabile dall’art. 9, 2° comma, Cost., cfr. anche P. Carpentieri, La nozione giuridica di paesaggio, in Riv. trim. dir. pubbl ., 2004, 394 ss.
[30] Corte cost. n. 309/2011.
[31] Corte cost. n. 151/1986.
[32] Corte cost. n. 9/2004.
[33] P. Chirulli, Il governo multilivello del patrimonio culturale, in Dir. amm ., 2019, 697 ss.
[34] P. Carrozza, Nazione (voce), in Dig. Disc. Pubbl .,Vol., X, Torino, 1995, 146.
[35] Sulla concezione “nazional-patrimoniale” cfr. diffusamente F.S, Marini, Lo Statuto costituzionale dei beni culturali, Milano, 2002, 205 ss.
[36] Così G. Caia, Art. 1, cit., 1056. Cfr. anche P. Caputi Jambrenghi, Art. 1 , in A. Angiuli, V. Caputi Jambrenghi (a cura di), Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio , Torino, 2005, 29 ss,
[37] P. Carrozza, Nazione (voce), cit. 126 ss.; V. Crisafulli, D. Nocilla, Nazione (voce), in Enc. dir., Milano, 1977, 791 ss; C. Mortati, La Costituzione in senso materiale, Milano, 1940, 314 ss.
[38] G. Severini, sub. Artt. 1-2, cit., 16; C. Mortati, La rilevanza giuridica del concetto di Nazione, in Raccolta di scritti – IV: problemi di politica costituzionale , Milano, 1972, 553 ss.
[39] F.S. Marini, Lo Statuto costituzionale dei beni culturali, cit., 54, si sofferma sulla nozione di “patrimonio” nell’art. 9, 2° comma, Cost., mettendo in evidenza come la “patrimonialità” abbia “un carattere evocativo, che rimanda ad un’ideale appartenenza dei beni alla Nazione”.
[40] Sono qualificabili, ad esempio, come “beni culturali” (art. 10 dlgs. n. 42/2004), quando sia intervenuta la dichiarazione dell’interesse culturale, le cose immobili che “presentino interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante ” (art. 10, 3° comma, let. a, dlgs. n. 42/2004), specificatamente “f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; g) le pubbliche piazze, vie strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico” (art. 10, 4° comma, dlgs. n. 42/2004); sono, invece, qualificabili come “beni paesaggistici” (art. 136 dlgs. n. 42/2004), previa dichiarazione di interesse pubblico (art. 139 dlgs. n. 42/2004), “a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”.
[41] G. Severini, sub. Artt. 1-2, cit., 19. Quel rischio di frammentazione autonomistica denunciato da Concetto Marchesi in Assemblea costituente (Att Ass. Cost. n. 3421) e ribadito dalla Corte costituzionale (n. 194/2013), che ha parlato di “patrimonio intrinsecamente comune non suscettibile di arbitrarie o improponibili frantumazioni ”. In questo senso cfr. anche Corte cost. n. 182/2006; 197/2014; 62/2015; 11/2016; 74/2021. Per indicazioni bibliografiche cfr. A. Gusmai, Il “governo del territorio”. Premesse costituzionali allo studio dell’urbanistica , Bari, 2024, 213 ss. In una prospettiva più ampia, invece, E. Boscolo, La nozione giuridica di paesaggio identitario ed il paesaggio “a strati” , cit., 67, ha osservato che “il carattere unificante di una (fantomatica) identità nazionale è astrattamente ricostruibile tanto quale mero mosaico di differenti identità-locali, quanto come valore somma di elementi necessariamente coerenti e massimamente rilevanti”.
[42] P. Carrozza, Nazione (voce), cit., 146.
[43] M. Dogliani, Costituente ed identità nazionale, in Scritti in onore di E. Casetta , Napoli, 2001, 1088 ss.
[44] Cfr. da ultimo G. Famiglietti, La tutela della cultura, in M. Benvenuti, R. Bifuclo (a cura di) Trattato di diritto costituzionale , I principi fondamentali, II, Torino, 2024, 375 ss. Cfr. anche G. Famiglietti, Diritti culturali e diritto della cultura. La voce “cultura” dal campo delle tutele a quello della tutela , Torino, 2010; G. Repetto, Il diritto alla cultura, in Rivista del Gruppo di Pisa, 2016, 1 ss.
[45] E. Boscolo, Le nozioni di paesaggio. La tutela giuridica di un bene comune (in apparenza diffusa) tra valori culturali e identitari , in www.giustamm.it, 2016, secondo cui “alcuni frammenti del territorio presentano un connotato di eccezionalità e costituiscono quindi patrimonio dell’intera Nazione, altri territori sono significativi solo per la comunità locale, unico soggetto interessato alla non dispersione degli elementi per essa significativi”.
[46] M. Ainis, M. Fiorillo, L’ordinamento della cultura, Milano, 2022, 53, mettono in evidenza come “ogni attività promozionale è intrinsecamente selettiva: postula cioè la scelta dei settori sui quali intervenire, delle modalità di intervento, degli obiettivi cui esso si rivolge”.
[47] Cfr. Corte cost. n. 194/2013.
[48] Cfr. da ultimo, pur in una prospettiva più ampia, A. Mastromarino, Formazioni culturali e conflitti identitari , Relazione Convegno AIC 2024, in www.aic.it , 2024, 1 ss.
[49] P. Chirulli, Il governo multilivello del patrimonio culturale, cit., 698.
[50] L’art. 9 Cost., secondo una interpretazione aderente all’evoluzione del concetto di cultura, è stata ritenuta una disposizione “manifesto”, posta a fondamento della salvaguardia, della valorizzazione, della fruizione di quel sostrato di beni, conoscenze, tradizioni che ogni comunità riconosce come propria; quindi una diposizione a tutela del pluralismo culturale. Cfr. P. Bilancia, La disciplina italiana dei beni culturali , cit., 3 ss.; J. Luther, Articolo 9, in G. Neppi Modona (a cura di), Stato della Costituzione, Milano, 1988, 50 ss.
[51] Cfr. da ultimo S. Mabellini, La tutela dei beni culturali nel costituzionalismo multilivello , Torino, 2021; M.G Pulvirenti, Patrimonio culturale e ordinamento pluralista , Torino, 2022.
[52] A livello regionale questa prospettiva sembra valorizzata anche dagli Statuti regionali, che contengono formulazioni ampie in cui si dilata il ruolo delle Regioni in ambito culturale, spesso con riferimento alla tutela dell’identità-specificità culturale regionale (cfr., ad esempio, art. 4 St. Toscana, art. 12 St. Puglia, art. 2 St. Calabria, art. 9 St. Lazio, art. 11 St. Umbria), per quanto, come noto, la giurisprudenza costituzionale abbia ridimensionato la portata precettiva di tali previsioni (Corte cost. nn. 196/2003; 27/2004).
[53] A.M. Sandulli, La tutela del paesaggio nella Costituzione, in Riv. giur. ed ., 1967, II, 69 ss.
[54] Per la nozione di Costituzione culturale cfr. A. Pizzorusso, Manuale di istituzioni di Diritto Pubblico , Napoli, 309: “al complesso dei principi che la costituzione dedica ai rapporti economici si contrappone un altro non meno importante insieme di indicazioni riguardanti la tutela minima da assicurare alla vita umana, considerata quale valore in sé, indipendentemente dall’impiego delle energie dell’uomo per finalità di carattere politico od economico. Si apre così un ulteriore importante profilo della tutela costituzionale che trova il suo nucleo essenziale nella garanzia della libertà personale e degli altri diritti fondamentali ad essa in vario modo correlati, ma che si manifesta altresì in un complesso di regole generali tendenti a creare una situazione ambientale che renda quanto più è possibile agevole l’esercizio delle libertà individuali. […] E poiché tanto queste regole generali, quanto il principio di tutela della persona e le sue varie specificazioni, trovano il loro fondamento in un complesso di scelte che rappresentano l’accettazione di un determinato modello di cultura ed il rifiuto di quelli ad esso contrapponibili, sembra opportuno riunire la trattazione di questi problemi sotto una comune concezione di “costituzione culturale”, da affiancare a quella di costituzione economica, ma mantenendola ben distinta da essa, pur se i nessi e le interferenze tra i due ordini di problemi sono tutt’altro che rari” . Per un’indagine sui rapporti tra cultura e Costituzione cfr. P. Haberle, Per una dottrina della Costituzione come scienza della cultura , Roma, 2001.
[55] G. Famiglietti, La tutela della cultura, cit., 389, che indagando sul contenuto della Costituzione culturale, mette in evidenza la esistenza di domini distinti, tra i quali è radicato il diritto alla fruizione. In una prima dimensione ritroviamo le garanzie che assicurano il libero svolgimento dell’attività culturale, che si concretizza nelle libertà di creazione e trasmissione della cultura (art. 9, 33 Cost.). In una seconda dimensione ritroviamo le tutele delle diversità culturali (si pensi alle norme costituzionali a presidio delle minoranze linguistiche, delle confessioni religiose e delle autonomie). In una terza dimensione troviamo la tutela del diritto alla cultura, che si sviluppa attraverso tre angolazioni, tra le quali è annoverabile il “diritto collettivo alla fruizione artistica culturale e scientifica”. Cfr. anche M. Carcione, Dal riconoscimento dei diritti culturali nell’ordinamento italiano alla fruizione del patrimonio culturale come diritto fondamentale , in Aedon, 2013, 1 ss. Cfr. sul contenuto della fruizione C. Castaldo, La fruizione come elemento di definizione del regime giuridico del bene culturale , in Dir. amm., 2022, 1145 ss.
[56] Sul nesso tra sviluppo della personalità e patrimonio culturale nazionale cfr. M.A. Cabiddu, La società del “bellessere” e il suo sistema, in www.rivistaaic.it ., 2022, 28 ss.
[57] Sulla nozione di identità M. Dogliani, Costituente e identità nazionale , in Dir. pub., 2001, 57 ss.; L. Ferrajoli, Cittadinanza e diritti fondamentali , in Teoria politica, 1993, 63 ss.
[58] R. Cavallo Perin, Il diritto al bene culturale, in Dir. amm., 2016, 498.
[59] Per un recente studio sul catalogo dei diritti culturali, quali diritti fondamentali, tra i quali il diritto alla diversità culturale, cfr. G. Cavaggion, Diritti culturali e modello costituzionale di integrazione , Torino, 2018, 97 ss.
[60] M. V. Lumetti, Il centro storico tra bene culturale e paesaggistico, in P. Stella Richter (a cura di), Governo del territorio, cit., 376.
[61] Corte cost. n. 118/1990.
[62] Sia consentito rinviare N. Pignatelli, La giurisdizione dei diritti costituzionali tra potere pubblico e interesse legittimo: la relativizzazione dell’inviolabilità , Pisa, 2013; Id., I diritti inviolabili nel riparto di giurisdizione: la resistenza di un “falso” costituzionale , in www.federalismi.it, 2020. In una diversa prospettiva R. Cavallo Perin, Il diritto al bene culturale , in Dir. amm., 2016, 495 ss. afferma che “la fruizione del bene culturale è l’oggetto di un diritto soggettivo proprio”.
[63] Corte cost. n. 232/2005.
[64] P. Marzaro, Gli ‘altri beni culturali’, cit., 430 secondo qui “è questa radicazione, del resto, l’essere ‘espressione di una memoria ‘particolare’, coltivata in quelle terre da parte di quelle persone, con le proprie peculiarità e le proprie storie la ratio delle normative regionali di tutela – diversa e aggiuntiva – ed è questa radicazione a legittimare la centralità della pianificazione urbanistica, a tutti livelli del territorio, ma certamente insostituibile a livello locale, dove la memoria può ancora parlare e trasmettersi alle generazioni future, in quanto segno di quell’affectio, di quelle identità minori”.
[65] S. Sicardi, Essere di quel luogo. Brevi considerazioni sul significato di territorio e di appartenenza territoriale , in Pol. Dir., 2003, 115.
[66] G.F. Cartei, Codice dei beni culturali e del paesaggio e Convenzione europea: un raffronto , in Aedon, 2008, 1 ss.; R. Priore, Verso l’applicazione della Convenzione europea del paesaggio in Italia, in Aedon, 2005, 1 ss.; G. Severini, “Paesaggio”: storia italiana ed europea di una veduta giuridica, in Aedon, 2019, 1 ss.; G. Cerrina Ferroni, in www.federalismi.it , 2019, 2 ss.
[67] G. Severini, P. Carpentieri, La ratifica della Convenzione di Faro “sul valore del patrimonio culturale per la società” vs tutela dei beni culturali , in www.federalismi.it, 2021, 224 ss.; P. Carpentieri, Il ruolo del paesaggio e del suo governo nello sviluppo organizzativo e funzionale del Ministero e delle sue relazioni inter-istituzionali , in Aedon, 2018, 9 ss.; C. Camorosino, La Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società , in Aedon, 2013, 1 ss.; A. Gualdani, L’Italia ratifica la Convenzione di Faro: quale incidenza nel diritto del patrimonio culturale italiano? , in Aedon, 2020, 1 ss.; V. Di Capua, La Convenzione di Faro. Verso la valorizzazione del patrimonio culturale come bene comune? , in Aedon, 2021, 1 ss.
[68] Per un commento alla l. cost. n. 1/2022, tra i molti, cfr. R. Bifulco, Primissime riflessioni intorno alla l. cost. n. 1/2022 in materia di tutela dell’ambiente , in www.federalismi.it, n. 11, 1ss., 2022; R. Montaldo, La tutela costituzionale dell’ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost.: una riforma opportuna e necessaria? in www.federalismi.it, n. 13, 2022, 187 ss.; R. Cabazzi, Dalla ''contrapposizione'' alla ''armonizzazione''? Ambiente ed iniziativa economica nella riforma costituzionale , in www.federalismi.it, n. 7/2022, 31 ss.; F. De Leonardis, La riforma “bilancio” dell’art. 9 Cost. e la riforma “programma” dell’art. 41 Cost. nella legge costituzionale n. 1/2022: suggestioni a prima lettura , in Apertacontrada, 2022, 2 e ss; D. Porena, 'Anche nell’interesse delle generazioni future'. Il problema dei rapporti intergenerazionali all’indomani della revisione dell’art. 9 della Costituzione , in www.federalismi.it, n. 15, 2022, 121 ss; P.D. Logroscino, Economia e Ambiente nel tempo della Costituzione , in www.federalismi.it, n. 29, 2022; S. Grassi, La tutela dell’ambiente nelle fonti internazionali, europee ed interne , in www.federalismi.it, focus n. 13, 2023.
[69] In senso utile G.F. Cartei, Note critiche a margine di un disegno di legge in materia di rigenerazione urbana , in Munus, 2022, afferma che la nozione di “governo del territorio” sarà sempre più “conformata” dall’art. 9, 3° comma, Cost., ben oltre il paradigma “ecologico”, posto che “non è difficile immaginare che all’organizzazione futura del territorio si chiederà non solo la produzione di esternalità ambientali, ma altresì, delle condizioni sociali necessarie per la vivibilità urbana”.
[70] Cfr. C. Videtta, Cultura e sviluppo sostenibile. Alla ricerca del IV Pilastro , Torino, 2018, 18, che mette in evidenza come la proiezione intergenerazionale sia “propria e intrinseca nel DNA della nozione di patrimonio culturale”. Su questi profili da ultimo M. Cecchetti, Il “posto” della tutela ecologica nella Costituzione: tra revisione costituzionale e principi supremi , in Scritti in memoria di Beniamino Caravita di Toritto, Napoli, 2024, 96 ss.; C. De Fiores, La questione costituzionale delle generazioni future tra istanze tecnocratiche e democrazia , ivi, 145 ss.; S. Petitti, La salvaguardia degli interessi delle generazioni future nella giurisprudenza costituzionale: spunti di riflessione , ivi, 483 ss; V. De Santis, Patrimonio culturale e generazioni future , in V. Giomi, P. Milazzo (a cura di), Beni culturali e diritto , Pisa, 2023, 27 ss.
[71] Corte cost. n. 179/2019. Su questa pronuncia cfr. tra gli altri N. Durante, La rigenerazione urbana, tra buoni propositi e scarsi risultati , in www.lexambiente.it, 2024, 1 ss.
[72] F. Salvia, Le testimonianze culturali e urbanistiche del passato: le ragioni di una maggior tutela. Vecchi e nuovi dilemmi su centri storici e periferie urbane , in Dir. soc., 2006, 327 ss.
[73] Si utilizza qui la nozione di “minoranza” in senso meramente “occasionale” (A. Pizzorusso, Minoranze e maggioranze, Torino, 1992, 50) e a-tecnico, ossia come minoranza che si forma ai limitati fini dell’apprezzamento di un patrimonio culturale ulteriore rispetto a quello nazionale, per quanto gli individui di quella minoranza non siano certamente esclusi dalla fruizione anche del patrimonio culturale nazionale. Peraltro l’abuso della nozione di minoranza (nello specifico da parte del legislatore regionale in relazione alla stessa comunità regionale) trova un limite fermo nella giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 81/2018) “In questa cornice debbono intendersi le affermazioni contenute nella sentenza n. 170 del 2010 – relative alla tutela delle minoranze linguistiche, ma da estendersi, per le ragioni sopra esposte, alla più generale tutela dei gruppi minoritari – secondo le quali non è consentito al legislatore regionale configurare o rappresentare la “propria” comunità in quanto tale come “minoranza”, «essendo del tutto evidente che, in linea generale, all’articolazione politico-amministrativa dei diversi enti territoriali all’interno di una medesima più vasta, e composita, compagine istituzionale non possa reputarsi automaticamente corrispondente – né, in senso specifico, analogamente rilevante – una ripartizione del “popolo”, inteso nel senso di comunità “generale”, in improbabili sue “frazioni”» (sentenza n. 170 del 2010). Riconoscere un tale potere al legislatore regionale significherebbe, infatti, introdurre un elemento di frammentazione nella comunità nazionale contrario agli artt. 2, 3, 5 e 6 Cost. Lasciata, dunque, in disparte ogni considerazione circa la compatibilità della legge regionale impugnata con lo specifico contenuto della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, a cui essa si richiama – la quale peraltro contiene principalmente un elenco di diritti di natura individuale, ma non configura diritti collettivi dei gruppi minoritari – la legge regionale impugnata, nel qualificare il «popolo veneto» come “minoranza nazionale” ai sensi della citata convenzione-quadro, contrasta con i principi sviluppati nella giurisprudenza di questa Corte in materia”.
[74] Cfr., pur in una prospettiva diversa, L.M. Guzzo, Il patrimonio culturale, in particolare quello di rilevanza religiosa, e la Convenzione di Faro , in Aedon, 1/2022, 1 ss. La problematica intercetta quella della edilizia di culto. Sia consentito rinviare a N. Pignatelli, La dimensione fisica della libertà religiosa: il diritto costituzionale ad un edificio di culto , in www.federalismi.it, 2015, 1 ss.
[75] Sul possibile contatto tra il tema dei patrimoni culturali e quello delle minoranze linguistiche cfr. Corte cost. n. 81/2018: “Successivamente, questa Corte ha ritenuto che anche i legislatori regionali e provinciali potessero adottare atti normativi in materia, specialmente al fine di garantire e valorizzare l’identità culturale e il patrimonio storico delle proprie comunità, ma sempre nel pieno rispetto di quanto determinato in materia dal legislatore statale (sentenze n. 261 del 1995, n. 289 del 1987 e n. 312 del 1983)”.
[76] G. Pitruzzella, in G. Falcon (a cura di), Lo Stato autonomista, Bologna, 1998, secondo cui “quando si pone l’accento sulla fruizione collettiva del patrimonio culturale cresce l’importanza del contesto locale in cui il bene è inserito e perciò gli attori istituzionali che rappresentano e governano questo contesto”.
[77] Corte cost. n. 118/1990.
[78] Corte cost. n. 94/2003.
[79] Corte cost. n. 232/2005.
[80] Corte cost. n. 194/2013.
[81] Corte cost. n. 194/2013.
[82] G. Severini, sub. Artt. 1-2, cit., 16.
[83] M. Cecchetti, Ambiente, paesaggio, e beni culturali, in G. Corso, V. Lopilato (a cura di), Il diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali (a cura di), Milano, 2006, 337.
[84] M. Cecchetti, subart. 131, in G. Famiglietti, N. Pignatelli (a cura di), Codice dei beni culturali e del paesaggio, Roma, 2018, secondo cui “anche al fine di non porsi in aperta contraddizione con l’impostazione della Convenzione europea del paesaggio, sembra preferibile propendere per l’ipotesi interpretativa secondo cui la tutela del paesaggio si appunta su quegli aspetti di esso che costituiscono espressione di valori culturali prima di tutto delle comunità insediate sul territorio di riferimento e solo di riflesso anche dell’identità nazionale”. Per quanto la rilevanza della Convenzione europea del Paesaggio può essere maggiormente apprezzata al di fuori dell’art. 9, 2° comma, Cost. Cfr. G.L. Conti, Dal Paesaggio di Predieri ai Paesaggi della Convenzione di Firenze , in www.costituzionalismo.it , n. 3/2010.
[85] In questi termini, invece, si esprime Corte cost. n. 194/2013.
[86] In tal senso, pur con riferimento a beni provenienti da fuori dei confini nazionali, G. Severini, sub. Artt. 1-2, cit., 17, secondo cui il patrimonio culturale nazionale è un “insieme complesso ma unitario” che “esprime un’aggregazione progressiva, consolidatasi nel tempo, di cui la singola cosa non necessariamente fa parte della genesi ”.
[87] Su questa mobilità, nei rapporti Stato-Regioni, si tornerà nel paragrafo 3.5.
[88] Più in generale, in relazione ai rapporti tra art. 9 Cost. e competenze, cfr. M. Cecchetti, sub art. 9 Cost., secondo cui “il vero nodo di fondo, che spiega, almeno in parte, le perduranti ambiguità della nozione di ‘bene culturale’ e del suo rapporto con le espressioni dell’art. 9, finisce per essere la considerazione che tale nozione è inevitabilmente condizionata dalle altre due questioni interpretative poste dalla norma costituzionale: quale siano i compiti della Repubblica e come si configuri il riparto di competenze tra i soggetti pubblici chiamati ad assolverli”.
[89] Corte cost. nn. 378/2000; 478/2002; 140/2015.
[90] Corte cost. nn. 307/2004; 153/2011.
[91] A. Sau, Beni e attività culturali tra Stato e Regioni: ciò che resta della stagione della regionalizzazione , in L. Cuocolo, E. Mostacci (a cura di), Pisa, 2023, 205.
[92] Cfr. Corte cost. nn. 94/2003; 232/2005.
[93] Parla di coincidenza N. Aicardi, L’ordinamento amministrativo dei beni culturali , Torino 2002, 74. Tale connessione emerge anche nella giurisprudenza costituzionale. Cfr. Corte cost. nn. 9/2004; 26/2004. In una diversa prospettiva cfr. F.S. Marini, Lo statuto costituzionale dei beni culturali , cit., 276 ss., secondo cui il “patrimonio storico artistico della Nazione” è una species del genus beni culturali.
[94] Cfr. A. Mitrotti, Il riparto di competenze in materia di beni culturali alla luce del felice coniugio tra redditività del patrimonio culturale e diritto di accesso ai beni culturali , in www.aic.it., 2018, 20.
[95] Cfr. Corte cost. n. 26/2004, su cui F.S. Marini, La tutela e la valorizzazione dei beni culturali come materia attività nella più recente giurisprudenza costituzionale , in Giur. cost., 1/2004, 197 ss.
[96] G. Falcon, Modello e transizione nel nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione , in Le Regioni, 2001, 1247 ss.
[97] Cfr. ex plurimis Corte cost. n. 106/2022; 66/2018; 246/2017. Sulla giurisprudenza costituzionale in materia di paesaggio cfr. anche R. Fattibene, L’evoluzione del concetto di paesaggio tra norme e giurisprudenza costituzionale: dalla cristallizzazione all’identità , in www.federalismi.it, 2016, 2 ss.
[98] P.L. Portaluri, Dal diritto delle costruzioni nelle città al governo del territorio , in www.federalismit.it, 2019, 13 ss.
[99] Corte cost. n. 94/2003: “È necessario innanzitutto valutare se le disposizioni della legge regionale del Lazio n. 31 del 2001, eccedano la competenza regionale da due punti di vista diversi: in primo luogo, quello concernente l'ipotizzata invasione della riserva esclusiva dello Stato, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), in tema di “tutela dei beni culturali”; in secondo luogo, quello riguardante la presunta violazione dei principi fondamentali determinati dal legislatore nazionale in tema di “valorizzazione dei beni culturali”.
La distinzione fra tutela e valorizzazione dei beni culturali può essere desunta dalla legislazione vigente ed in particolare dagli articoli 148, 149 e 152 del decreto legislativo 11 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352): in particolare, il terzo comma dell'art. 149 del d.lgs. n. 112 del 1998 riserva alla esclusiva competenza statale anzitutto la “apposizione di vincolo, diretto e indiretto, di interesse storico o artistico e vigilanza sui beni vincolati” e tutto quanto riguarda “autorizzazioni, prescrizioni, divieti, approvazioni e altri provvedimenti, anche di natura interinale, diretti a garantire la conservazione, l'integrità e la sicurezza dei beni di interesse storico o artistico” ed “esercizio del diritto di prelazione”; il primo comma dell'art. 152 del medesimo testo normativo afferma, invece, che “lo Stato, le regioni e gli enti locali curano, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali”. Queste funzioni peraltro ineriscono ai beni culturali quali attualmente definiti e disciplinati dal d. lgs. n. 490 del 1999, ma non riguardano altri beni cui, a fini di valorizzazione, possa essere riconosciuto particolare valore storico o culturale da parte della comunità regionale o locale, senza che ciò comporti la loro qualificazione come beni culturali ai sensi del d. lgs. n. 490 del 1999 e la conseguente speciale conformazione del loro regime giuridico . La legge regionale del Lazio n.31 del 2001 non pretende quindi di determinare una nuova categoria di beni culturali ai sensi del d.lgs. n. 490 del 1999, ma prevede semplicemente una disciplina per la salvaguardia degli “esercizi commerciali ed artigianali del Lazio aperti al pubblico che hanno valore storico, artistico, ambientale e la cui attività costituisce testimonianza storica, culturale, tradizionale, anche con riferimento agli antichi mestieri”. Questi esercizi commerciali vengono individuati da parte dei Comuni territorialmente competenti sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione Lazio d'intesa con le Sovrintendenze statali territorialmente competenti (secondo quanto previsto dall'art. 2, commi secondo e terzo, della legge regionale del Lazio n.31 del 2001) e vengono inseriti in un elenco regionale, che viene anche pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, così assumendo la denominazione di “locali storici”. Quest'ultima qualificazione rende semplicemente ad essi applicabile la speciale disciplina della legge regionale in tema di finanziamenti per la loro valorizzazione e per il sostegno delle spese connesse all'aumento dei canoni di locazione, senza produrre alcuno dei vincoli tipici della speciale tutela dei beni culturali di cui al d.lgs. n. 490 del 1999”. Su tale pronuncia cfr. P. Carpentieri, Le Regioni possono introdurre nuove tipologie di beni culturali, ma ai soli fini della valorizzazione , in www.giustizia-amministrativa.it , 2003; P. Carpentieri, Tutela e valorizzazione dei beni culturali , in Urb. App., 2003, 1017 ss.; S. Foà, La legittimità costituzionale della l.r. Lazio sulla tutela e valorizzazione dei locali storici , in Giorn. dir. amm., 2003, 907 ss.; F.S. Marini, I beni culturali e i locali storici del Lazio: una differenza storico-normativa , in Giur. cost., 2003, 775 ss.
[100] Cfr. ex plurimis Corte cost. n. 138/2020.
[101] Cfr. F.S. Marini, I beni culturali e i locali storici del Lazio: una differenza storico-normativa , cit., 776; M. Picchi, Tutela e valorizzazione dei beni culturali nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Verso un progressivo accentramento delle competenze? , in www.forumcostituzionale.it , 2017, 17. Cfr. anche S. Foà, La legittimità costituzionale della l.r. Lazio sulla tutela e valorizzazione dei locali storici , cit., 908, secondo cui “a dire il vero la Corte avrebbe potuto sviluppare il ragionamento: non trattandosi di beni culturali stricto senso,gli stessi immobili avrebbero potuto essere anche ‘tutelati’ dal legislatore regionale (…) Ben avrebbe potuto, procedendo ulteriormente nel proprio iter argomentativo, giustificare interventi del legislatore regionale rientranti in una nozione di tutela non riferita ai beni culturali di cui al testo unico, ma a beni che possono vantare una diversa qualificazione ed un titolo differente a fondamento della loro protezione o ‘salvaguardia’. Al riguardo non esisterebbe, infatti, alcun ostacolo desumibile dall’art. 117 Cost .”.
[102] La Corte costituzionale nella sentenza n. 194/2013 utilizza l’espressione “ al di fuori dello schema tutela/valorizzazione”.
[103] S. Parisi, La competenza residuale, in Regioni, 2011, 341 ss.
[104] F. Benelli, La smaterializzazione delle materie. Problemi teorici ed applicativi del nuovo Titolo V della Costituzione , Milano, 2006.
[105] M. Luciani, L’autonomia legislativa, in Regioni, 2004, 365.
[106] Su queste problematiche sia consentito rinviare a N. Pignatelli, Il “governo del territorio” nella giurisprudenza costituzionale: la recessività della materia , Torino, 2012, 187 ss.
[107] Sulla recessività della materia “governo del territorio” cfr. N. Pignatelli, Il “governo del territorio” nella giurisprudenza costituzionale: la recessività della materia , cit., 201 ss.
[108] Corte cost. n. 235/2005. Su questa pronuncia cfr. G. Cocco, Le relazioni tra ambiti materiali differenziati e livelli di governo diversi. La Corte si “complica la vita” , in Riv. giur. amb., 2006, 70 ss; R. Agnoletto, Le finalità di tutela dei beni culturali nell’ambito della legislazione regionale , in Riv. giur. ed., 2005, 1414 ss.; A. Roccella, Governo del territorio: rapporti con la tutela dei beni culturali e l’ordinamento civile , in www.formucostituzionale.it , 1 ss.
[109] Corte cost. n. 232/2005.
[110] Corte cost. n. 232/2005.
[111] Corte cost. n. 401/2007. Di tutela aggiuntiva, in relazione più in generale agli altri beni culturali, ha parlato anche Corte cost. n. 194/2013.
[112] M. Cecchetti, subart. 9 Cost., cit.,
[113] Sulla rilevanza della trasversalità per la tutela dei beni culturali urbanistici, nel senso della sentenza della Corte costituzionale, cfr. già F. Salvia, La tutela trasversale dei beni culturali. I beni culturali urbanistici , in Dir. soc., 2003, 368 ss. Di “altre tutele” parla C. Barbati, Governo del territorio, beni culturali e autonomie: luci e ombre di un rapporto , in Aedon, 2009, 4.
[114] Corte cost. n. 232/2005. Più in generale per una analisi della giurisprudenza costituzionale cfr. P. Scarlatti, Beni culturali e riparto di competenze tra Stato e Regioni nella più recente giurisprudenza della Corte costituzionale , in Le Regioni, 2018, 645 ss.; R. Bifulco, Tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali (art. 117.2.S) e Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117.3.), in A. Celotto, R. Bifulco (a cura di), Le materia dell’art. 117 nella giurisprudenza costituzionale dopo il 2001 , Napoli, 225 ss.; P. Milazzo, I beni culturali nella forma di stato regionale. Un riparto di competenze “difficile” e la prospettiva del regionalismo differenziato , in V. Giomi, P. Milazzo (a cura di), cit.,103 ss.; M. Picchi, Tutela e valorizzazione dei beni culturali nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Verso un progressivo accentramento delle competenze? , in www.forumcostituzionale.it , 2017, 1 ss.; F. Petrangeli, Il riparto di funzioni legislative tra Stato e Regioni in materia di beni culturali , in P. Bilancia (a cura di), La valorizzazione dei beni culturali tra pubblico e privato , Milano, 2015, 43 ss. In modo specifico sul parallelismo sopra richiamato cfr. E. Buoso, La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale dopo la riforma del Titolo V della Costituzione: una proposta interpretativa alla luce della giurisprudenza costituzionale , in Riv. giur. urb., 2006, 485 ss.
[115] “La tutela dei beni culturali, inclusa nel secondo comma dell'art. 117 Cost. sotto la lettera s) tra quelle di competenze legislativa esclusiva dello Stato, è materia che condivide con altre alcune peculiarità. Essa ha un proprio ambito materiale, ma nel contempo contiene l'indicazione di una finalità da perseguire in ogni campo in cui possano venire in rilievo beni culturali. Essa costituisce anche una materia-attività, come questa Corte l'ha già definita (v. sentenza n. 26 del 2004), condividendo alcune caratteristiche con la tutela dell'ambiente, non a caso ricompresa sotto la stessa lettera s) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione. In entrambe assume rilievo il profilo teleologico della disciplina” 8Corte cost. n. 232/2005).
[116] Sulla trasversalità della materia ambientale cfr., già prima della riforma del Titolo V, G. Morbidelli, Il regime amministrativo speciale dell’ambiente , in Studi in onore di Alberto Predieri, Milano, 1996.
[117] “La materia del governo del territorio, comprensiva dell'urbanistica e dell'edilizia (v. sentenze n. 362 del 2003 e n. 196 del 2004), rientra tra quelle di competenza legislativa concorrente. Spetta perciò alle Regioni, nell’ambito dei principi fondamentali determinati dallo Stato, stabilire la disciplina degli strumenti urbanistici. Ora, non v'è dubbio che tra i valori che gli strumenti urbanistici devono tutelare abbiano rilevanza non secondaria quelli artistici, storici, documentari e comunque attinenti alla cultura nella polivalenza di sensi del termine” (Corte cost. n. 232/2005).
[118] Devono ritenersi illegittime le normative regionali che restringono l’ambito delle tutele. Cfr. ex plurimis Corte cost. n. 66/2012; 246/2017; 74/2021; 144/2021; 106/2022.
[119] Cfr. Corte cost. n. 197/2014, secondo cui le Regioni hanno il potere di “incrementare i livelli della tutela (…) senza però compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato”.
[120] Corte cost. n. 164/2021. Più in generale sul rapporto tra autonomia regionale e tutele incrementali cfr. 58/2013; 7/2019; 158/2021; 135/2022; 58/2023. In riferimento specifico alla tutela dei beni culturali cfr. anche Corte cost. nn. 51/2006; 182/2006; 232/2008; 12/2009; 164/2009; 101/2010; 234/2010; 244/2012; 201/2014.
[121] Sulla problematica dell’ambiguità della legittimazione regionale ad incidere sulla dimensione ambientale (art. 117, 2° comma, let. s), Cost.) cfr. M. Cecchetti, La materia “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” nella giurisprudenza costituzionale: lo stato dell’arte e i nodi ancora irrisolti , in www.federalismi.it., 2009, n. 7, 8.
[122] Diversamente la Corte costituzionale (n. 388/2005), in una prospettiva coerente, ha rigetto una ricorso statale avverso una normativa regionale (in materia di tratturi, ossia di beni “codicistici”) sul presupposto che la normativa regionale prevedeva una tutela ulteriore rispetto allo standard statale, quindi un’addizione rispetto al livello ex art. 117, 2° comma, let. s).
[123] Il modello degli standard e quindi il rapporto competenza legislativa statale (art. 117, 2° comma, let. s) - “governo del territorio (art. 117, 3° comma, Cost.) può dirsi quindi coerentemente applicabile ai “centri storici”, essendo questi qualificati come “beni paesaggistici” (art. 136 dlgs. n. 42/2004), in quanto tali riconducibili nell’alveo dell’art. 9, 2° comma, Cost. e quindi espressione della competenza legislativa statale. Cfr. in tal senso Corte cost. n. 130/2020, secondo cui i centri storici si trovano “al croceviafra le competenze regionali in materia urbanistica o di governo del territorio e la tutela dei beni culturali”. Su questa pronuncia cfr. A. Perini, Una pronuncia per tornare a riflettere sul regime giuridico dei centri storici. Note a margine di Corte costituzionale 26 giugno 2020 n. 130 , in www.forumcostituzionale.it , 2021, 68 ss.
[124] A. Poggi, La difficile attuazione del Titolo V: il caso dei beni culturali , in www.federalismi.it, 2003, 7, afferma che “una dilatazione, anch’essa concordata, della legislazione regionale che in questo caso potrebbe dilatarsi potendo contare, peraltro, su una rilettura del nesso tra le competenze legislative concorrenti e l’art. 9 Cost.”
[125] R. Bin, Ambiente sempre! Lo dice la Corte costituzionale (ma subito si smentisce) , in www.lacostituzione.info , 2021, commentando Corte cost. 177/2021. In senso analogo, sul “punto di equilibrio”, cfr. Corte cost. nn. 286/2019; 88/2020; 106/2020; 121/2022.
[126] In ogni caso non può certamente negarsi la difficoltà, in concreto, di individuare i limiti dell’autonomia regionale, in relazione alla tutela dei “patrimoni culturali urbanistici”, soprattutto con riferimento ai beni paesaggistici residuali. Cfr. Corte cost. n. 113/2008, che ha dichiarato illegittima una normativa regionale, in materia di “governo del territorio”, incidente sulla competenza legislativa statale avente ad oggetto la tutela del paesaggio intesa come morfologia del territorio, cioè come ambiente nel suo aspetti visivo.
[127] Questo assunto è stato sviluppato in N. Pignatelli, Il “governo del territorio” nella giurisprudenza costituzionale: la recessività della materia , cit., 205. La tesi sembra condivisa da P. Chirulli, I rapporti tra urbanistica e discipline differenziate , in F.G. Scoca, P. Stella Richter, P. Urbani (a cura di), Trattato di diritto urbanistico , Torino, 2018, 52.
[128] Corte cost. n. 202/2021; 219/2021. Le pronunce sono valorizzate anche da P. Carpentieri, Riflessi della tutela e della valorizzazione del patrimonio paesaggistico-culturale sulla disciplina urbanistica-edilizia , in www.giustizia-amministrativa.it , 2021, 5.
[129] A. Bartolini, Patrimonio culturale e urbanistica, cit., 12.
[130] S. Settis, Italia Spa, cit., passim.
[131] A. Poggi, La difficile attuazione del Titolo V: il caso dei beni culturali , cit., 7.
[132] Cons. St., sez. IV, 2710/2012 su cui cfr. P. Urbani, Conformazione dei suoli e finalità economico sociali , in Urb. app., 1/2023, 59 ss.
[133] Cons. St., sez. IV, n. 2221/2016.
[134] Corte cost. n. 179/2019.
[135] Corte cost. n. 303/2003.
[136] R. Bin, Il governo delle politiche pubbliche tra Costituzione ed interpretazione del giudice costituzionale , in Le Regioni, 2013, 510 ss.
[137] N. Pignatelli, Il “governo del territorio”, cit., 79 ss. Non può negarsi come dalla interazione esterna tra il «governo del territorio» e le altre materie di competenza esclusiva statale (art. 117, 2° comma, Cost.), di competenza concorrente (art. 117, 3° comma, Cost.) e di competenza residuale regionale (art. 117, 4° comma, Cost.) emerga una diffusa recessività materiale. Tale recessività può dirsi gerarchica in relazione alla forza assiologica e valoriale che gli ambiti legislativi esclusivi statali (art. 117, 2° comma, Cost.) proiettano in seno al «governo del territorio»; si pensi ai rapporti con «l’ordinamento civile», l’«ordinamento penale», la «sicurezza», la «tutela della concorrenza» e la «tutela dell’ambiente». In tale logica non si assiste in realtà ad un’implementazione materiale del «governo del territorio» attraverso una dilatazione dei fini (ambientali, di tutela dei beni culturali, di tutela penale del territorio, ecc.) ma ad una perimetrazione conformativa, in quanto tale restrittiva. Quanto invece alle interazioni tra «governo del territorio» e le materie di competenza concorrente (art. 117, 3° comma, Cost.) la suddetta recessività può dirsi generata da una logica di specialità , che attribuisce al primo, in quanto ambito costituzionale assai ampio ed indeterminato, una forte debolezza rispetto agli altri titoli competenziali (in relazione ai contatti del «governo del territorio» con la «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», la «tutela della salute», i «porti e gli aeroporti civili», la «valorizzazione dei beni culturali»). A questo si aggiunga come la natura debole del «governo del territorio» emerga anche dai rapporti con le materie innominate, maggiormente contigue al primo («lavori pubblici», «espropriazioni»), dai quali si desume una sorta di recessività funzionale, caratterizzata da un’incapacità del «governo del territorio» di sviluppare una forza assorbente generale rispetto ad ambiti non riconducibili ex se nell’alveo dell’art. 117, 4° comma, Cost. e da ricondurre (caso per caso) invece sotto la copertura costituzionale del titolo di legittimazione funzionalmente connesso all’interesse disciplinato.
In questa logica il «governo del territorio», quale ambito legislativo costituzionale, esiste e vive (nella concretezza delle dinamiche del processo costituzionale) come dimensione residuale : è «governo del territorio» ciò che, pur attenendo alla disciplina degli «usi ordinati del territorio», nonè assimilabile ai limiti conformativi imposti dagli ambiti di competenza esclusiva statale (art. 117, 2° comma, Cost.), ciò che non ricade sotto la copertura costituzionale di altri ambiti disciplinanti in via specifica gli usi del territorio (art. 117, 3° comma, Cost.), ciò che non è di competenza residuale (art. 117, 4° comma, Cost.), senza essere funzionalmente attratto in altro ambito competenziale contiguo.
Può così affermarsi, in via sintetica, che sussiste la competenza del «governo del territorio» esclusivamente quando non siano individuabili interessi ulteriori rispetto al mero interesse di gestione razionale dell’assetto del territorio e di controllo sugli usi dello stesso.
[138] N. Pignatelli, Il “governo del territorio”, cit., 207. In una prospettiva strettamente costituzionalistica, sembra di poter sostenere, alla luce della suddetta recessività materiale del «governo del territorio» e quindi della conseguente scissione tra nozione legislativa e nozione amministrativa, che la Corte costituzionale si sia vista costretta a ridimensionare la volontà del legislatore costituzionale (l. n. 3/2001) ed il suo portato testuale («governo del territorio»), svolgendo una funzione di contropotere rispetto all’attribuzione alla potestà legislativa regionale (pur concorrente) di un ambito, che storicamente e naturalmente spetta allo Stato (e quindi al suo legislatore). La Corte costituzionale sembra percepire come necessario l’esperimento di una costante interpretazione conforme del «governo del territorio» ai principi fondamentali costituzionali, al fine di garantire, in senso restrittivo, la stessa legittimità costituzionale della scelta del legislatore della l. cost. n. 3/2001. In altre parole la giurisprudenza costituzionale in materia di «governo del territorio» palesa la configurazione di un sistemico contro-limite ermeneutico interno alla stessa Costituzione, nella parte in cui il legislatore costituzionale ha introdotto una materia potenzialmente debordante rispetto all’unità dell’ordinamento giuridico.
[139] Così E. Boscolo, La nozione giuridica di paesaggio identitario ed il paesaggio “a strati” , 67.
[140] A. Roccella, Governo del territorio: rapporti con la tutela dei beni culturali e l’ordinamento civile , cit., 3.
[141] F. Salvia, Spunti di riflessione per una teoria sui beni culturali urbanistici , cit., 130.
[142] Corte cost. n. 282/2002.
[143] Corte cost. n. 94/2003. Nell’ipotesi in cui vi sia un’assenza di norme statali di principio non può certamente dirsi che il legislatore regionale sia paralizzato. Per quanto il cambiamento della formulazione letterale del testo costituzionale (art. 117, 3° comma, Cost.), ritenuta più restrittiva della precedente, avesse fatto escludere a taluni la possibilità per la potestà regionale di legiferare nelle materie a competenza concorrente in carenza di una legge-cornice, la questione è stata definitivamente superata dalla l. n. 131 (c.d. l. La Loggia), il cui art. 1, 3° comma, in conformità alla giurisprudenza costituzionale, ha disposto che la legislazione regionale concorrente deve svolgersi nell’ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in mancanza di essi, da quelli desumibili dalle leggi statali vigenti. La sopravvenienza del Titolo V ha certamente riproposto uno storico problema costituzionale, ad alto tasso di politicità, per quanto in realtà già definito in passato. È noto, infatti, come la legge n. 62/1953 (c.d. legge Scelba) prevedesse intensi limiti per la legislazione regionale, disponendo che le Regioni non avrebbero potuto legiferare fino a quando il legislatore statale non avesse approvato le leggi- cornice recanti principi fondamentali. In questa logica veniva rimesso nelle mani dello Stato il potere di congelare la funzione legislativa regionale. Tuttavia tale congelamento venne superato con la l. n. 281/1970. L’attuazione costituzionale delle Regioni passò anche attraverso la legittimazione (rectius, il riconoscimento politico) della potestà legislativa regionale ad operare in assenza di una legge cornice qualificata come tale, alla luce dei principi generali desumibili dal sistema. Evidentemente tale soluzione, come quella contenuta nella suddetta l. n. 131/2003, avrebbe scaricato definitivamente sulla Corte costituzionale la funzione di ricognizione ermeneutica dei principi ricavabili dal tessuto normativo complessivo.
[144] Come è stato puntualmente rilevato da P. Marzaro, Gli ‘altri beni culturali’ e i beni culturali urbanistici: note di sistema , cit., 430 ss., che analizza in concreto la legislazione regionale (L.R.V. n. 11/2004, artt. 13 e 40 bis; L.R.P. n. 20/200, art. 9; L.R.E. n. 24/2017, art. 32; L.R.U. n. 1/2015, art. 96).
[145] L. Casini, “Le parole e le cose”, cit., 263, mette in evidenza come la tutela aggiuntiva sia stata tradizionalmente esercitata non tanto in sede legislativa regionale quanto dagli strumenti urbanistici comunali. Cfr. anche G. De Giorgi Cezzi, Tutela dell’identità dei luoghi e rilevanza “monumentale” di un uliveto secolare , in Foro amm. – TAR, 2005, 2959, che mette in evidenza la necessità che la normativa regionale, spesso carente, disciplini le zone agricole tradizionali, espressione di identità culturale.
[146] Corte cost. n. 247/2020.
[147] Sulla necessità costituzionale di evitare tali contrapposizioni cfr. A. Poggi, La difficile attuazione del Titolo V: il caso dei beni culturali , cit., 4.
[148] C. Napoli, Le funzioni amministrative nel titolo V della Costituzione. Contributo allo studio dell'art. 118, primo e secondo comma , Torino, 2011, passim.
[149] Su questa relazione cfr. G. Sciullo, Corte costituzionale e nuovi scenari per la disciplina del patrimonio culturale , in Aedon n. 1/2017, 4.
[150] Corte cost. n. 194/2013. Sul rapporto tra tutela e valorizzazione cfr. C. Barbati, Tutela e valorizzazione dei beni culturali dopo la riforma del titolo V: la separazioni di funzioni , in Giorn. dir. amm., 2/2003, 145 ss.
[151] Corte cost. n. 140/2015. Su questa pronuncia cfr. P. Carpentieri, Il decoro dei monumenti deve attendere le intese con le Regioni: come subordinare la tutela (art. 9 Cost.) al commercio e alla “leale collaborazione” interistituzionale , in Giur. cost., 2015, 1246 ss.; S. Mabellini, Un caso di “non prevalenza” della competenza statale che segna un ulteriore passo indietro per la potestà legislativa delle Regioni , Giur. cost., 2015, 1237 ss. In senso critico cfr. G. Sciullo, Concorrenza di competenze in tema di beni culturali , in Riv. giur. urb., 2015, 379 ss. Cfr. anche Corte cost. n. 251/2016, in altra materia, in relazione alla applicazione del principio di leale collaborazione anche alla dimensione normativa delegata.
[152] P. Stella Richter, Diritto del territorio e Costituzione, in F.G. Scoca, P. Stella Richter, P. Urbani (a cura di), Trattato di diritto urbanistico , cit., 13, rileva come la “regola sarà quindi l’integrazione e non già la separazione delle competenze, la sovrapposizione e non già la distinzione”.
[153] Corte cost. n. 9/2004; 140/2015.
[154] Cons. St., sez. 14.11.2019 n. 7839; in senso analogo già Cons. St., sez. IV, 10.5.2012 n. 2710.
[155] Corte cost. n. 194/2013.
[156] Corte cost. n. 194/2013: “ La circostanza, infatti, che una specifica cosa non venga “classificata” dallo Stato come di «interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico», e dunque non venga considerata come «bene culturale», non equivale ad escludere che essa possa, invece, presentare, sia pure residualmente, un qualche interesse “culturale” per una determinata comunità territoriale: restando questo interesse ancorato, in ipotesi, a un patrimonio identitario inalienabile, di idealità e di esperienze e perfino di simboli, di quella singola e specifica comunità.
In tale contesto e solo entro tali limiti, la potestà legislativa delle Regioni può dunque legittimamente esercitarsi – al di fuori dello schema tutela/valorizzazione – non già in posizione antagonistica rispetto allo Stato, ma in funzione di una salvaguardia diversa ed aggiuntiva: volta a far sì che, nella predisposizione degli strumenti normativi, ci si possa rivolgere – come questa Corte ha avuto modo di sottolineare (sentenza n. 232 del 2005) – oltre che ai «beni culturali» identificati secondo la disciplina statale, e rilevanti sul piano della memoria dell’intera comunità nazionale, eventualmente (e residualmente) anche ad altre espressioni di una memoria “particolare”, coltivata in quelle terre da parte di quelle persone, con le proprie peculiarità e le proprie storie ”.
[157] S. Mabellini, La “presunzione di culturalità” apre un ulteriore varco statale nell’autonomia regionale , in Giur. cost., 4/2013, 2270 ss. Su questa pronuncia cfr. anche L. Casini, “Le parole e le cose”: la nozione giuridica di bene culturale nella legislazione regionale , in Giorn. Dir. amm., 2014, pag. 257 ss; S. Cavaliere, Oscillazioni in senso centralistico della giurisprudenza costituzionale in tema di altri beni culturali diversi da quelli identificati tali ai sensi della normativa statale , in amministrazioneincammino.it, 2014, 1 ss.
[158] Cfr. G. Morbidelli, subart. 10, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dei beni culturali e del paesaggio , cit., 128 ss.
[159] M. Picchi, Tutela e valorizzazione dei beni culturali nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Verso un progressivo accentramento delle competenze? , cit., 27.
[160] S. Mabellini, La “presunzione di culturalità” apre un ulteriore varco statale nell’autonomia regionale , cit., 2274. In senso critico anche A. Sau, Beni e attività culturali tra Stato e Regioni: ciò che resta della stagione della regionalizzazione. Guardando alla prossima , in Aedon, 2023, 5 ss.
[161] Cfr. F.S. Marini, I beni culturali e i locali storici del Lazio: una differenza storico-normativa , cit., 777.
[162] S. Mabellini, La “presunzione di culturalità” apre un ulteriore varco statale nell’autonomia regionale , cit., 2275.
[163] Cfr. art. 10, 3° comma, let. a), 4° comma, lett. f), g); art. 136, 1° comma, let. a) - d), Dlgs. n. 42/2004.
[164] A. Bartolini, Patrimoni culturali e limitazioni urbanistiche, cit., 11. Cfr. anche A. Crosetti, Governo del territorio e tutela del patrimonio culturale: un difficile percorso di integrazione , in Riv. giur. ed., 2018, 81 ss.
[165] A. Bartolini, Patrimoni culturali e limitazioni urbanistiche, cit., 11.
[166] G. Morbidelli, La proprietà culturale, in Il contributo della prassi notarile alla evoluzione della disciplina delle situazioni reali - Quaderni della Fondazione del Notariato, Milano, 2015, 24 ss.
[167] In generale sul contenuto di tale potere conformativo cfr. anche A. Crosetti, Governo del territorio e tutela del patrimonio culturale: un difficile percorso di integrazione , 88 ss.; P. Marzaro, Gli ‘altri beni culturali’ e i beni culturali urbanistici: note di sistema , cit., 434 ss. Per quanto G. Severini, I beni culturali “minori , cit., 30, abbia messo in evidenza come sia “opportuno che l’intervento pubblico - conformemente al principio di sussidiarietà – si collochi ad un livello minore, fatto di aiuto e non di ablazione: un intervento leggero e a basso regime, incentrato su una amministrazione di servizi invece che su un amministrazione di direzione, vale a dire più un sostegno che una limitazione o un condizionamento”.
[168] Cfr. Cons. giust. amm. sic., 22.3.2006 n. 107 , secondo cui “mentre la tradizionale legislazione sui beni culturali (coniata secondo i canoni estetici degli anni ’30) tendeva essenzialmente ad una tutela puntiforme delle c.d. ‘cose d’arte’ (con la sola apertura del ‘vincolo indiretto’), viceversa la successiva e più evoluta normativa sui ‘centri storici’ tende a conservare e tramandare nella loro integrità interi complessi urbanistici-architettonici, che – in quanto prodotti irripetibili di un ciclo economico e sociale ormai chiuso – assumono il valore di beni culturali a tutti gli effetti (‘beni culturali urbanistici’)”.
[169] A. Bartolini, Patrimoni culturali e limitazioni urbanistiche, cit., 13.
[170] Corte cost. n. 478/2002.
[171] Cfr. anche, nella giurisprudenza amministrativa, TAR Toscana n. 1499/1988; TAR Toscana n. 1349/1987; Cons. St., sez. IV, 20.9.2005 n. 4818/2005; TAR Liguria n. 522/2013; Cons. St., sez. IV, n. 519/2016; Cons. St., sez. 14.11.2019 n. 7839; TAR Veneto, 26.3.2018 n. 349. Per una analisi della giurisprudenza amministrativa cfr. L. Casini, “Giochi senza frontiere?”: giurisprudenza amministrativa e patrimonio culturale , in Riv. trim. dir. pub., 2019, 914 ss. In senso maggiormente restrittivo, invece, Corte cost. n. 182/2006.
[172] Così V. Onida, Tutela del paesaggio e pianificazione territoriale, in Riv. giur. amb., 1989, 756.
[173] Corte cost. n. 202/2021; 219/2021.
[174] Cons. St., sez. IV, 2710/2012 (c.d. caso Cortina).
[175] Sul principio partecipativo in materia pianificatoria Cfr. Corte cost. n. 17/2023.
[176] Sulla problematica cfr. I. Impastato, La sussidiarietà presa sul serio: il caso dei beni culturali urbanistici tra tutela parallela e sistema multipolare integrato , in Dir. soc., 2008, 395 ss.
[177] Sui limiti di tale potere, alla luce della giurisprudenza amministrativa, cfr. anche G. Sobrino, Gli Enti territoriali possono sottoporre a tutela gli immobili di interesse culturale presenti nel loro territorio? (Nota a Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 519/2016) , in www.rivistaaic.it, 2016, 1 ss.
[178] Cfr. Cons. St., II, 24.12.2021 n. 8580; Cons. St., sez. IV, 22.8.2018 n. 5029; Cons. St., sez. IV, 9.2.2016 n. 516; Cons. St., sez. IV, 29.2.2016 n. 846; Cons. St., sez. IV, 12.6.2013 n. 3255; Cons. St., sez. V, 24.4.2013 n. 2265; TAR Puglia, Bari, 4.6.2010 n. 2241; TRGA Trento, n. 184/2009; C.d.S., sez. IV, 28.9.1998 n. 1226; Cons. St., sez. IV, 14.2.1990 n. 78.
[179] Non mancano anche in dottrina analisi critiche. Cfr. S. Amorosino, Dalla disciplina (statica) alla regolazione (dinamica) del paesaggio , in Riv. giur. urb., 2006, 434 ss; I.M.G. Impastato, La sussidiarietà presa sul serio: il caso dei beni culturali urbanistici tra tutele parallele e sistema multipolare integrato , in Dir. soc., 2008, 393.
[180] Cons. St., sez. V, 24.4.2013 n. 2265.
[181] Cons. St., sez. IV, 22.8.2018 n. 5029.
[182] Cfr. M. Cammelli, Regionalismo differenziato e patrimonio culturale: quello che resta , in Aedon, 2019, 1 ss; M. Cammelli, Regione Toscana – Ipotesi di autonomia speciale per i beni culturali ex art. 116, comma 3, Cost. – Relazione e articolato , in Aedon, 2003, 1 ss.
[183] Così A. Sau, Le politiche di governo del territorio nel quadro dell’autonomia differenziata , in Le Regioni, 2023, 967.
[184] M. Dugato, Gli strumenti territoriali come strumenti di programmazione economica , in Ist. Fed., 2009, 261.
[185] M. Cammelli, Flessibilità, autonomia, decentramento amministrativo: il regionalismo oltre l’art. 116.3 Cost ., in Astrid, 2019, 1 ss.; M. Cammelli, Amministrare senza amministrazione , in Il Mulino, 2016, 578 ss.
[186] Sul rapporto tra rigenerazione urbana e patrimonio culturale cfr. G. Piperata, Rigenerazione urbana e patrimonio culturale nell’esperienza amministrativa italiana di ripresa e resilienza , in Aedon, 2024, 7 ss.
[187] A. Sau, Le politiche di governo del territorio nel quadro dell’autonomia differenziata , cit., 972.
[188] Cfr. S. Valaguzza, Il diritto delle città e il dibattito sull’autonomia differenziata , in www.federalismi.it, 2019, 1 ss.; G. Piperata, Riflessioni di un giurista sul futuro dell’urbanistica , in G. Corso, M. Immordino (a cura di), Studi in onore di Filippo Slavia , Napoli, 2022, 539 ss.
[189] A. Sau, Le politiche di governo del territorio nel quadro dell’autonomia differenziata , cit., 988.
[190] Cfr. R. Pinardi, L’horror vacui nel giudizio sulle leggi, Milano, 2007; C. Colapietro, Le sentenze additive e sostitutive della Corte costituzionale , Pisa, 1991.
[191] Cfr. sulla problematica, in relazione ai regolamenti, M. Massa, Regolamenti amministrativi e processo. I due volti dei regolamenti e i loro riflessi nei giudizi costituzionali e amministrativi , Napoli, 2011, 375 ss.
[192] P. Carpentieri, Tutela e valorizzazione dei beni culturali, in Urb. app., 2003, 1023.
[193] Cfr. M. Gorlani, Il nucleo intangibile dell’autonomia dei Comuni, in www.forumcostituzionale.it , 2020, 121.
[194] Di cui parla efficacemente P. Chirulli, Il governo multilivello del patrimonio culturale , cit., 699.
[195] Corte cost. n. 921/1988.
[196] Ad. Pl. n. 5/2023 (il caso del ristorante “Il vero Alfredo”) secondo cui “ Dai sopra riportati principi, si ricava, dunque, che la tutela del bene culturale non può che estendersi anche al suo uso, ogni qualvolta anche quest'ultimo contribuisca alla sua rilevanza culturale.
3.4. Infine, tale interpretazione è coerente con il complessivo sistema normativo di tutela dell'interesse culturale, basato non soltanto sull'azione delle autorità statali ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, ma anche sull'esercizio di distinti poteri pubblici, ascrivibili pure ad Amministrazioni non statali.
La Sezione remittente ha correttamente richiamato il potere di pianificazione territoriale, il cui esercizio ben può tenere conto delle esigenze legate alla tutela di interessi costituzionalmente primari, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del territorio su cui detto potere è esercitato (C.d.S., Sez. II, 29 ottobre 2020, n. 6628). In tale contesto, si inquadra quell'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato che ha ammesso l'esercizio del potere di pianificazione territoriale anche in funzione dell'imposizione di vincoli di destinazione d'uso, motivati dal riferimento al carattere storico-identitario che talune attività possano rivestire in determinati luoghi per la collettività locale: in tali ipotesi, è ben possibile che un bene, pur privo in sé di valenza culturale, rivesta una oggettiva centralità identitaria per una città e sia considerato dagli abitanti (e dagli organi elettivi comunali) come elemento idoneo a rappresentarne il passato ed a rammentarlo (C.d.S., Sez. IV, 22 agosto 2018, n. 5029, per un vincolo di destinazione a "caffè-bar"). Sarebbe dunque irragionevole negare un'analoga possibilità all'Amministrazione istituzionalmente competente a tutelare i beni culturali, non consentendole di apprestare adeguata tutela a quelle attività - di qualsiasi natura - che nella storia sono divenute coessenziali con quella stratificazione del costruito, rappresentandone in una certa misura la stessa ragione d'essere ”. Cfr. G. Morbidelli, Della progressiva estensione della componente immateriale nei beni culturali e dei suoi limiti , in Aedon, 2023, 1 ss.; P. Marzaro, Vincolo culturale di destinazione d’uso: il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni della p.a. e il rischio dell’effetto paradosso , in Aedon, 2023.
[197] Il richiamo è criticato da G. Morbidelli, Della progressiva estensione della componente immateriale nei beni culturali e dei suoi limiti , in Aedon, 2023, 1, posto che “non si ritiene condivisibile l’affermazione secondo cui già in sede di pianificazione territoriale sarebbe ammessa l'imposizione di vincoli di destinazione d'uso, motivati dal riferimento al carattere storico-identitario che talune attività possano rivestire in determinati luoghi per la collettività locale: in tali ipotesi la giurisprudenza del Consiglio di Stato ritiene invece illegittima l’imposizione di vincoli d’uso tarati sui singoli immobili. Pur confermando il potere del comune di operare micronizzazioni e dettare discipline di dettaglio nell'ambito di una zona omogenea più estesa, si ritiene infatti illegittimo modellare questo strumento al fine sviato di imporre vincoli su singoli immobili, in stretta attinenza con la loro attuale destinazione: v. Cons. Stato, Sez. IV, 12 giugno 2013, n. 3255 ma v. anche Sez. VI, 29 febbraio 2016, n. 844. La Plenaria richiama per corroborare la propria tesi, Cons. Stato, Sez. IV, 22 agosto 2018, n. 5029, relativa ad un vincolo di destinazione a “caffè-bar” posto in sede di strumento urbanistico: ma in realtà nel caso, che riguardava il Caffè Grande di Campo Sanpiero, non risulta che sia stata sollevata la questione della microzonizzazione ristretta a singoli immobili”.